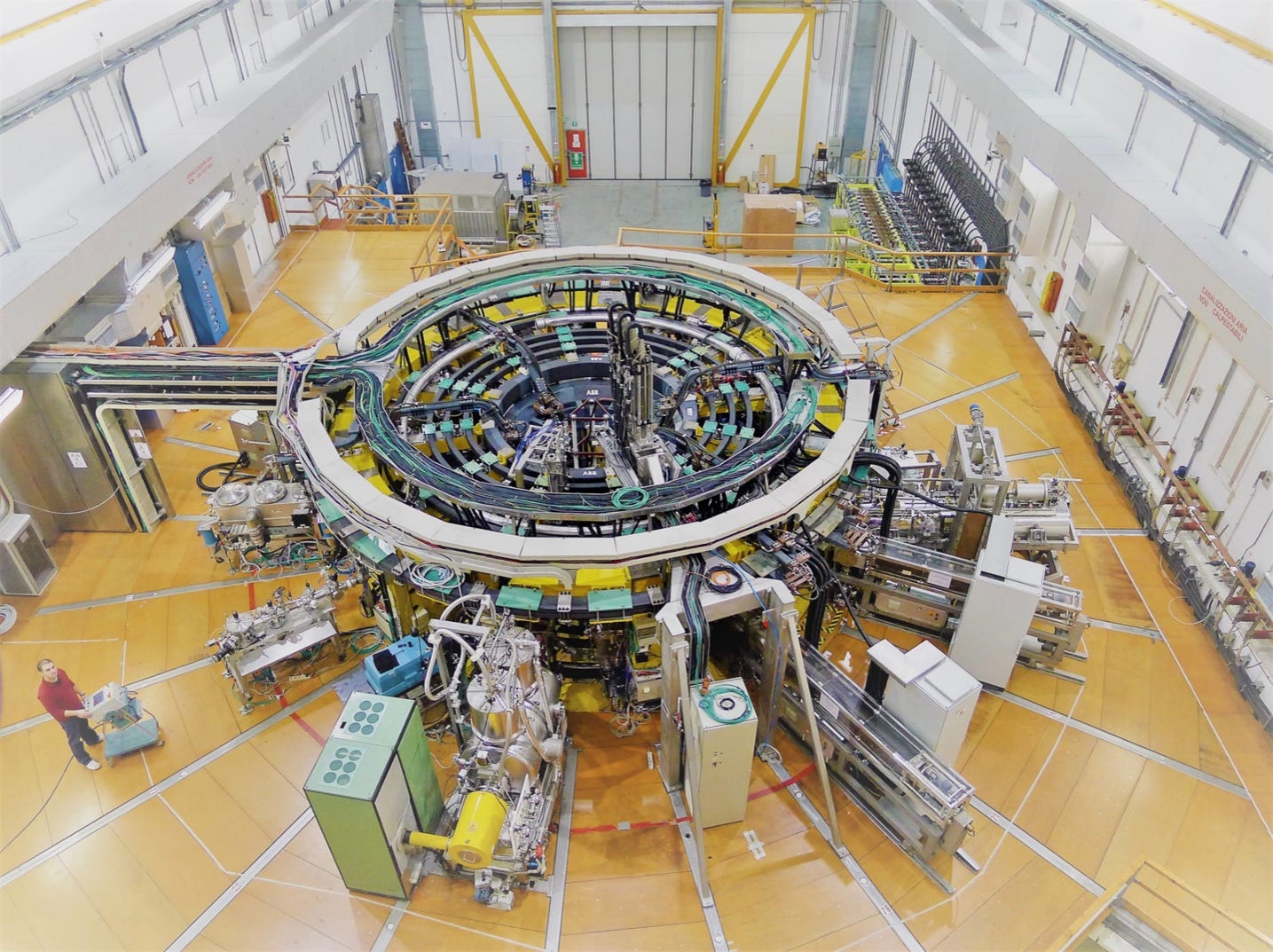Brevetti e proprietà intellettuale nella Terza Missione dell’università italiana
Nel sistema universitario italiano, la Terza Missione affianca le missioni tradizionali di didattica e ricerca, puntando alla valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze verso la società e il tessuto produttivo. Sebbene la Legge 240/2010 non menzioni espressamente il termine “terza missione”, essa ha di fatto istituzionalizzato questo mandato attribuendo ai Dipartimenti la responsabilità anche delle attività di trasferimento di conoscenze. Ciò è stato reso operativo dal D.Lgs. 19/2012, che ha integrato la terza missione nel sistema nazionale di valutazione della qualità universitaria. In particolare, l’introduzione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento) dal 2013 in poi ha formalizzato la rilevanza istituzionale della terza missione, includendo tra gli indicatori di performance anche i risultati di trasferimento tecnologico e interazione con il territorio. In questo contesto, la protezione della conoscenza tramite brevetti e, più in generale, la gestione della proprietà intellettuale (PI) emergono come elementi chiave attraverso cui l’università trasforma i risultati della ricerca in benefici socio-economici tangibili.
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha sistematizzato le attività di terza missione in specifiche categorie, in particolare distinguendo un ampio dominio dedicato alla valorizzazione economica della conoscenza. All’interno di tale dominio rientrano quattro ambiti omogenei:
Gestione della proprietà intellettuale – attività di tutela e sfruttamento dei risultati inventivi della ricerca, in primis il deposito di brevetti per invenzioni (e modelli di utilità), nonché la registrazione di altri titoli di PI previsti dall’ordinamento.
Imprenditorialità accademica – iniziative di creazione di imprese spin-off o start-up basate su risultati della ricerca universitaria.
Ricerca conto terzi e convenzioni – contratti di ricerca, consulenza e collaborazioni con partner esterni finalizzati all’applicazione del know-how accademico.
Strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico – unità organizzative come uffici di trasferimento tecnologico (TTO/ILO), incubatori universitari, consorzi e parchi scientifici, deputati a facilitare le interazioni tra ateneo e attori esterni.
Tra queste, la gestione della proprietà intellettuale – e in particolare la brevettazione – rappresenta il primo passo per proteggere legalmente le conoscenze generate e porre le basi per il loro sfruttamento commerciale tramite licenze o accordi con imprese. Nel prosieguo dell’articolo si analizzerà questo tema in dettaglio, ricostruendo il quadro procedurale per la tutela brevettuale dei risultati della ricerca e le modalità con cui gli atenei italiani gestiscono e trasferiscono i diritti di PI al fine di generare impatto socio-economico.
Il processo di protezione della conoscenza mediante brevetti
Brevettare un’invenzione accademica significa ottenere un titolo giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’invenzione, impedendo ad altri di utilizzarla senza autorizzazione. Nel contesto universitario italiano, il percorso dalla ricerca al brevetto coinvolge tipicamente diverse fasi e attori. Anzitutto, quando un gruppo di ricerca ottiene un risultato scientifico potenzialmente innovativo e applicabile industrialmente, viene effettuata una valutazione preliminare della brevettabilità: si esamina la novità dell’invenzione, il suo livello inventivo e le possibili applicazioni sul mercato. Questa valutazione avviene spesso in collaborazione con gli uffici di trasferimento tecnologico (TTO) dell’ateneo, oppure con commissioni brevettuali interne, che assistono i ricercatori nell’analisi tecnica e nel verificare l’assenza di anteriorità rilevanti nei database brevettuali. Tali strutture specializzate svolgono un ruolo di supporto cruciale, aiutando i ricercatori a individuare opportunità di tutela, a gestire gli aspetti legali e a orientarsi nelle procedure di brevettazione. L’obiettivo è di tutelare formalmente l’invenzione depositando una domanda di brevetto quanto prima, idealmente prima che i risultati vengano divulgati in pubblicazioni scientifiche o convegni (circostanza che ne pregiudicherebbe la novità brevettuale).
Dal punto di vista procedurale, il deposito può avvenire presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) – spesso come primo passo per ottenere una priorità nazionale – oppure direttamente tramite organismi internazionali quali l’European Patent Office (EPO) o l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), a seconda della strategia di tutela e dei mercati di interesse. È prassi frequente depositare inizialmente in Italia (ottenendo una data di priorità) e poi, entro 12 mesi, estendere la domanda in ambito europeo o internazionale (ad esempio tramite trattato PCT) per coprire altri Paesi. Le università italiane generalmente sostengono questo iter fornendo supporto amministrativo e legale: il TTO coordina la stesura della domanda (spesso affidata a consulenti in proprietà industriale), cura i rapporti con l’ufficio brevetti e monitora l’iter di esame fino alla concessione. È importante sottolineare che nell’ordinamento italiano i professori e ricercatori universitari godono di un regime peculiare (noto come privativa del ricercatore ai sensi dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale) per cui, salvo diverso accordo, i diritti sull’invenzione spettano all’inventore. Tuttavia, molti atenei adottano politiche interne per incentivare i propri ricercatori a cedere il brevetto all’università (in cambio della copertura dei costi di deposito e di una quota sui futuri utili), così da permettere all’istituzione accademica di gestire direttamente la proprietà intellettuale e valorizzarla in modo più sistematico. In ogni caso, che il brevetto sia intestato all’ateneo (titolarità istituzionale) o al singolo inventore, l’obiettivo finale rimane la protezione dell’invenzione e la creazione di un asset intangibile di valore che possa essere trasferito al sistema economico.
Un aspetto tecnico da rilevare è che, ai fini delle rilevazioni ministeriali e valutative, vengono generalmente conteggiati i brevetti di invenzione industriale depositati presso uffici che emettono un rapporto di ricerca sull’anteriorità (requisito che garantisce una qualificazione dell’invenzione). In pratica, l’ANVUR considera solo le domande di brevetto depositate presso UIBM, EPO, USPTO o tramite procedura PCT che siano state pubblicate ed esaminate. Inoltre, per evitare doppie conteggiature, l’unità di misura impiegata è spesso la famiglia brevettuale, definita come l’insieme di tutte le domande di brevetto (nazionali e internazionali) derivanti dalla stessa invenzione. Ad esempio, un brevetto depositato in Italia e poi esteso in Europa e negli USA viene contato come una singola “famiglia” anziché come tre brevetti distinti. Ciò consente di misurare in modo più accurato il numero di invenzioni uniche generate dalla ricerca accademica e oggetto di tutela brevettuale.
Gestione accademica della proprietà intellettuale
Una volta depositato e (auspicabilmente) concesso il brevetto, l’università deve occuparsi della gestione strategica della proprietà intellettuale risultante. Questo implica anzitutto amministrare il portafoglio brevetti dell’ateneo, ovvero l’insieme di titoli brevettuali di cui l’istituzione è titolare o co-titolare, o che comunque derivano dall’attività inventiva dei suoi ricercatori. Gli uffici preposti monitorano lo stato legale di ciascun brevetto (pagamento delle annualità per mantenerlo in vita, avanzamento delle fasi nazionali estere, etc.) e valutano periodicamente l’opportunità di proseguire la tutela. Va infatti considerato che brevettare e mantenere un brevetto è oneroso: le decisioni di mantenimento, abbandono o estensione di un brevetto dipendono dal potenziale valore commerciale percepito e dall’interesse manifestato dal mercato. Le università, nel loro ruolo pubblico, tendono a brevettare principalmente con lo scopo di trasferire le tecnologie all’industria più che per sfruttarle direttamente; pertanto, la gestione della PI è orientata a massimizzare le chance di utilizzo esterno delle invenzioni.
Un elemento caratteristico del panorama italiano è la frequente co-titolarità dei brevetti universitari con altri enti di ricerca o partner industriali. Molte invenzioni nascono infatti da collaborazioni scientifiche (consorzi inter-universitari, progetti con CNR, ENEA, aziende, ecc.), riflettendosi in brevetti condivisi. Durante la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), ad esempio, ANVUR rilevò che circa il 31% dei brevetti in portafoglio alle università italiane vedeva una co-titolarità con altri soggetti. In particolare, il 48% di questi casi coinvolgeva altri enti pubblici di ricerca o atenei, e un ulteriore 38% vedeva co-inventori partner privati (aziende). La co-titolarità richiede accordi chiari sulla gestione condivisa dei diritti (chi si occupa dei costi di mantenimento, come si ripartiscono eventuali proventi, ecc.) ed è parte integrante delle politiche di gestione della PI. Gli atenei spesso stipulano accordi di sfruttamento congiunto o regolamenti di Ateneo che disciplinano questi aspetti, al fine di evitare conflitti e assicurare che il brevetto venga valorizzato al meglio degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Dal punto di vista organizzativo, presso quasi tutte le università italiane operano uffici o unità per la valorizzazione della ricerca (spesso denominati Technology Transfer Office, Industrial Liaison Office o simili) incaricati di presidiare l’intero ciclo di vita della proprietà intellettuale. Questi uffici curano non solo la fase di deposito brevettuale già descritta, ma anche le attività successive di marketing tecnologico, ricerca di partner industriali, negoziazione di contratti di licenza o cessione, supporto alla creazione di nuove imprese, e monitoraggio dei risultati. È fondamentale che tali strutture agiscano come facilitatori e non come meri organi burocratici: il Manuale ANVUR 2015 sul tema sottolinea che il rapporto tra ricercatori e uffici di trasferimento tecnologico deve essere dialettico e collaborativo, con l’obiettivo di rendere efficaci e fluide le relazioni con l’esterno e moltiplicare le opportunità di valorizzazione. In altre parole, l’ufficio di PI si configura come un service interno all’ateneo, dotato di personale specializzato (tecnici brevettuali, legali, manager del trasferimento tecnologico) che mette a disposizione competenze difficilmente riscontrabili tra i singoli ricercatori. Il buon funzionamento di queste strutture è oggi oggetto di valutazione qualitativa da parte di ANVUR nell’ambito dell’accreditamento periodico: la presenza di efficaci uffici di trasferimento tecnologico, di incubatori e in generale di un ecosistema di supporto alla terza missione viene interpretata come indice dell’impegno strategico dell’ateneo nel generare impatto.
Trasferimento, licenze e impatto socio-economico
Depositare un brevetto è un mezzo, non un fine: il vero successo di un’invenzione accademica si misura dalla sua effettiva trasformazione in innovazione, ossia dalla capacità di tradurre quel brevetto in nuovi prodotti, processi o servizi utilizzati nella società. Per raggiungere questo obiettivo, le università impiegano due strumenti principali: il licenziamento della proprietà intellettuale a imprese esistenti e la creazione di imprese spin-off quando non esiste un immediato sbocco industriale. Entrambe le modalità rientrano a pieno titolo nella terza missione, in quanto convertono conoscenza in valore economico e sviluppo.
La concessione in licenza di un brevetto consiste nel trasferire a un soggetto esterno (tipicamente un’azienda) il diritto di utilizzare, produrre o commercializzare l’invenzione protetta, a fronte di condizioni contrattuali definite. Tali condizioni prevedono in genere un compenso economico per l’università, che può assumere la forma di royalties (percentuali sui ricavi derivati dal prodotto brevettato), fee una tantum, o altre forme di remunerazione (ad esempio equity se la licenza è concessa a una start-up partecipata). La licenza mantiene la titolarità del brevetto in capo all’università (o ente proprietario), ma ne permette l’uso esclusivo al licenziatario per specifici campi applicativi e territori, evitando la frammentazione dei diritti. Attraverso le licenze, l’ateneo realizza un duplice scopo: da un lato, assolve alla propria funzione pubblica di trasferire tecnologia al sistema produttivo, contribuendo al progresso tecnico e alla competitività delle imprese; dall’altro, genera introiti economici che possono essere reinvestiti in attività di ricerca o in nuovi progetti di terza missione. Proprio gli introiti da brevetti sono monitorati come segnale dell’efficacia del trasferimento: a fini valutativi, ANVUR considera non solo il numero di brevetti concessi, ma anche gli eventuali proventi ottenuti dalla loro vendita o licenza, in quanto indicatori della capacità di tradurre la ricerca scientifica in asset intangibili di valore per il mercato. Un portafoglio brevetti inutilizzato, infatti, pur rappresentando una riserva di conoscenza, non produce impatto se non trova applicazione pratica; viceversa, anche un numero limitato di brevetti ma ben trasferiti può generare ricadute significative in termini di nuovi prodotti (si pensi a brevetti farmaceutici o biotecnologici che sfociano in terapie), posti di lavoro e crescita economica.
Parallelamente alle licenze, un altro strumento di sfruttamento della PI universitaria è la promozione di spin-off accademici. Uno spin-off è una nuova impresa (startup innovativa) fondata da ricercatori, spesso con la partecipazione dell’ateneo, avente l’obiettivo di sviluppare commercialmente risultati della ricerca. Spesso l’università concede allo spin-off l’uso di uno o più brevetti (mediante licenza o con cessione parziale di proprietà in cambio di equity nella società), in modo che la nuova impresa possa basare il proprio vantaggio competitivo su tali innovazioni protette. Questo modello imprenditoriale è particolarmente efficace in settori ad alta tecnologia o emergenti, dove può non esistere un’industria consolidata pronta ad assorbire immediatamente l’invenzione: creando un’impresa ad hoc, si dà all’invenzione il veicolo per arrivare sul mercato. L’ANVUR riconosce l’importanza degli spin-off come complemento alla brevettazione, monitorandone il numero e la vitalità nel tempo. La presenza di numerose startup accademiche attive indica un ecosistema dinamico e la propensione di un ateneo a tradurre conoscenza in iniziative imprenditoriali, contribuendo direttamente allo sviluppo economico locale attraverso la creazione di occupazione qualificata e l’attrazione di investimenti.
Strumenti di rilevazione e valutazione
Il crescente rilievo dei brevetti e della PI nella terza missione si riflette nei meccanismi di valutazione e monitoraggio adottati a livello nazionale. A partire dal 2015, tutte le università sono tenute a censire annualmente le proprie iniziative di terza missione tramite la Scheda Unica Annuale della Terza Missione/Impatto Sociale (SUA-TM/IS), una piattaforma informatizzata gestita dal consorzio CINECA. In questa scheda confluiscono dati standardizzati su brevetti depositati e concessi, su accordi di licenza attivi, su nuove imprese spin-off riconosciute, su contratti di ricerca conto terzi, e su molte altre attività terza-missionali. L’obbligatorietà della rilevazione (pena l’esclusione dalle valutazioni) ha consentito negli ultimi anni di disporre di basi informative consistenti e omogenee a livello nazionale, superando la frammentazione precedente. Sulla base di queste informazioni, l’ANVUR e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) possono attuare valutazioni comparative e definire indicatori di performance.
In effetti, già nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014), l’ANVUR aveva sperimentato un approccio di valutazione combinato: da un lato la raccolta di indicatori quantitativi (come il numero di brevetti e spin-off per docente) e dall’altro l’analisi qualitativa di casi di successo di terza missione. Il Manuale ANVUR 2015 formalizzava questa metodologia mista, in cui la peer review esperta dei casi studio si affiancava agli indicatori, al fine di cogliere non solo il quanto ma anche il come e il perché le attività di terza missione producono impatto. Per esempio, un caso studio potrebbe descrivere nel dettaglio il percorso di un brevetto dall’invenzione alla sua applicazione industriale, evidenziando la dimensione del suo impatto economico o sociale (fatturato generato, miglioramento di processi produttivi, benefici per la salute pubblica, ecc.), mentre gli indicatori numerici forniscono un quadro generale della propensione dell’ateneo a brevettare e a interagire con il tessuto produttivo.
Dal punto di vista delle politiche pubbliche, l’importanza attribuita a brevetti e trasferimento tecnologico è confermata dall’inclusione di specifici parametri nei criteri di finanziamento e programmazione del sistema universitario. Ad esempio, nelle Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021–2023 emanate dal MUR, tra gli indicatori di risultato figurano sia il numero di spin-off attivati che la proporzione di brevetti registrati (nazionali ed europei) rispetto al numero di docenti di ruolo. Tali indicatori quantitativi contribuiscono, con un certo peso percentuale, alla valutazione delle performance degli atenei e alla distribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario. In particolare, l’indicatore “brevetti per docente” riflette l’enfasi nel considerare la produttività brevettuale come un segnale di capacità innovativa dell’ateneo. Parallelamente, nei processi di accreditamento periodico della qualità (AVA) è previsto che le commissioni di valutazione verifichino la presenza di strategie e risultati anche in terza missione: il recente DM 1154/2021 (che ha aggiornato il modello AVA) richiede agli atenei di dimostrare di possedere un sistema adeguato per la pianificazione e gestione delle conoscenze prodotte, finalizzato anche alle attività di terza missione e impatto sociale. Inoltre, con l’evoluzione al modello AVA3, tale verifica si estende ai Dipartimenti, chiamati a pianificare obiettivi e monitorare i risultati di ricerca e terza missione in coerenza con la strategia di ateneo. In sintesi, brevetti e proprietà intellettuale sono divenuti parametri espliciti con cui viene misurata l’efficacia dell’azione accademica oltre i confini universitari: il loro peso nei sistemi di valutazione e finanziamento segnala la volontà pubblica di incentivare le università a fungere da motore di innovazione.
Conclusioni
Il percorso analizzato evidenzia come, nell’ambito della terza missione dell’università italiana, la protezione della conoscenza tramite brevetti non sia un esercizio accademico fine a sé stesso, bensì uno strumento strategico di connessione tra ricerca e società. Attraverso un processo procedurale ben definito – dall’individuazione delle invenzioni alla tutela brevettuale formale – gli atenei pongono le basi per trasferire know-how al sistema produttivo, garantendo al contempo riconoscimento e vantaggio competitivo alle scoperte dei propri ricercatori. La successiva gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, attuata tramite strutture dedicate (TTO, incubatori) e politiche di ateneo, mira a tradurre questi titoli di PI in risultati concreti: accordi di licenza che alimentano innovazione nelle imprese esistenti, oppure nuove iniziative imprenditoriali (spin-off) che portano sul mercato tecnologie rivoluzionarie. Il fil rouge è la creazione di impatto socio-economico: brevetti e licenze divengono metriche attraverso cui l’università dimostra la propria utilità pubblica nel favorire lo sviluppo economico, la competitività tecnologica del Paese e il benessere della collettività. Le politiche nazionali degli ultimi anni – dalle linee di finanziamento premiale alle procedure di valutazione periodica – hanno consolidato questo orientamento, spingendo le istituzioni accademiche a integrare stabilmente la tutela brevettuale e il trasferimento tecnologico nella propria missione. Ne risulta un ecosistema nel quale la conoscenza generata nei laboratori accademici trova tutela giuridica e percorsi di diffusione verso l’esterno, in linea con gli obiettivi di innovazione e crescita perseguiti dalle politiche pubbliche per l’università e la ricerca.
Fonti: Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR (normativa di riferimento: L.240/2010, D.Lgs.19/2012, DM 47/2013, DM 987/2016, DM 1110/2019, DM 1154/2021), Agenzia ANVUR (documentazione su terza missione, Manuale 2015, linee guida SUA-TM/IS), Consorzio CINECA (SUA-TM), dati e rapporti ufficiali citati.