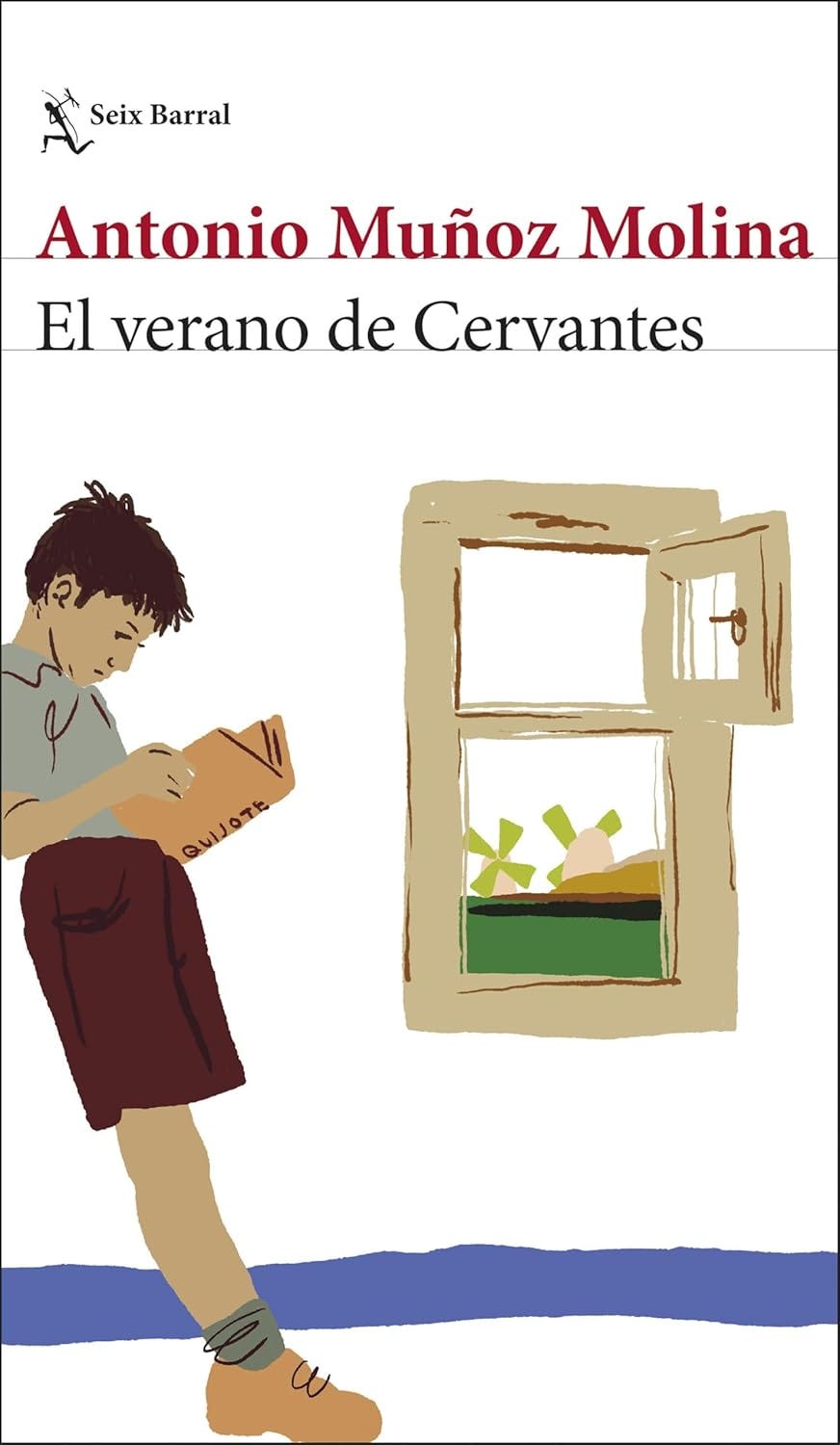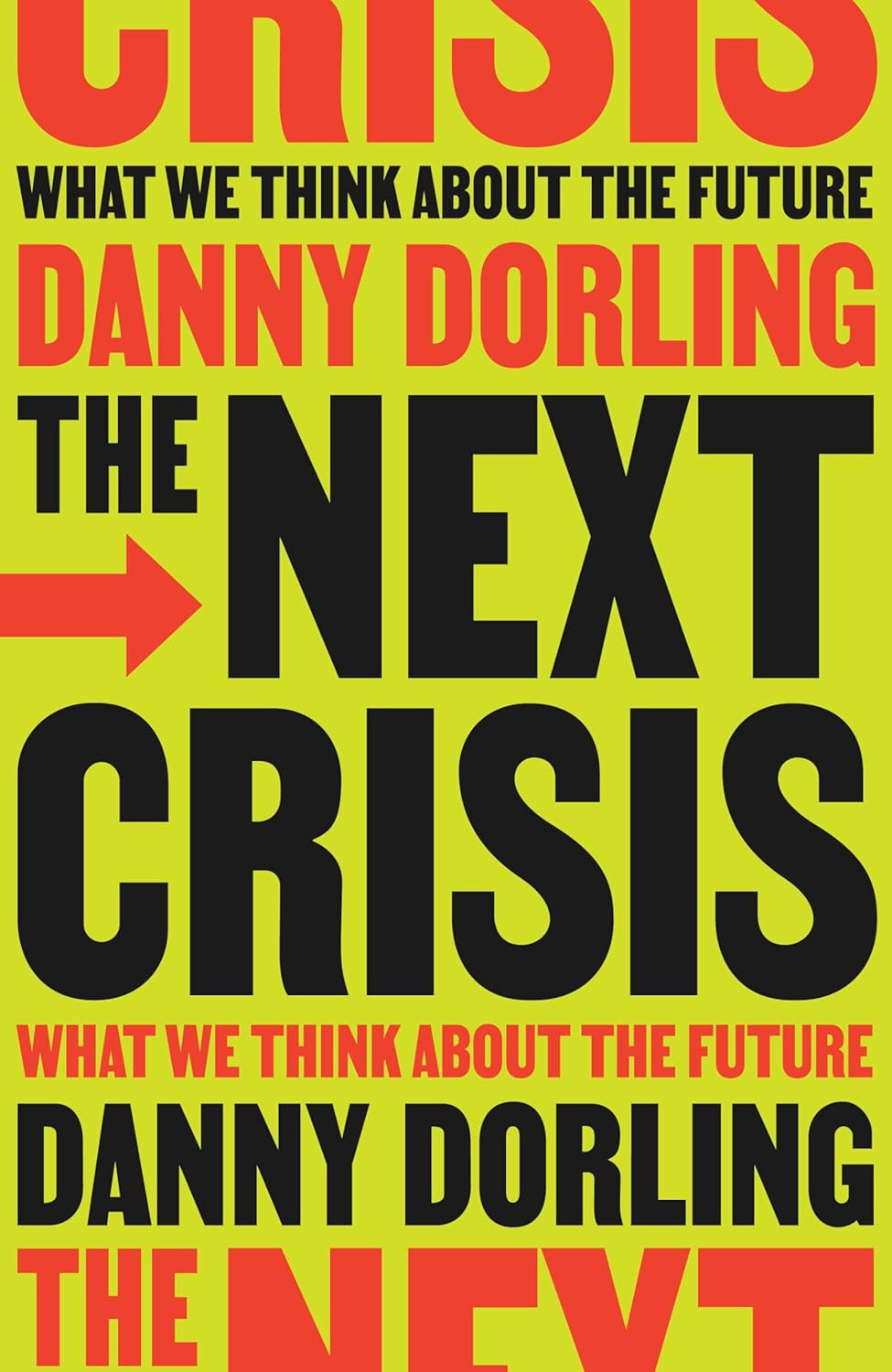Chi comanda l’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale è ormai un’infrastruttura cognitiva globale che investe trasversalmente settori cruciali come sanità, istruzione, finanza, difesa e comunicazioni. Non si tratta più solo di tool specialistici, ma di nuovi strumenti di potere: il controllo sui modelli, sui dati e sull’hardware computazionale rappresenta oggi una leva determinante nella definizione degli equilibri futuri dell’economia cognitiva. La crescente digitalizzazione ridefinisce infatti gli equilibri geo-strategici globali e ha generato un ecosistema centralizzato, dominato da poche grandi imprese – soprattutto statunitensi e cinesi – capaci di esercitare un’influenza senza precedenti. Questa concentrazione di risorse crea nuovi vincoli di autonomia: da un lato solleva questioni economiche e politiche, dall’altro rischia di generare dipendenze tecnologiche e di esclusione. A fronte di questo impatto crescente, infatti, l’ecosistema dell’IA appare fortemente concentrato: un numero ristretto di attori, prevalentemente privati e localizzati tra Stati Uniti e Cina, controlla la produzione, l’addestramento e la distribuzione dei modelli più avanzati. Questa concentrazione solleva interrogativi di natura economica e politica. Quali sono le conseguenze per i Paesi che non hanno accesso alle infrastrutture necessarie? Come si ridefiniscono le dipendenze industriali e tecnologiche in un mondo in cui pochi soggetti controllano la conoscenza computazionale? In quale misura l’asimmetria nella disponibilità di modelli, dati e potenza di calcolo genera nuove forme di subalternità o esclusione sistemica?
Terza Missione
Un filo rosso tra premio nobel, proteine e AI" con Marta Corno e Bartolomeo Civalleri
In questa nuova puntata della serie Molecole in Scatola, promossa dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, dal titolo Un filo rosso tra premio Nobel, proteine e AI, Marta Corno e Bartolomeo Civalleri esplorano il legame sempre più stretto tra intelligenza artificiale e ricerca scientifica, e mostrano come le tecnologie digitali stiano trasformando il modo di studiare le molecole. La riflessione si apre con il Premio Nobel per la Chimica 2024, assegnato per aver reso possibile una comprensione più profonda della struttura delle proteine grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. È un punto di partenza per ragionare su come gli strumenti digitali stiano cambiando il modo di fare ricerca, permettendo di esplorare strutture complesse attraverso modelli e simulazioni.
Punti cardinali
"El verano de Cervantes" di Antonio Muñoz Molina
El verano de Cervantes è un testo di riflessione letteraria e autobiografica scritto da Antonio Muñoz Molina. Il libro prende forma come una lunga meditazione estiva durante la rilettura del Don Chisciotte, combinando osservazioni sul capolavoro cervantino con memorie personali dell’autore, considerazioni storiche, e un’indagine sui rapporti fra letteratura, tempo e identità. La struttura non è lineare né saggistica in senso stretto: si sviluppa per giustapposizione, secondo un flusso di pensiero che intreccia piani temporali, impressioni sensoriali e riferimenti culturali. Il testo alterna passaggi descrittivi a riflessioni critiche, sovrapponendo piani esperienziali e narrativi. Il progetto che lo sostiene non è ricostruttivo o sistematico, ma immersivo e interrogativo: leggere Cervantes per abitare il tempo, per riconoscere sé stessi, per interrogare la funzione e i limiti della finzione letteraria. Il tono è insieme dimesso e scrupoloso, con frequenti allusioni intertestuali e riferimenti alla tradizione europea.
"The Next Crisis. What We Think About the Future" di Danny Dorling.
Il volume The Next Crisis di Danny Dorling, pubblicato nel 2025 da Verso, si propone di analizzare le crisi attuali e potenziali che caratterizzano il mondo contemporaneo, interrogandosi su quali siano percepite come più gravi e quali potrebbero emergere in futuro. L’autore, geografo umano con lunga esperienza nello studio delle disuguaglianze, struttura il libro in sette capitoli tematici, ciascuno dedicato a una categoria di crisi: costo della vita, lavoro, guerra e casa, sanità e servizi sociali, crisi climatica, perdita di biodiversità. Ogni capitolo presenta dati, analisi e riflessioni sull’evoluzione di queste problematiche, per poi concludere con una discussione sul potenziale prossimo scenario critico. Il testo è supportato da figure, grafici e fonti istituzionali, ma è costruito anche su osservazioni personali e considerazioni di carattere sistemico. Il taglio è divulgativo ma rigoroso, con l’obiettivo di stimolare un ripensamento delle priorità collettive e individuali, evitando visioni apocalittiche o salvifiche, e adottando invece un approccio analitico e comparativo alle rappresentazioni del futuro.