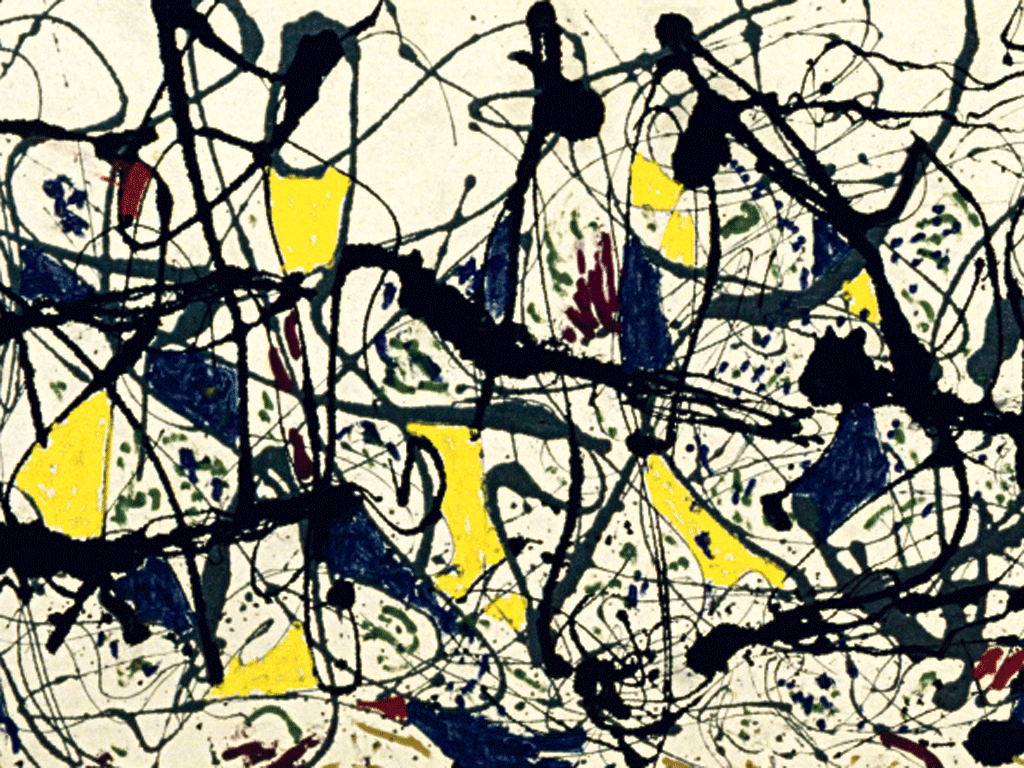Il mosaico della sicurezza europea: accordi di cooperazione in ambito Difesa extra NATO
Negli ultimi anni, il panorama della sicurezza europea si è ristrutturato attraverso un processo di intensificazione delle cooperazioni bilaterali e multilaterali tra Stati membri dell’Unione, spesso sviluppate autonomamente rispetto al quadro istituzionale della NATO. Tale processo ha subito un’accelerazione a partire dal 2014, con la crisi ucraina e l’annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, ma trova radici più profonde in una lunga evoluzione storica della politica di sicurezza europea. Se da un lato l’alleanza atlantica ha costituito per decenni il principale pilastro della sicurezza collettiva occidentale, il progressivo affermarsi dell’idea di “autonomia strategica europea” ha portato numerosi Stati a rafforzare forme di cooperazione militare diretta, finalizzate ad accrescere la propria capacità di risposta autonoma in scenari di crisi, anche al di fuori delle dinamiche transatlantiche.
Questo riassetto non ha solo rilievo operativo, ma evidenzia la permanenza e la rielaborazione di alcune linee profonde della politica estera europea. Il Regno Unito, ad esempio, pur uscito dall’Unione Europea, ha ripreso una postura coerente con la propria tradizione strategica, orientata a sostenere i paesi dell’Europa centro-orientale e a fungere da elemento di equilibrio – o di contenimento – rispetto a eventuali egemonie continentali da parte di potenze ostili. Si tratta di una continuità storica che affonda le radici nell’Ottocento e che si è ripresentata nel sostegno britannico alla Polonia, all’Ucraina e ai paesi nordici in chiave anti-russa e anti-egemonica. La politica estera del Regno Unito appare dunque coerente con una logica di proiezione flessibile e di contenimento multilivello, tipica della sua tradizione geopolitica.
Analogamente, la Francia ha rinnovato un proprio ruolo centrale come potenza continentale e mediterranea, erede di una tradizione strategica incentrata sulla ricerca dell’autonomia e sulla leadership europea in materia di difesa. Le intese bilaterali con Italia, Grecia, Belgio e ora con la Polonia confermano la volontà francese di costruire un’infrastruttura europea di sicurezza, anche in funzione di riequilibrio rispetto al ruolo statunitense e alle divisioni interne all’UE. La postura francese si richiama, sul piano storico, all’idea di una “Europa della difesa” autonoma già formulata negli anni Cinquanta e più volte riproposta nei decenni successivi, con alterne fortune.
Il processo in atto contribuisce anche a sanare fratture storiche, in alcuni casi risalenti alla Guerra Fredda o addirittura anteriori. La cooperazione militare tra Repubblica Ceca e Slovacchia, sviluppatasi dopo la fine dell’epoca post-bipolare, rappresenta oggi un esempio concreto di riconciliazione e solidarietà strategica tra due paesi separatisi pacificamente nel 1993, ma storicamente legati. Un'evoluzione simile si osserva nella cooperazione tra Paesi Bassi e Germania, un tempo avversari strutturali nello scenario continentale e oggi integrati in forme operative avanzate, così come nel graduale riallineamento tra Paesi Bassi e Regno Unito, in passato divisi da visioni divergenti sull’Europa.
Tuttavia, il quadro attuale mostra anche la persistenza di alcune linee di tensione strutturale. L’accordo bilaterale tra Francia e Grecia, che prevede clausole di mutua assistenza militare, si colloca in un contesto segnato da tensioni irrisolte tra Atene e Ankara, entrambe membri della NATO, ma storicamente in competizione per la supremazia nel Mediterraneo orientale. Il sostegno francese ad Atene, pur legittimo sul piano delle alleanze politiche, ha contribuito a riattivare dinamiche di contrapposizione che sfuggono al controllo dei meccanismi multilaterali dell’Alleanza atlantica.
Nel complesso, l’intensificarsi delle cooperazioni bilaterali e multilaterali in ambito sicurezza riflette un ritorno della storia nella politica europea: alleanze, rivalità, ambizioni e diffidenze che affondano le radici in equilibri consolidati vengono oggi rielaborati in forme nuove, all’interno di un contesto giuridico e istituzionale in trasformazione. Il risultato è un mosaico di intese sovrapposte e interconnesse che, pur frammentato, tende progressivamente a costruire una capacità autonoma europea, con una propria logica di sicurezza regionale, articolata in cerchie concentriche e sensibilità strategiche differenziate.
Andiamo nel dettaglio