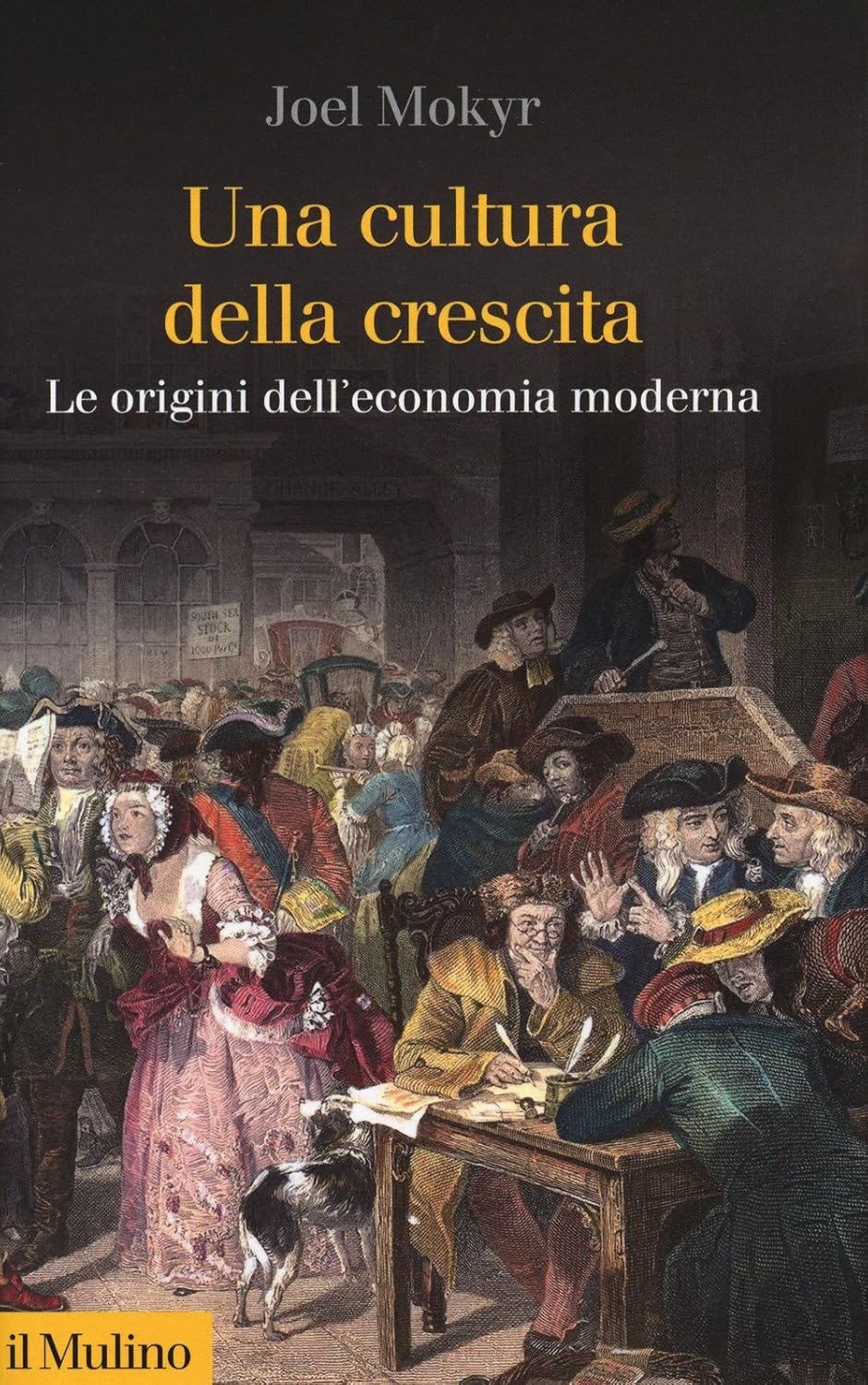Il nuovo Premio Nobel per l’Economia Joel Mokyr ospite di Stroncature nel 2021
Nel febbraio del 2021 Stroncature ha ospitato la presentazione del volume Una cultura della crescita. Le origini dell’economia moderna di Joel Mokyr, professore di economia e storia economica alla Northwestern University, oggi insignito del Premio Nobel per l’Economia. L’incontro ha visto la partecipazione di Amedeo Lepore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Luigi Mascilli Migliorini dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli e Vincenzo Pascale di Stroncature e della Long Island University. Di seguito il resoconto di quell’incontro.
Nel suo intervento, Mokyr è partito individuando il cuore del problema nella “grande domanda” della storia economica comparata: perché l’Europa, e non altre civiltà, riuscì a sviluppare una crescita economica sostenuta a partire dal XVIII secolo? Rifiutando le spiegazioni puramente materiali, come l’abbondanza di carbone o l’espansione coloniale, egli propone una chiave di lettura culturale. La rivoluzione industriale, secondo Mokyr, non fu il risultato di risorse o geografia, ma di un mutamento nei valori e nelle convinzioni circa la possibilità del progresso. L’Europa tra Seicento e Settecento elaborò una nuova visione della conoscenza: la considerò non più come contemplazione del mondo, ma come strumento per trasformarlo. Questa ridefinizione del rapporto tra sapere e miglioramento materiale diede origine a una forma di Illuminismo specifica, che egli chiama “Illuminismo industriale”, in cui la fiducia nel progresso economico divenne parte integrante della cultura dell’epoca.
L’“Illuminismo industriale” descritto da Mokyr fu un movimento intellettuale minoritario, diffuso fra le élite alfabetizzate e scientificamente istruite dell’Europa occidentale, ma con effetti sistemici sull’economia e sulla società. Esso si fondava su tre assunti principali: il progresso economico è possibile, è desiderabile e dipende dall’applicazione della conoscenza utile ai problemi pratici. Non si trattava di un’ideologia astratta, ma di un orientamento collettivo a considerare la scienza e la tecnica come strumenti di miglioramento delle condizioni di vita. In questo senso, la cultura dell’epoca elaborò una nuova relazione fra teoria e pratica, scardinando la separazione tra chi conosce e chi fa. La conoscenza divenne un mezzo per generare innovazione, e l’innovazione, a sua volta, un valore condiviso. Mokyr ha sottolineato come questo cambiamento fosse radicale: per la prima volta nella storia, l’accumulazione di conoscenza fu considerata il motore della prosperità.
Al centro di questo mutamento Mokyr colloca il “programma baconiano”, ossia il progetto culturale proposto da Francis Bacon per subordinare la ricerca scientifica al miglioramento della vita umana e alla prosperità dello Stato. Bacon non eseguì esperimenti, ma delineò un metodo: la conoscenza doveva essere “utile”, orientata all’azione e condivisa tra studiosi e artigiani, filosofi naturali e inventori. Mokyr interpreta questa impostazione come l’inizio di una nuova infrastruttura cognitiva, che permise di costruire ponti tra le diverse sfere del sapere. L’obiettivo era creare canali di comunicazione stabili fra coloro che “sapevano” e coloro che “facevano”, in modo che le scoperte potessero tradursi in innovazioni concrete. Tale programma, diffuso attraverso l’Europa, costituì la base di una nuova cultura della cooperazione intellettuale, dove lo Stato, le accademie e le reti di scienziati si riconoscevano in una missione comune di progresso materiale.
Per descrivere come questa cultura abbia prodotto risultati tangibili, Mokyr introduce la nozione di “mercato delle idee”. Pur trattandosi di una metafora, egli ne analizza i meccanismi con gli strumenti dell’economia: la conoscenza si diffonde attraverso scambi di tipo reputazionale, e gli studiosi agiscono mossi da incentivi non monetari ma simbolici. La validità di un’idea viene “acquistata” dal consenso dei pari, e chi la propone ottiene un guadagno in termini di prestigio. Il mercato delle idee è dunque un sistema competitivo in cui le barriere all’ingresso, i costi di transazione e i tabù funzionano come variabili economiche. L’efficienza di questo mercato dipende dalle istituzioni che lo sostengono, e l’Europa, secondo Mokyr, riuscì a sviluppare regole che ne aumentarono la produttività. Laddove altri contesti reprimevano la novità, l’Europa incentivava l’innovazione, trasformando la cultura in un motore economico.
L’istituzione che più di ogni altra rese possibile questo mercato cognitivo fu, per Mokyr, la Repubblica delle Lettere. Essa non fu un organismo politico, ma una rete autonoma di scienziati, filosofi e studiosi uniti da regole informali e condivise. Tra queste, la circolazione aperta del sapere, la priorità come forma di proprietà simbolica, la contestabilità universale delle teorie, l’eguaglianza formale fra i partecipanti e il superamento dei confini religiosi e nazionali. Grazie alla stampa e al miglioramento dei servizi postali, la Repubblica delle Lettere costituì la prima comunità intellettuale virtuale della storia europea. Essa unificò un continente politicamente frammentato, trasformando la diversità politica in un vantaggio: ogni tentativo di censura in un paese trovava una via di fuga in un altro. Questa dinamica rese inefficaci i meccanismi di repressione e consolidò l’idea che il sapere dovesse essere pubblico e verificabile.
Nell’ultima parte della sua esposizione Mokyr ha distinto fra incentivi negativi e positivi alla produzione intellettuale. Tra i primi annovera la censura, le persecuzioni religiose e la resistenza accademica alle innovazioni; tra i secondi, la reputazione, il riconoscimento e il mecenatismo. Con il tempo, le penalità diminuirono e le ricompense crebbero, trasformando la produzione di conoscenza in una carriera riconosciuta e socialmente sostenuta. Le corti e le università cominciarono a competere per attrarre scienziati, creando una domanda di talento che stimolò ulteriormente la creatività. Mokyr conclude che questa combinazione di incentivi, regole e istituzioni trasformò la conoscenza da bene privato a bene pubblico, generando un’accumulazione senza precedenti di sapere utile tra il 1500 e il 1750. Tale accumulazione fu la condizione necessaria per l’industrializzazione e, in ultima analisi, per la nascita dell’economia moderna.