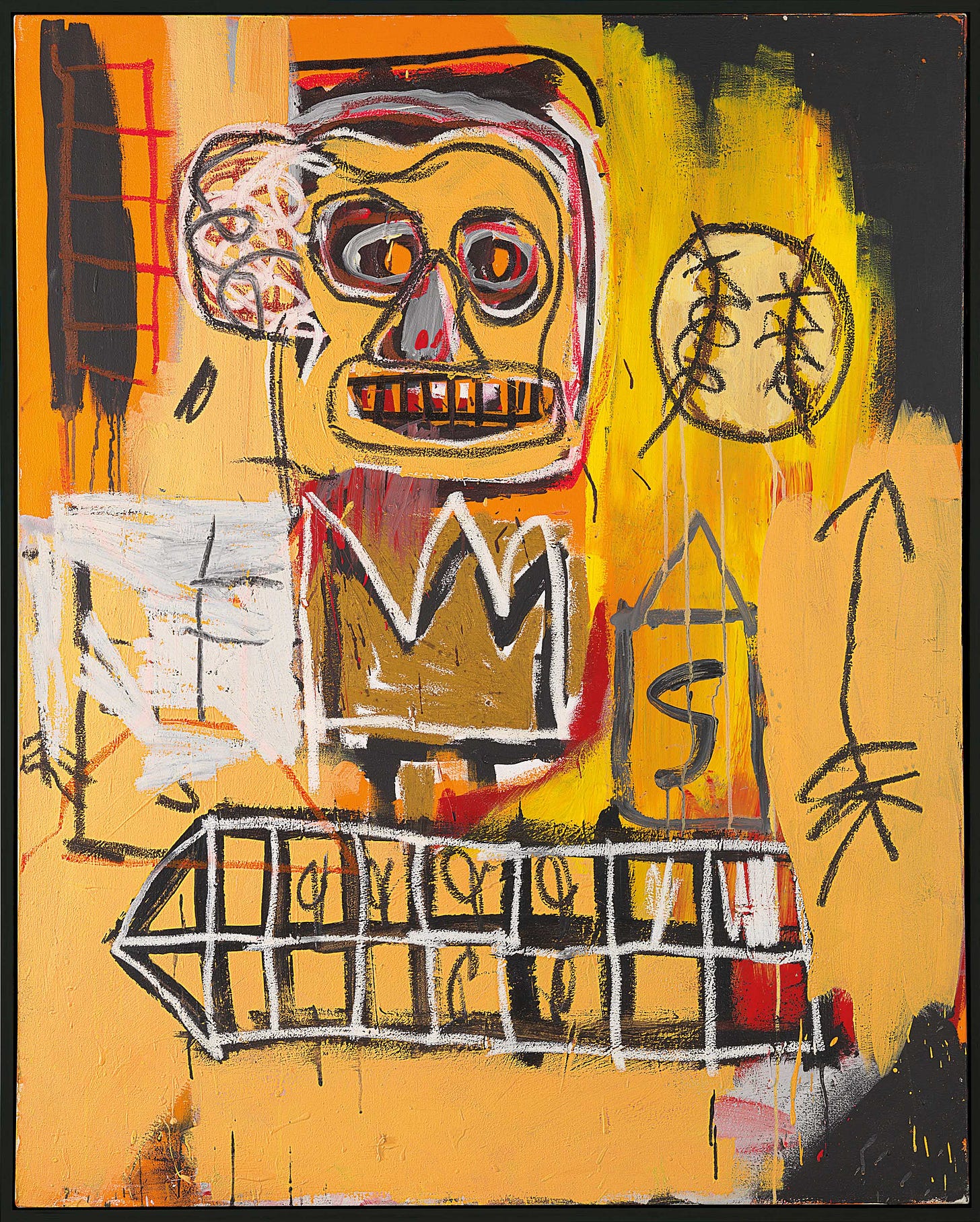Pensare complesso: linguaggio e complessità
La realtà in cui viviamo è plasmata da fenomeni interconnessi, processi adattivi e trasformazioni continue che sfuggono alle categorie tradizionali. Eppure, il linguaggio con cui spesso ne discutiamo in pubblico resta improntato a semplificazioni e dicotomie fuorvianti. Di fronte a problemi complessi – pensiamo al cambiamento climatico, alla gestione di una pandemia, o anche alla trasformazione digitale di un’azienda – c’è la tendenza a ridurli a narrazioni semplici, a singole cause o colpevoli, a soluzioni miracolistiche. Questa semplificazione eccessiva può dare l’illusione di controllo, ma quasi sempre tradisce la natura del problema e conduce a interventi inefficaci o controproducenti. “Intelligenza sistemica” significa sviluppare un diverso approccio mentale e linguistico: un lessico adeguato alla complessità, che ci aiuti a descrivere e affrontare i fenomeni senza distorcerli. Uscire dalla semplificazione richiede dunque di arricchire il nostro modo di pensare e comunicare con concetti e metafore più sofisticati, capaci di catturare nuance, connessioni e retroazioni.
Uno degli elementi chiave di questo lessico è il concetto di retroazione (feedback). Nei sistemi complessi, gli effetti di un’azione possono ritornare indietro e influenzare la causa originaria, spesso in modi non lineari. Parlare in termini di feedback – positivi o negativi – evita visioni lineari causa-effetto troppo semplicistiche. Ad esempio, invece di dire “più A causa più B”, l’intelligenza sistemica formulerebbe: “A e B sono legati da una retroazione: un aumento di A inizialmente provoca un aumento di B, ma questo a sua volta retroagisce su A riducendolo” (feedback negativo) oppure amplificandolo ulteriormente (feedback positivo). Concetti come circolo vizioso o virtuoso entrano così nel linguaggio quotidiano per indicare questi circuiti di retroazione. Già solo riconoscere l’esistenza di tali cicli cambia il modo in cui cerchiamo soluzioni: capiamo che rompere un ciclo vizioso richiede un intervento che spezza la retroazione, non basta agire unilateralmente su un anello della catena.
Un altro termine fondamentale è emergenza: l’idea che dall’interazione di parti semplici possono sorgere proprietà globali nuove, non deducibili dalle parti prese singolarmente. Adottare il concetto di emergenza nel nostro lessico ci allena a cercare spiegazioni a livello di sistema, non solo a livello dei componenti. Ad esempio, la “cultura organizzativa” di un’azienda è un fenomeno emergente dai comportamenti individuali e dalle regole formali, ma non è riconducibile solo a una policy scritta o a un singolo individuo: è qualcosa di più, una proprietà collettiva. Rendersi conto di ciò guida i leader a intervenire sul sistema nel suo insieme (ad esempio modificando flussi di comunicazione, incentivi, spazi di interazione) se vogliono cambiare la cultura, invece di illudersi che basti emanare una direttiva.
La non linearità è un altro concetto imprescindibile per uscire dalla semplificazione. In molti discorsi pubblici si ragiona ancora con mentalità lineare. Ma i sistemi complessi spesso mostrano soglie critiche: fino a un certo punto nulla sembra cambiare, poi superata la soglia il sistema subisce un cambiamento drastico (il cosiddetto tipping point). Un lessico sistemico include quindi parole come soglia, punto di non ritorno, effetto soglia, e riconosce l’asimmetria (incrementi piccoli possono portare a effetti enormi, e viceversa grandi input possono dissiparsi in piccoli output). Ciò aiuta, ad esempio, nel dibattito ambientale a far capire al pubblico che riscaldare il pianeta di 1 grado è profondamente diverso che riscaldarlo di 3 gradi: non è solo “tre volte più caldo”, ma potenzialmente un altro pianeta, perché oltre certe soglie scattano retroazioni climatiche incontrollabili.
L’interconnessione è forse la parola ombrello di questo nuovo lessico. Significa passare da un pensiero per compartimenti stagni a un pensiero che vede le relazioni tra le parti. Un approccio sistemico spinge a domandarsi, di fronte a qualunque intervento: “E poi cosa succede? Chi/cosa altro ne sarà influenzato?”. Questo porta a considerare, ad esempio, gli effetti secondari (le cosiddette conseguenze non intenzionali) come parte integrante dell’analisi, non come note a margine. Un imprenditore con intelligenza sistemica, nel lanciare un nuovo prodotto, rifletterà sugli impatti lungo l’intera filiera – fornitori, comunità locali, clienti a lungo termine, ambiente – e non solo sul profitto immediato. Un linguaggio appropriato qui include termini come trade-off (compromessi), spillover (ricadute), sistemi socio-tecnici (per evidenziare che tecnologia e società si coevolvono). Ad esempio, parlando di innovazione nell’automotive, invece di semplificare con “l’auto elettrica è la soluzione ecologica”, un discorso sistemico noterebbe i trade-off: meno emissioni allo scarico ma domanda di elettricità e materie prime altrove, evidenziando la necessità di un approccio integrato energia-trasporti.
Un aspetto importante del lessico della complessità è anche l’uso di metafore adeguate. Le metafore guidano il pensiero: per decenni si è parlato dell’economia come di una “macchina” da regolare, metafora fuorviante perché l’economia somiglia più a un organismo vivente o a un ecosistema. Adottare metafore biologiche o ecologiche (es. “ecosistema dell’innovazione”) induce a considerare aspetti come l’adattabilità, la diversità, l’evoluzione graduale – concetti cari alla complessità. Un’altra metafora utile è quella della rete: pensare a un problema come a una rete di nodi e collegamenti fa emergere intuizioni su colli di bottiglia, nodi centrali, periferie dimenticate, ridondanze. Questo è ormai comune nell’analisi di internet o delle reti sociali, ma dovrebbe diventare patrimonio comune anche nel ragionare, ad esempio, di organizzazione aziendale (chi è il nodo di collegamento critico tra due reparti?) o di politiche pubbliche (quali territori sono rimasti ai margini delle reti di sviluppo?).
Lo sviluppo di un lessico sistemico non è esercizio accademico, ma condizione pratica per migliorare il decision making in contesti complessi. Come sottolinea il filosofo Mario Bunge, i grandi problemi del nostro tempo “vanno affrontati sistemicamente” perché vengono in pacchetti interconnessi. Se continuiamo a usare un linguaggio frammentario, affronteremo solo pezzi di problemi, con soluzioni parziali che spesso falliscono. Al contrario, una terminologia adeguata costringe il pensiero a vedere il quadro d’insieme. Ad esempio, introdurre nel dibattito politico termini come “politiche di sistema” o “approccio olistico” fa comprendere che non basta una misura isolata, ma serve coordinamento multi-settoriale. Termini come resilienza (capacità di un sistema di assorbire shock mantenendo le funzioni) o adattività entrano nel lessico di amministratori e imprenditori, spostando l’attenzione dal controllo statico alla flessibilità dinamica.
In conclusione, coltivare l’intelligenza sistemica significa dotarsi di un vocabolario concettuale ricco e preciso, capace di descrivere la complessità senza ridurla a uno schema banale. Questo lessico è fatto di parole (feedback, emergenza, interdipendenza, resilienza, ecc.), di schemi (cicli causali, reti) e di metafore, che insieme formano una vera e propria “mappa mentale” nuova. Con questa mappa, imprenditori, decisori e cittadini possono navigare il mondo contemporaneo con maggiore consapevolezza, evitando sia la trappola di soluzioni semplicistiche che quella dell’impotenza di fronte al caos. È un linguaggio che richiede un po’ più di sforzo – perché riconosce sfumature e complessità – ma che restituisce in efficacia ciò che chiede in rigore. Uscire dalla semplificazione non vuol dire complicare inutilmente i discorsi: significa renderli realistici, aderenti alla natura multi-sfaccettata dei problemi, preparando così il terreno a soluzioni più robuste e durature.
Fonti
Adam Tinworth, “Systems Thinking: our guard against unintended consequences” (2019) .
Hobbs & Midgley, “How systems thinking enhances systems leadership” (2021)
A. de la Fuente, “Systemic Intelligence in the VUCA world”, PA Times (2021)
Jurgen Appelo, “32 Key Concepts in Systems Thinking and Complexity Theory” (2023)