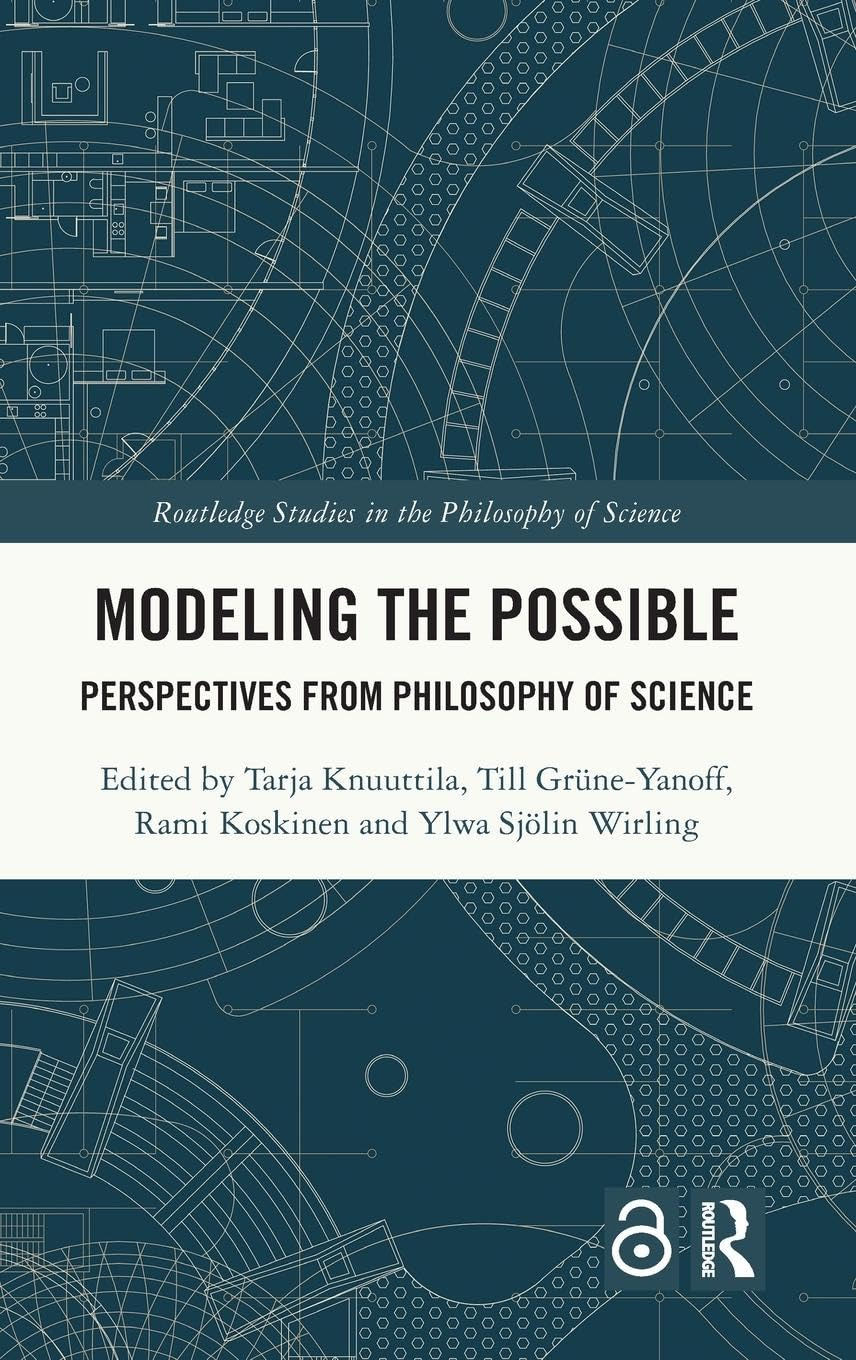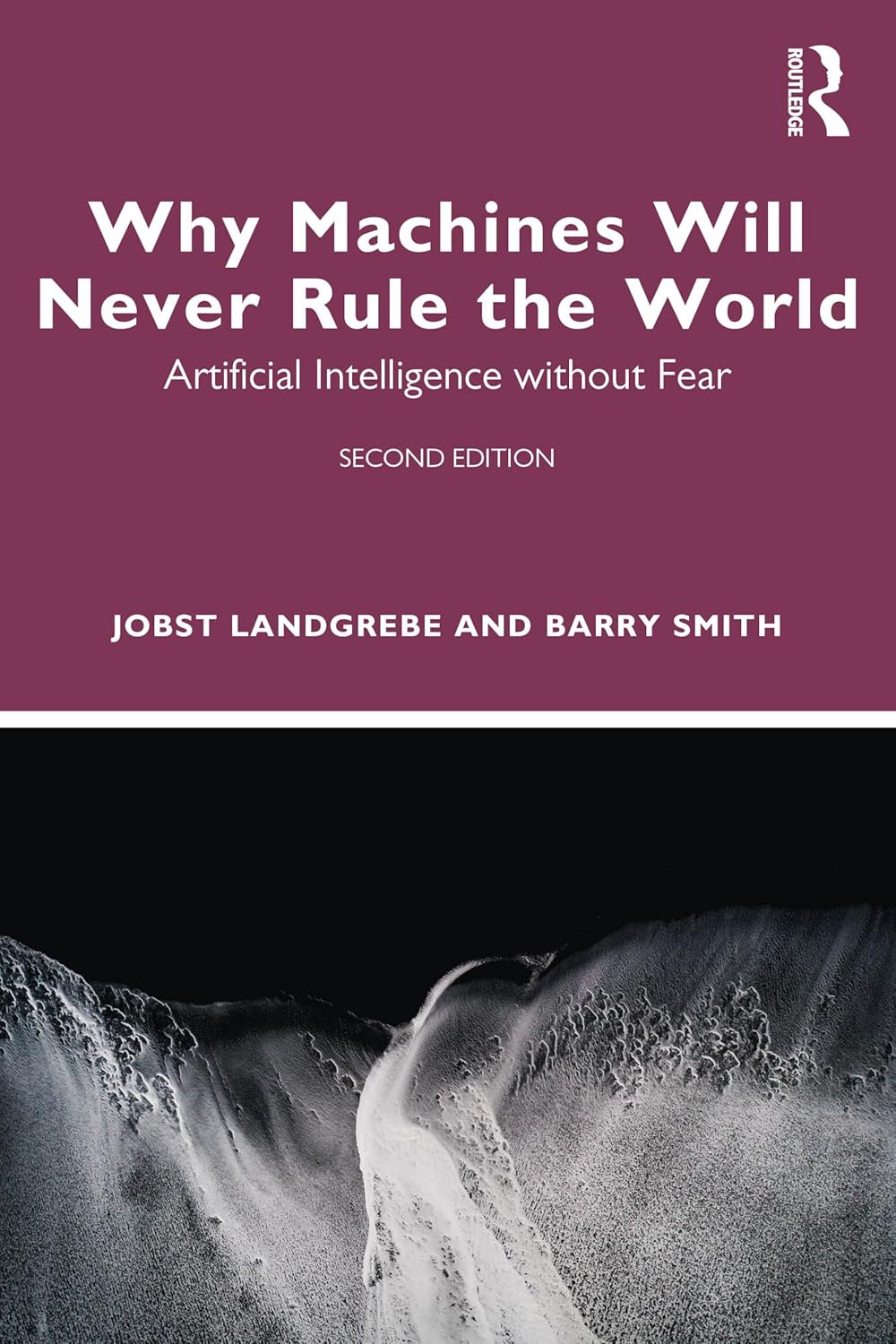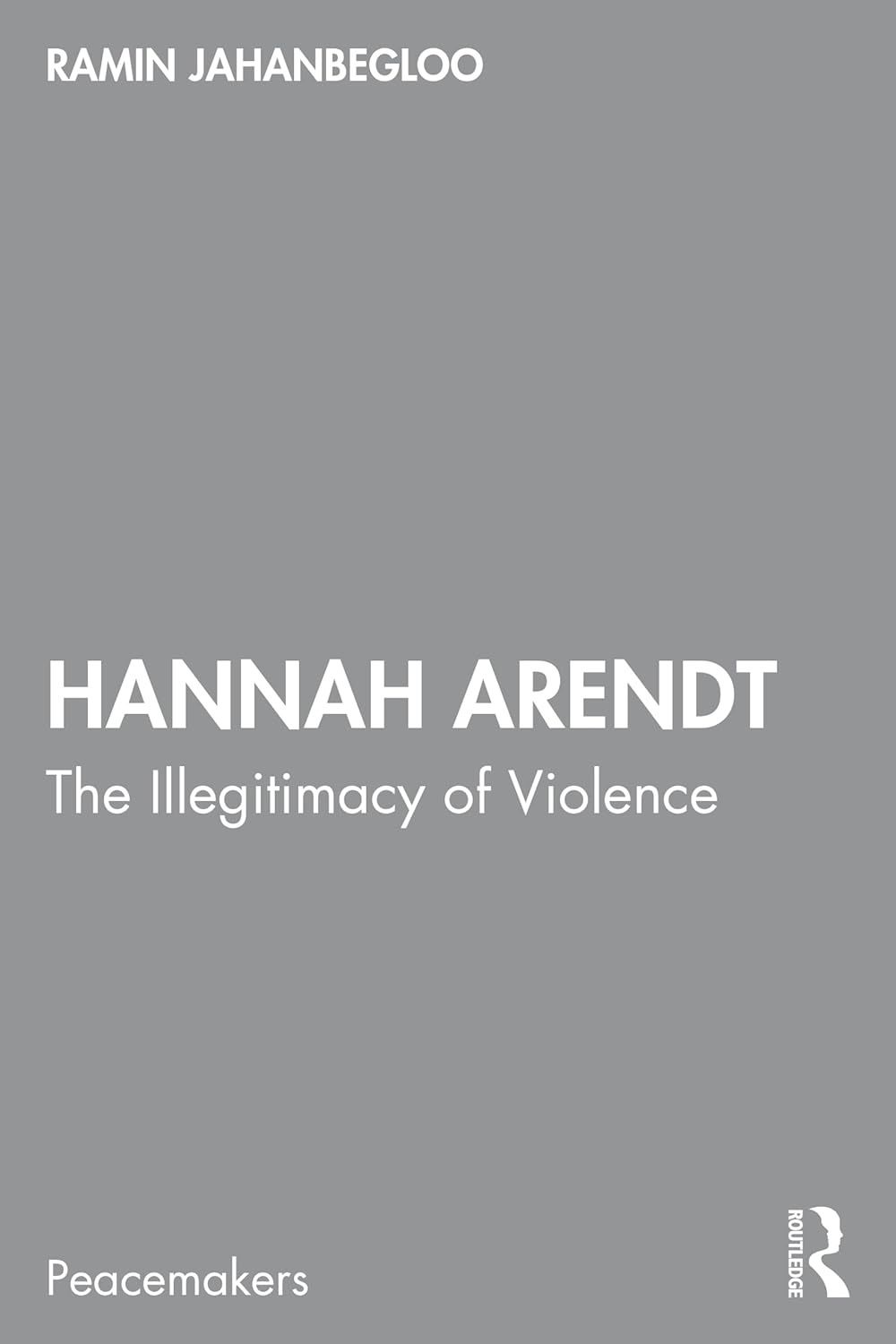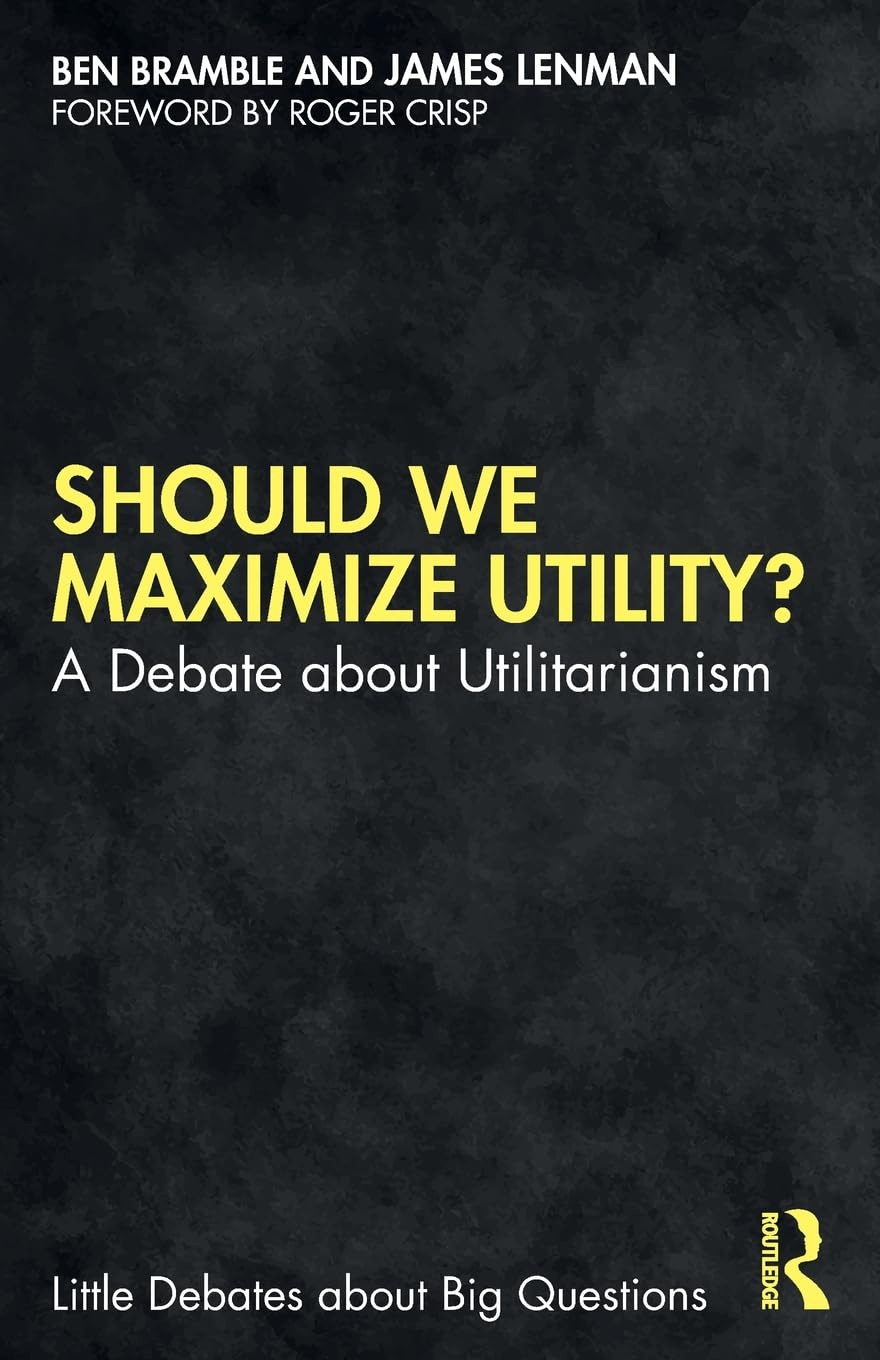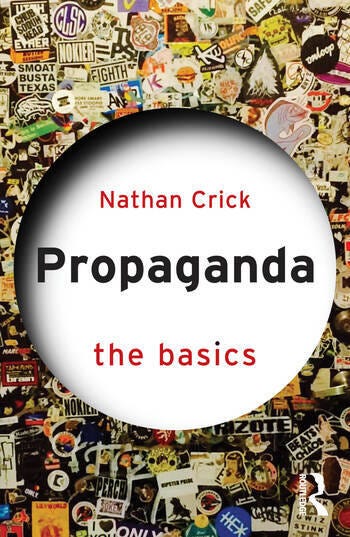Punti cardinali #15
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Per ogni testo viene redatta una scheda dettagliata e approfondita che consente di accedere a tutti i contenuti del libro, alle sue tesi, concetti ed argomentazioni, in modo completo.
I vantaggi sono enormi. In breve tempo è possibile accedere ai contenuti completi di testi di saggistica di grande complessità e di difficile accesso, potendo spaziare dalle scienze sociali a quelle della natura, e facendo così propri in modo facile ed economico i frutti della ricerca dei maggiori studiosi e studiose e delle più prestigiose case editrici a livello globale, come se si fosse letto l’intero libro.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale.
“Modeling the Possible. Perspectives from Philosophy of Science” di Tarja Knuuttila, Till Grüne-Yanoff, Rami Koskinen e Ylwa Sjölin Wirling
Il volume “Modeling the Possible. Perspectives from Philosophy of Science” (Modellare il possibile. Prospettive dalla filosofia della scienza), curato da Tarja Knuuttila, Till Grüne-Yanoff, Rami Koskinen e Ylwa Sjölin Wirling, è stato pubblicato da Routledge, Taylor & Francis Group, nel 2025. L’opera si colloca nell’ambito della filosofia della scienza contemporanea e affronta un problema che, pur essendo sempre più rilevante nelle pratiche scientifiche attuali, non aveva ricevuto finora una trattazione sistematica: quello della modellizzazione del possibile. Gli autori si interrogano su come i modelli scientifici non servano soltanto a descrivere o spiegare ciò che è effettivamente reale, ma siano strumenti per esplorare scenari ipotetici, alternative controfattuali e possibilità ancora non realizzate. La questione centrale è quindi comprendere in che senso i modelli permettano di indagare mondi possibili, generare previsioni su stati futuri, supportare decisioni normative o politiche e persino orientare la costruzione di nuove istituzioni sociali o pratiche scientifiche. Il libro prende posizione sul ruolo della modellizzazione nella scienza moderna, mostrando come la nozione di “possibile” costituisca un campo di ricerca filosofica che tocca ontologia, epistemologia e metodologia. In questo modo, l’opera intende offrire sia un quadro concettuale sia casi concreti per illustrare come la scienza operi non solo sul reale, ma anche sull’immaginato e sull’ipotetico.
"Why Machines Will Never Rule the World. Artificial Intelligence without Fear" di Jobst Landgrebe e Barry Smith
Il volume Why Machines Will Never Rule the World. Artificial Intelligence without Fear (Perché le macchine non governeranno mai il mondo. L’intelligenza artificiale senza paura), scritto da Jobst Landgrebe e Barry Smith e pubblicato da Routledge nel 2022, affronta il tema cruciale dei limiti intrinseci dell’intelligenza artificiale. La domanda centrale è se sia possibile creare una “intelligenza artificiale generale” (AGI), capace di uguagliare o addirittura superare l’intelligenza umana. Gli autori rispondono in modo netto e argomentato che ciò non sarà mai possibile, poiché la mente e la coscienza emergono da sistemi complessi che non possono essere pienamente descritti da equazioni matematiche o da algoritmi computazionali. Il problema di fondo è dunque quello di distinguere con chiarezza le reali potenzialità delle macchine da illusioni o aspettative irrealistiche. L’opera si colloca in un dibattito molto ampio che coinvolge scienze cognitive, filosofia, matematica e informatica, proponendo una confutazione radicale di visioni come quelle transumaniste o della cosiddetta “singolarità tecnologica”, le quali prevedono un futuro in cui le macchine prenderanno il controllo del mondo.
"Hannah Arendt. The Illegitimacy of Violence" di Ramin Jahanbegloo
Il volume di Ramin Jahanbegloo, Hannah Arendt. The Illegitimacy of Violence (Hannah Arendt. L’illegittimità della violenza), pubblicato da Routledge nel 2025, affronta il rapporto tra politica, potere e violenza nella prospettiva arendtiana, proponendo una lettura comparata che collega il lessico concettuale di Arendt a casi storici e a un quadro teorico più ampio. L’opera appartiene alla serie “Peacemakers” e reca in apertura i dati editoriali che confermano editore e anno di prima pubblicazione, insieme agli estremi di collana e di sede editoriale. Il problema centrale è la distinzione qualitativa tra potere e violenza: il potere sorge dall’agire insieme, nella parola e nella pluralità; la violenza è uno strumento muto, incapace di generare legittimità e di fondare istituzioni stabili. L’autore esplicita fin dall’Introduzione che Arendt non elaborò una “filosofia della nonviolenza” in senso tecnico, ma sviluppò una critica coerente della violenza come negazione della politica, collocando tale critica entro l’esperienza novecentesca dei totalitarismi e i dibattiti sulle rivoluzioni. L’argomentazione del libro mira a chiarire perché la violenza, anche quando appare utile, corrode le condizioni della convivenza politica.
"Should We Maximize Utility? A Debate about Utilitarianism" di Ben Bramble e James Lenman
Il volume Should We Maximize Utility? A Debate about Utilitarianism (Dovremmo massimizzare l’utilità? Un dibattito sull’utilitarismo), scritto da Ben Bramble e James Lenman e pubblicato da Routledge nel 2022, si presenta come un confronto diretto e sistematico tra due studiosi di filosofia morale che rappresentano posizioni contrapposte sul tema dell’utilitarismo. La questione centrale è se la massimizzazione dell’utilità debba essere considerata il criterio supremo per guidare l’azione umana e le istituzioni, o se invece essa porti a esiti problematici sia sul piano teorico che pratico. L’utilitarismo, che ha radici nell’opera di Jeremy Bentham e John Stuart Mill, sostiene che la giustezza di un’azione dipenda dal contributo che essa offre al benessere complessivo. Bramble difende questa prospettiva, presentandola come una dottrina semplice, coerente e capace di fornire risposte chiare alle sfide etiche contemporanee. Lenman, al contrario, mette in evidenza le difficoltà logiche e le conseguenze controintuitive di una concezione che riduce la moralità a un calcolo utilitaristico. L’intero dibattito è quindi strutturato come un’esposizione contrapposta, arricchita da esempi concreti e casi ipotetici, che mostrano i punti di forza e di debolezza delle rispettive posizioni.
"Propaganda: The Basics" di Nathan Cric
Il libro di Nathan Crick, Propaganda: The Basics (Propaganda: le basi), pubblicato da Routledge nel 2025, affronta in modo organico e sistematico la questione della propaganda come fenomeno centrale della società contemporanea. L’autore, professore di Comunicazione alla Texas A&M University, parte da una constatazione semplice ma cruciale: il termine “propaganda” è stato a lungo associato esclusivamente alla menzogna, alla manipolazione e agli apparati totalitari del Novecento, da Goebbels al realismo socialista, divenendo quasi sinonimo di inganno deliberato. Crick ribalta questa prospettiva, sostenendo che la propaganda non è riducibile a disinformazione o manipolazione ideologica, ma va intesa come un insieme di tecniche moderne di persuasione di massa. Tali tecniche non sono eliminabili, perché intrinseche al funzionamento dei sistemi democratici e delle società digitali, e si ritrovano tanto nelle campagne politiche quanto nella pubblicità, nei movimenti sociali o nelle iniziative culturali. La questione di fondo che il libro intende chiarire riguarda quindi la definizione della propaganda e il suo ruolo concreto nel plasmare le motivazioni, le emozioni e le azioni collettive, al di là di qualsiasi demonizzazione superficiale.