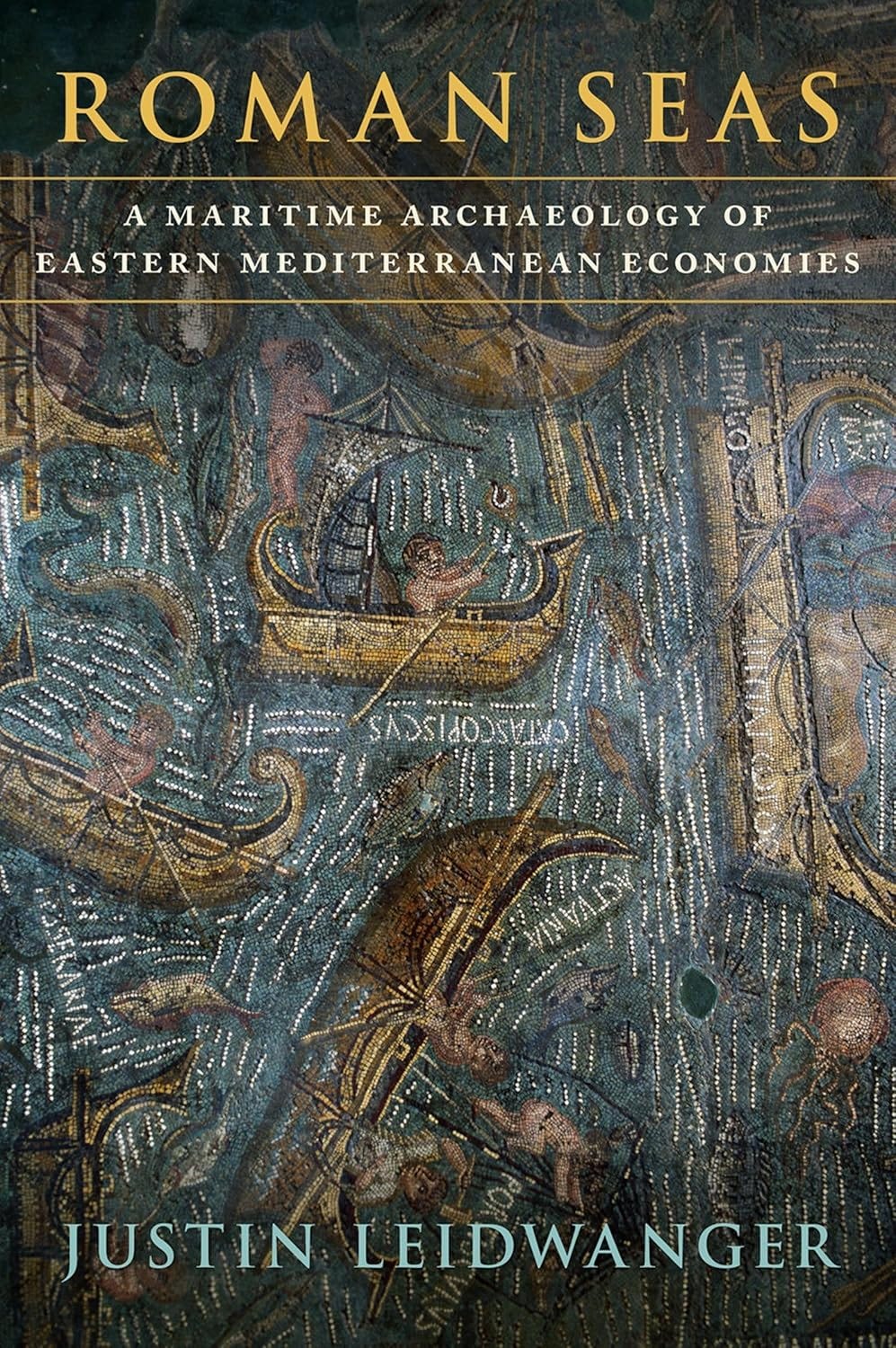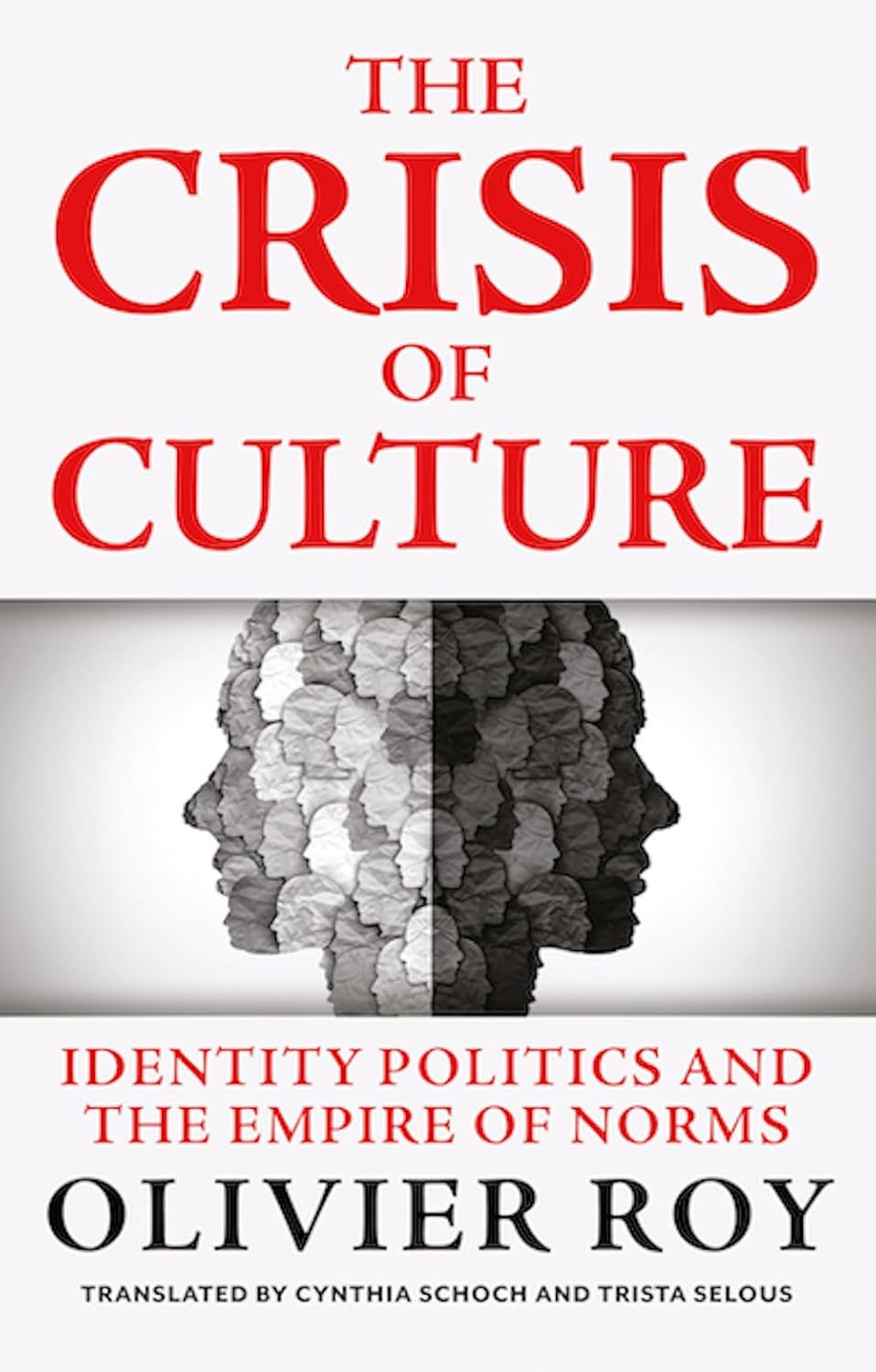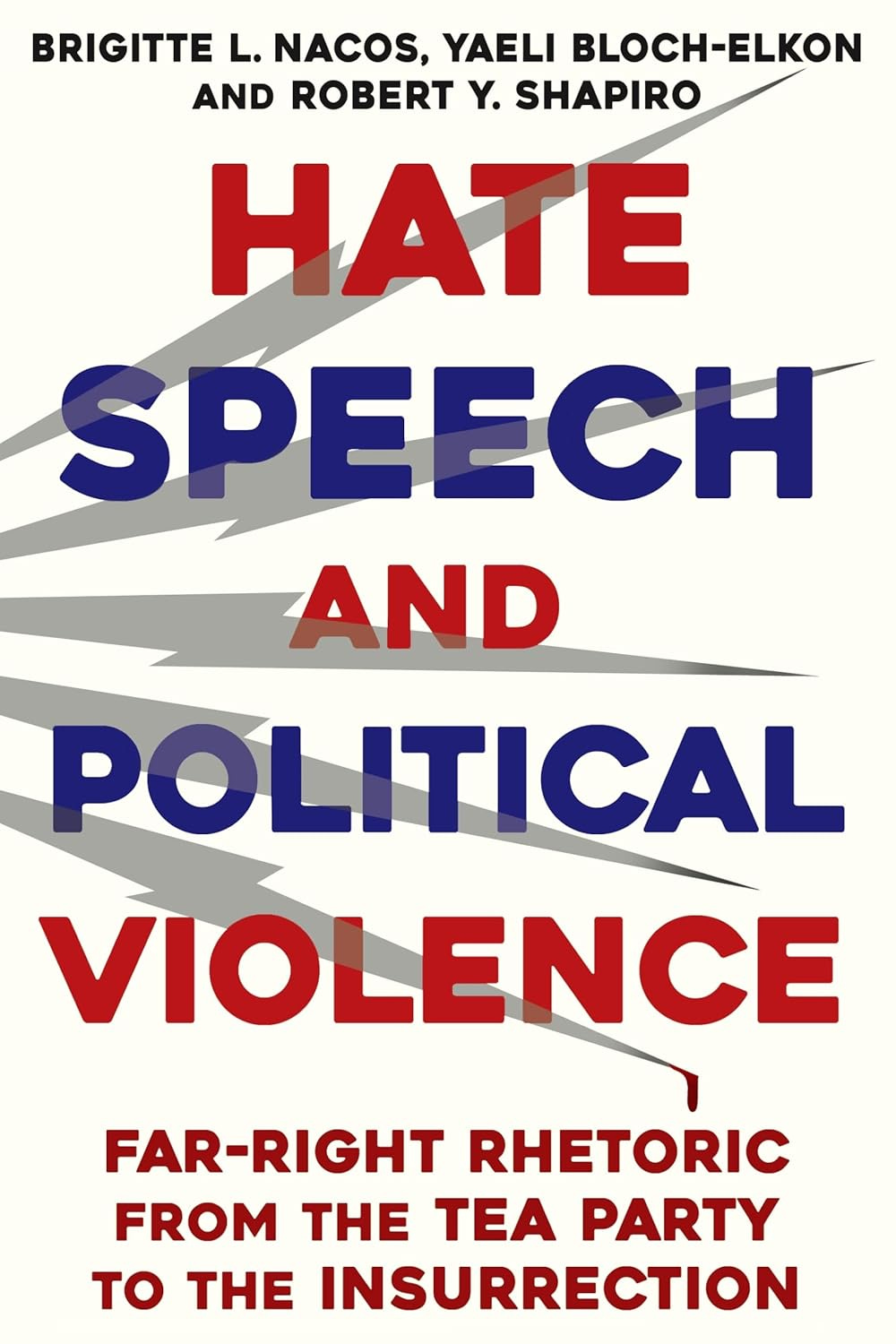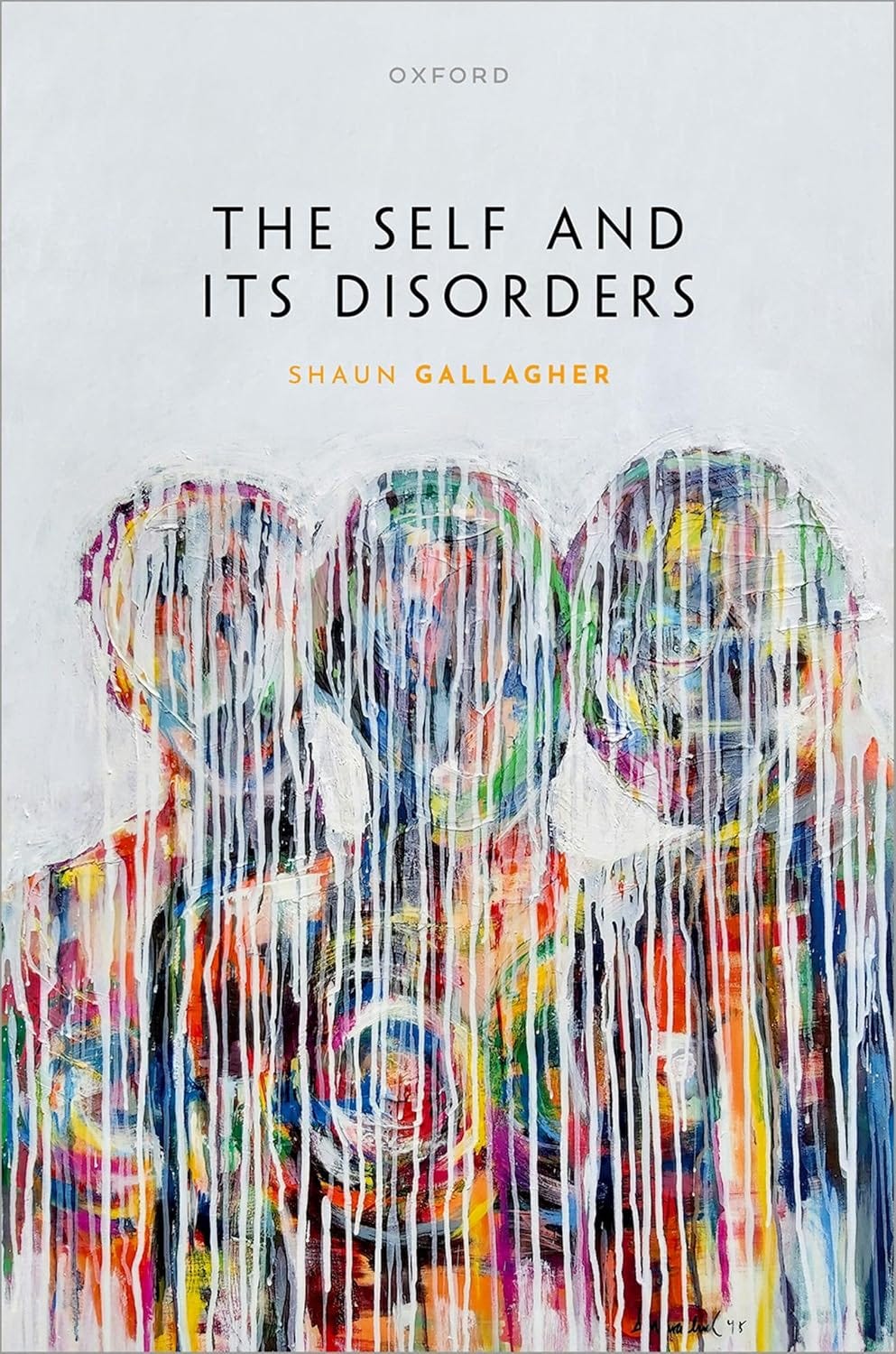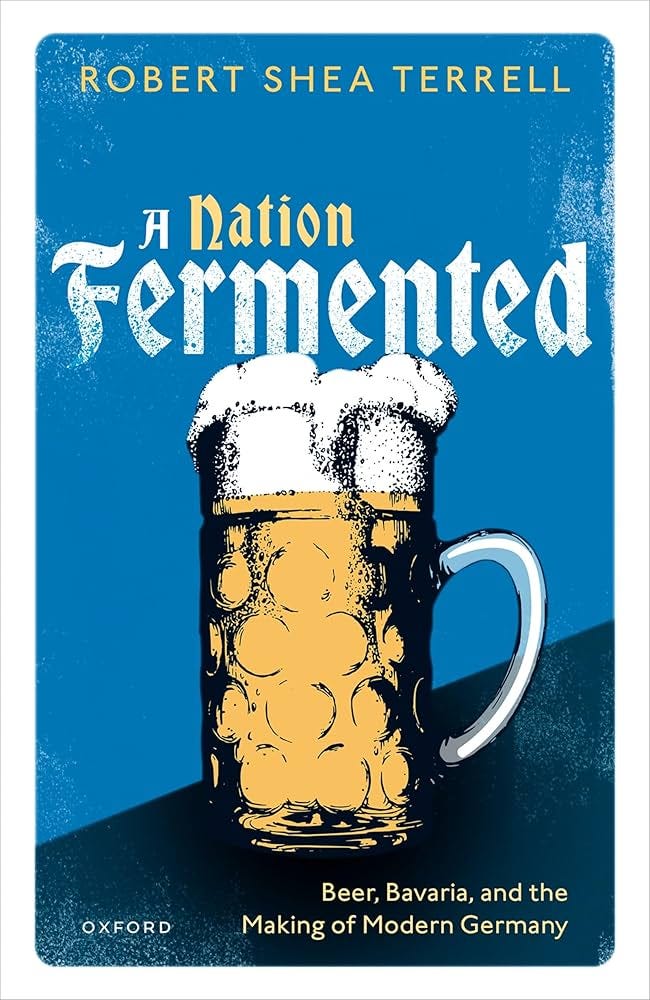Punti cardinali #22
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Per ogni testo viene redatta una scheda dettagliata e approfondita che consente di accedere a tutti i contenuti del libro, alle sue tesi, concetti ed argomentazioni, in modo completo.
I vantaggi sono enormi. In breve tempo è possibile accedere ai contenuti completi di testi di saggistica di grande complessità e di difficile accesso, potendo spaziare dalle scienze sociali a quelle della natura, e facendo così propri in modo facile ed economico i frutti della ricerca dei maggiori studiosi e studiose e delle più prestigiose case editrici a livello globale, come se si fosse letto l’intero libro.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale.
"Roman Seas. A Maritime Archaeology of Eastern Mediterranean Economies" di Justin Leidwanger
Il libro di Justin Leidwanger, Roman Seas. A Maritime Archaeology of Eastern Mediterranean Economies (Oxford University Press, 2020), affronta un tema complesso e cruciale per la comprensione del mondo romano: il ruolo del mare come infrastruttura economica e sociale del Mediterraneo orientale. L’autore si propone di ricostruire le logiche e le dinamiche degli scambi marittimi in età romana e tardoantica, non limitandosi a una semplice descrizione dei traffici o dei porti, ma elaborando un modello interpretativo che considera il mare come un tessuto connettivo, fatto di reti locali, regionali e interregionali. L’approccio scelto è fortemente interdisciplinare: Leidwanger combina archeologia subacquea, in particolare lo studio sistematico dei relitti, con la storia economica e sociale, la teoria dei network e la geografia storica. In questo senso, il volume si inserisce in un filone di studi che, dagli anni Settanta in poi, ha messo in discussione la visione di un Mediterraneo inteso unicamente come spazio di grandi rotte commerciali, insistendo invece sull’importanza degli scambi di corto raggio e sulla molteplicità dei “mari nel mare”. La prospettiva è quindi quella di un’analisi multiscalare, che presta attenzione sia alle strutture generali delle economie marittime, sia alle pratiche quotidiane delle comunità locali che vivevano e lavoravano lungo le coste. L’obiettivo è offrire un quadro complessivo, capace di cogliere le trasformazioni nel tempo e di restituire la complessità di un sistema economico dinamico, in cui le rotte e i porti non erano entità statiche, ma parte di un continuo processo di adattamento.
"The Crisis of Culture. Identity Politics and the Empire of Norms" di Olivier Roy
Il libro di Olivier Roy, The Crisis of Culture. Identity Politics and the Empire of Norms (Oxford University Press, 2023), affronta in maniera organica una delle questioni centrali del dibattito contemporaneo: la crisi della nozione stessa di cultura nelle società occidentali. Secondo l’autore, non ci troviamo di fronte a un semplice cambiamento di valori, né a una classica fase di transizione da un modello culturale a un altro, come avvenuto nel corso della storia con il passaggio dal mondo medievale al Rinascimento o dall’Illuminismo all’età industriale. Piuttosto, viviamo una fase di deculturazione, cioè di perdita delle basi stesse che rendevano possibile la cultura come linguaggio condiviso e come insieme di pratiche implicite capaci di orientare i comportamenti collettivi. L’impostazione del libro è al tempo stesso storica e teorica: Roy parte dall’analisi delle trasformazioni sociali intervenute dagli anni Sessanta a oggi per mostrare come valori, norme, codici e rivendicazioni identitarie abbiano progressivamente sostituito la cultura sia in senso antropologico (l’insieme di habitus impliciti che strutturano una società) sia in senso alto (il canone delle arti, delle lettere e delle scienze). L’autore mette in evidenza come, laddove un tempo l’elemento culturale implicito fungeva da collante e da cornice di riferimento, oggi predominino la codificazione esplicita e l’imposizione normativa, con l’effetto di moltiplicare conflitti, frammentazioni e ansie identitarie. L’obiettivo del volume non è proporre soluzioni immediate ma chiarire i termini della crisi, analizzando in profondità i processi di lungo periodo che hanno condotto alla situazione attuale.
"Hate Speech and Political Violence. Far-Right Rhetoric from the Tea Party to the Insurrection" di Brigitte L. Nacos, Yaeli Bloch-Elkon e Robert Y. Shapiro
Il volume Hate Speech and Political Violence. Far-Right Rhetoric from the Tea Party to the Insurrection, scritto da Brigitte L. Nacos, Yaeli Bloch-Elkon e Robert Y. Shapiro, si concentra sull’evoluzione della comunicazione politica dell’estrema destra negli Stati Uniti tra il 2009 e il 2021. L’opera indaga il rapporto tra linguaggio politico, odio e violenza, mostrando come la retorica utilizzata da leader e movimenti conservatori radicali abbia progressivamente eroso le basi del discorso democratico, aprendo la strada a episodi di violenza politica culminati con l’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021. Gli autori partono dal presupposto che le parole non siano meri strumenti di comunicazione, ma atti performativi che possono legittimare o delegittimare attori politici, costruire nemici e rafforzare identità collettive. La loro analisi, basata su un ampio corpus di dati empirici, studi sull’opinione pubblica, monitoraggi dei media e ricostruzioni storiche, intende dimostrare che la violenza verbale ha effetti diretti sul comportamento politico e può creare le condizioni per la violenza fisica. L’impostazione è multidisciplinare: integra approcci di scienza politica, comunicazione, sociologia e psicologia politica. Il testo si rivolge non solo a studiosi e specialisti, ma anche a un pubblico interessato a comprendere le trasformazioni del sistema politico americano, offrendo strumenti interpretativi per leggere la connessione tra dinamiche mediatiche, leadership politica e radicalizzazione. L’obiettivo complessivo è fornire un quadro rigoroso delle cause e delle conseguenze dell’incitamento all’odio e della retorica polarizzante nell’era contemporanea.
"The Self and Its Disorders" di Shaun Gallagher
Il libro di Shaun Gallagher, The Self and Its Disorders, rappresenta uno dei contributi più articolati e ambiziosi alla comprensione del sé e delle sue alterazioni psicopatologiche. L’autore, tra i maggiori filosofi contemporanei della mente, si muove con un approccio interdisciplinare che integra fenomenologia, filosofia della mente, neuroscienze cognitive e psicopatologia clinica. L’obiettivo non è quello di ridurre il sé a una funzione cerebrale, né di abbandonarlo a una descrizione puramente soggettiva, ma di esplorarne la natura complessa come fenomeno multilivello. Gallagher parte dall’idea che il sé sia costituito da una rete di dimensioni interconnesse, che vanno dal senso corporeo immediato fino alle narrazioni biografiche e alle relazioni sociali. Questo impianto, che l’autore chiama “pattern theory of self”, consente di superare dicotomie riduttive e di collocare le diverse patologie come perturbazioni di uno schema dinamico piuttosto che come guasti isolati. L’intero volume si struttura come una progressione: dalle basi fenomenologiche del sé, alle sue declinazioni teoriche, fino alla descrizione dei disturbi clinici che ne mostrano la fragilità. L’approccio è sistematico ma mai astratto, perché continuamente supportato da esempi clinici, casi storici e dati neuroscientifici.
"A Nation Fermented. Beer, Bavaria, and the Making of Modern Germany" di Robert Shea Terrell
Il volume di Robert Shea Terrell si apre con una premessa metodologica che chiarisce l’originalità dell’approccio: raccontare la storia della Germania moderna attraverso la birra, in particolare quella bavarese. Non si tratta di una storia del gusto, né di una ricostruzione aneddotica legata a feste popolari, bensì di un’analisi di lungo periodo che utilizza la birra come lente interpretativa per osservare il modo in cui si è costruita l’identità nazionale. L’autore evidenzia come la Baviera, spesso percepita come regione periferica o folkloristica, sia stata invece un laboratorio decisivo per l’elaborazione di modelli legislativi, fiscali e culturali che hanno avuto risonanza ben oltre i confini locali. La birra, nella sua apparente banalità, diventa quindi un “bene rivelatore”: seguendo le sue vicende si possono cogliere i conflitti tra centro e periferia, tra tradizione e modernizzazione, tra economia regionale e mercato globale. L’impostazione del libro è cronologica ma intrecciata a un’analisi tematica, capace di mostrare come i diversi momenti storici abbiano rielaborato la birra bavarese attribuendole significati differenti: da simbolo di resistenza culturale a bandiera di identità nazionale, da strumento di consenso politico a marchio di qualità da difendere sui mercati europei e internazionali. In tal senso, l’opera non è una monografia su un prodotto, ma un’indagine su come beni culturali materiali possano diventare strumenti per costruire narrazioni collettive e legittimazioni politiche.