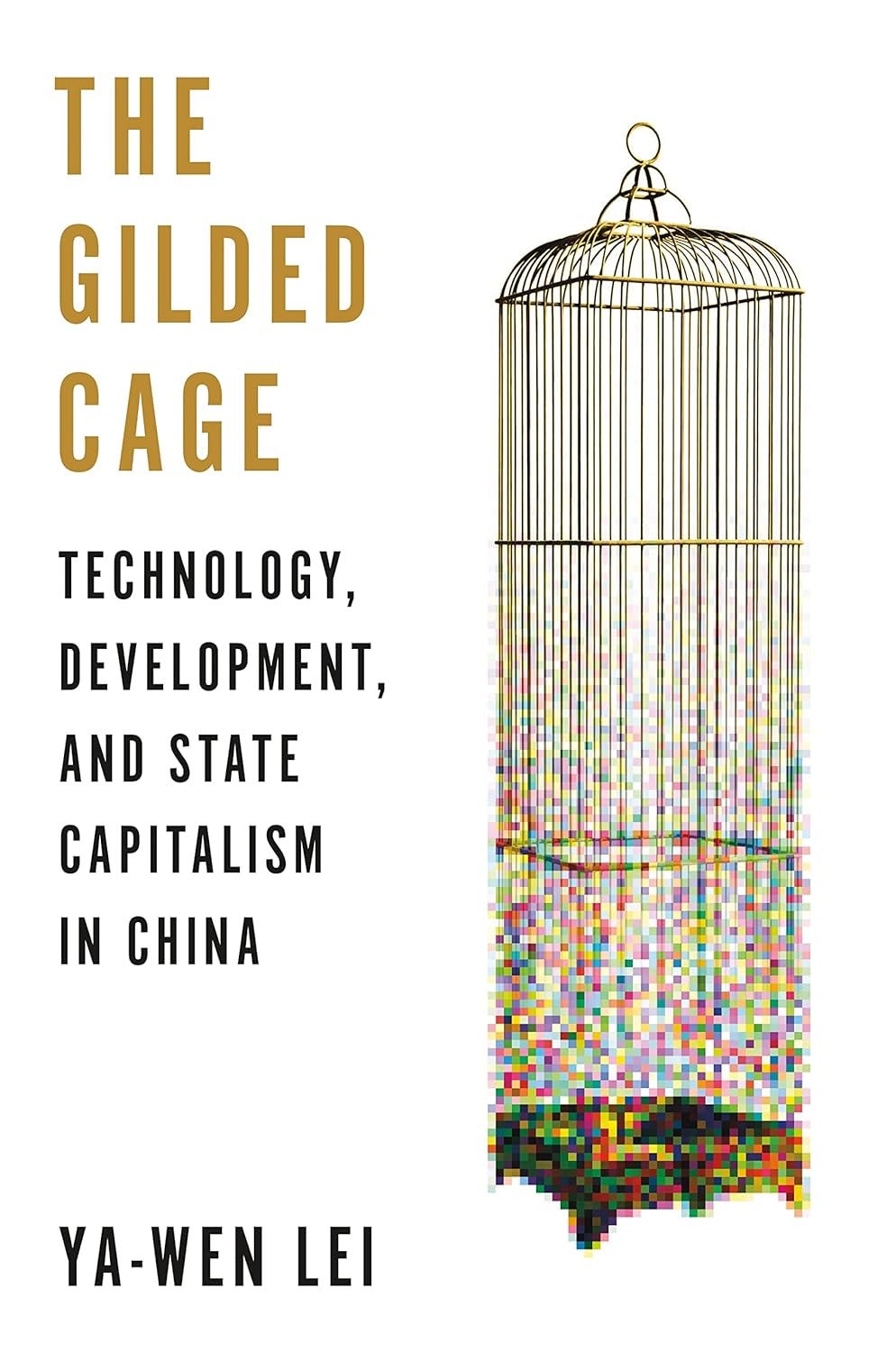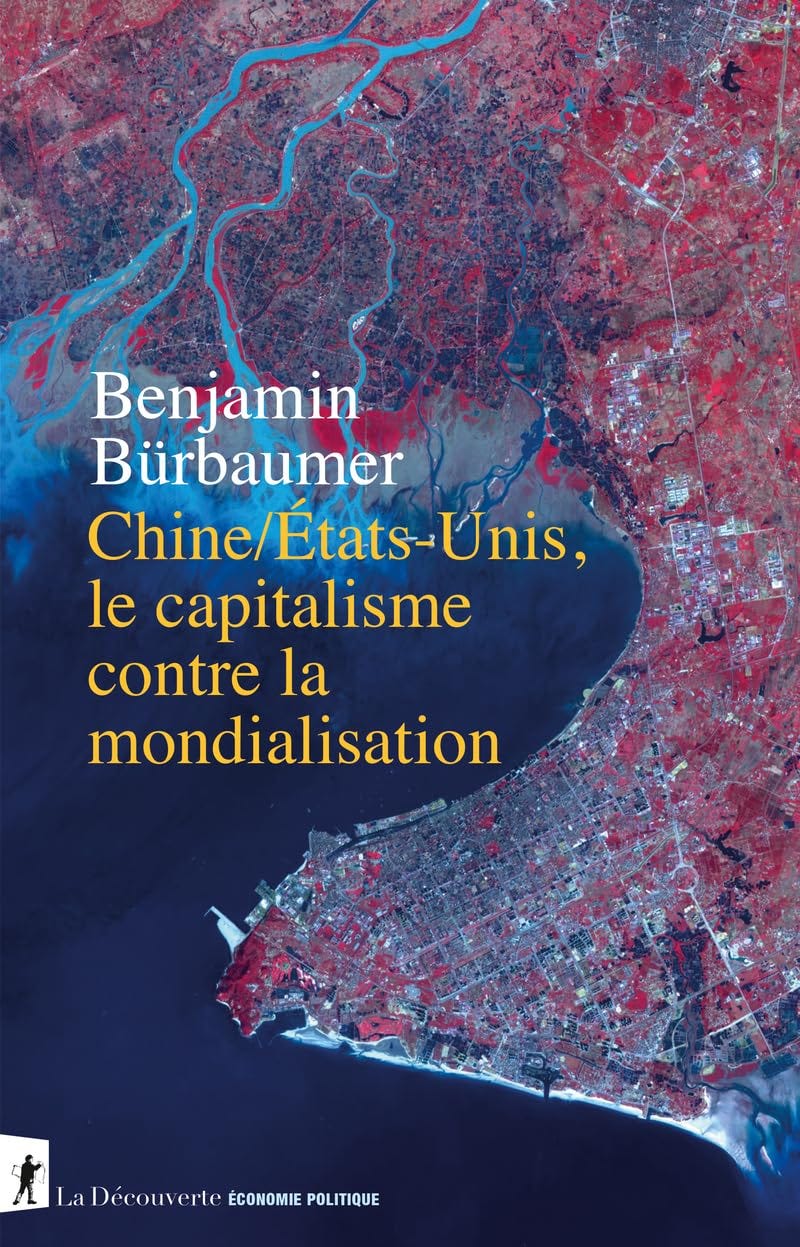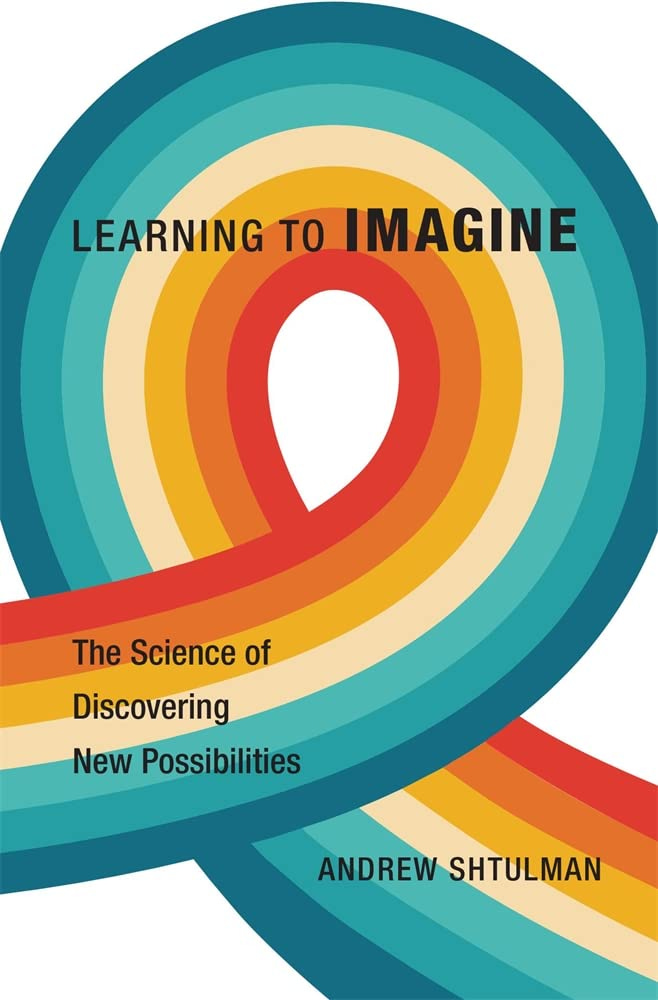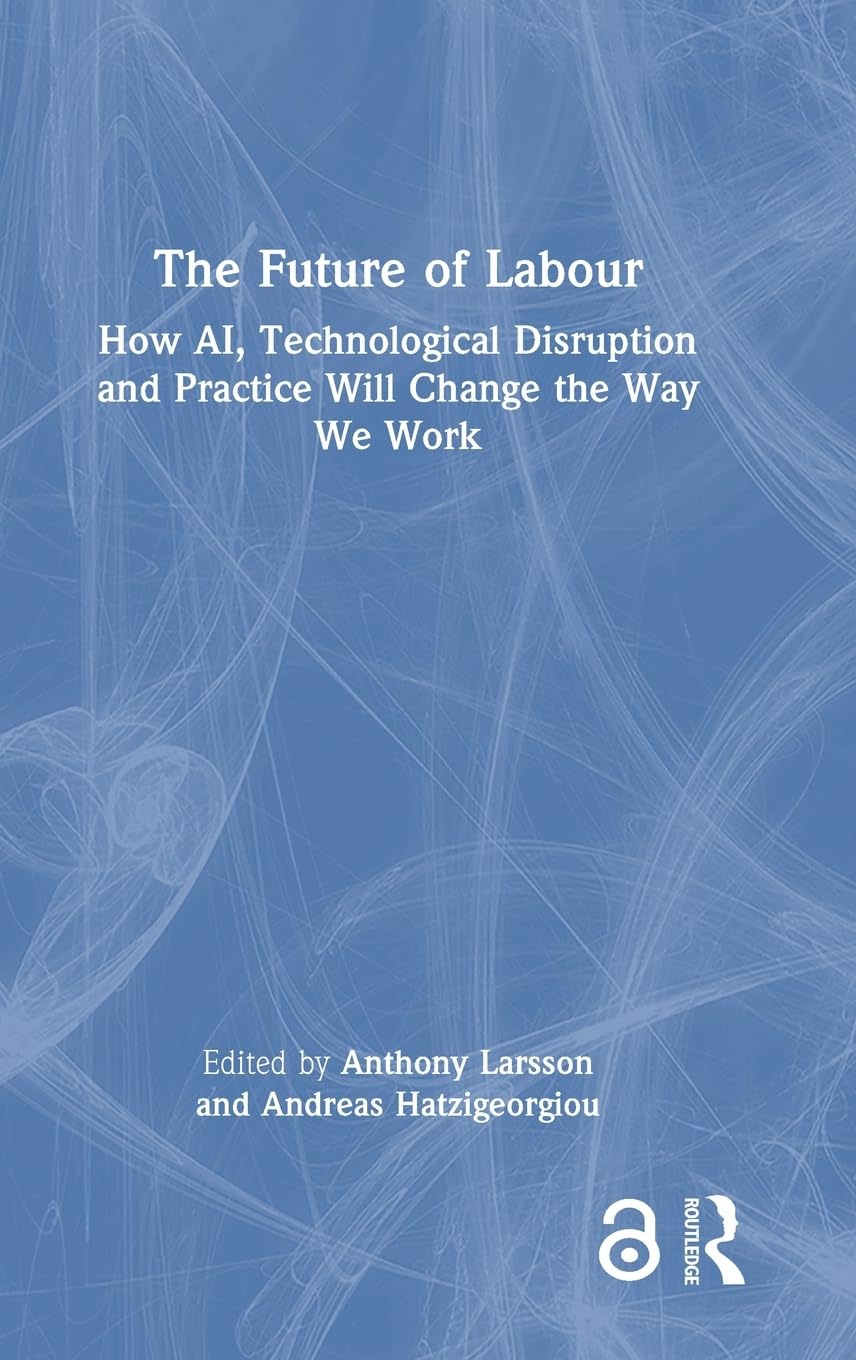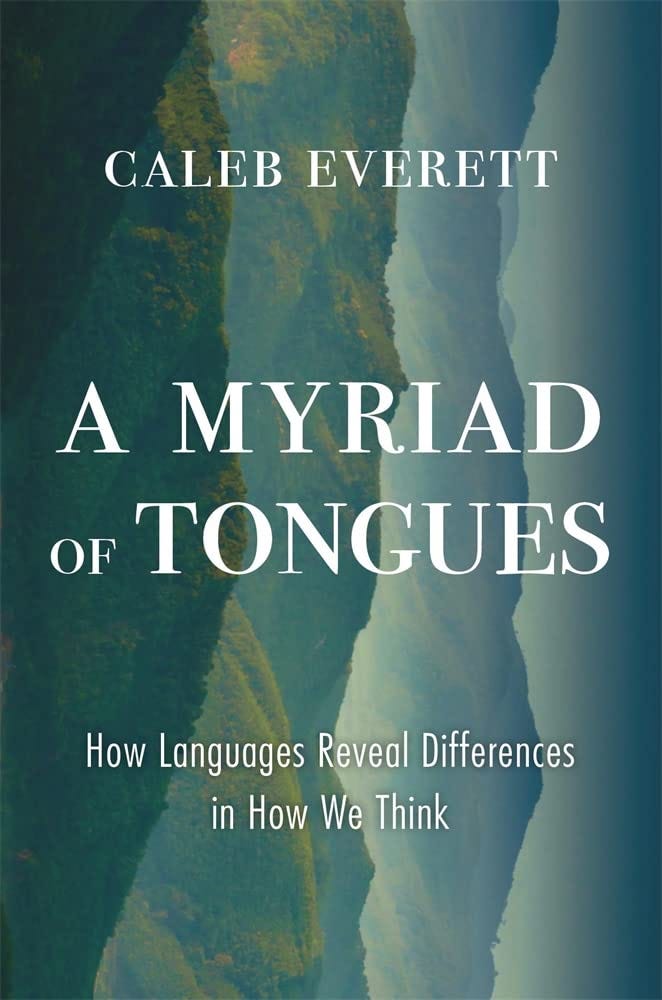Punti cardinali #28
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Per ogni testo viene redatta una scheda dettagliata e approfondita che consente di accedere a tutti i contenuti del libro, alle sue tesi, concetti ed argomentazioni, in modo completo.
I vantaggi sono enormi. In breve tempo è possibile accedere ai contenuti completi di testi di saggistica di grande complessità e di difficile accesso, potendo spaziare dalle scienze sociali a quelle della natura, e facendo così propri in modo facile ed economico i frutti della ricerca dei maggiori studiosi e studiose e delle più prestigiose case editrici a livello globale, come se si fosse letto l’intero libro.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale.
"The Gilded Cage: Technology, Development, and State Capitalism in China" di Ya-Wen Lei
Il volume The Gilded Cage: Technology, Development, and State Capitalism in China, pubblicato nel 2023 da Ya-Wen Lei, si propone di analizzare le trasformazioni strutturali che hanno caratterizzato la Repubblica Popolare Cinese nel corso delle ultime due decadi, ponendo particolare attenzione al rapporto tra tecnologia, sviluppo economico e forme peculiari di capitalismo di Stato. L’autrice, sociologa formatasi ad Harvard, dove oggi insegna, affronta la questione con un approccio interdisciplinare che coniuga sociologia politica, studi sullo sviluppo, teoria delle istituzioni e analisi delle tecnologie emergenti. Il tema generale del libro è la costruzione di una modernità “dorata ma limitata”, ovvero una gabbia che da un lato ha favorito crescita e innovazione, ma dall’altro ha mantenuto salde le maglie del controllo politico. L’obiettivo dichiarato di Lei è mostrare come il Partito Comunista Cinese abbia utilizzato le tecnologie digitali e le politiche industriali per promuovere lo sviluppo, contenendo al tempo stesso spinte sociali potenzialmente destabilizzanti. L’impostazione complessiva è quella di una ricerca empiricamente fondata, basata su un vasto corpus di interviste, dati statistici, documenti ufficiali e osservazioni sul campo, che vengono presentati in modo sistematico per illustrare il funzionamento concreto del capitalismo di Stato cinese e le sue contraddizioni interne.
"Chine–États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation" di Benjamin Bürbaumer
Il libro di Benjamin Bürbaumer, pubblicato nel 2024 da La Découverte, affronta la questione cruciale della ridefinizione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina e il loro impatto sul capitalismo contemporaneo e sulla mondializzazione. L’autore parte da una constatazione: il termine “globalizzazione” è spesso utilizzato come sinonimo di “capitalismo”, ma in realtà si tratta di fenomeni distinti, che nel tempo hanno avuto traiettorie convergenti o divergenti. Se negli anni Novanta sembravano coincidere – con l’apertura dei mercati, la liberalizzazione dei flussi di capitale e l’integrazione delle catene del valore – oggi le dinamiche mostrano una crescente frattura. Il capitalismo, inteso come sistema di produzione e accumulazione flessibile e adattabile, continua a prosperare, ma la mondializzazione, come progetto unitario e integrato, appare in crisi. In questo scenario, la rivalità tra Cina e Stati Uniti non va intesa come una semplice “guerra commerciale” o come la contrapposizione classica tra potenza emergente e potenza dominante. Secondo Bürbaumer essa è piuttosto la manifestazione di due modelli differenti di capitalismo, che mettono in discussione l’idea stessa di una globalizzazione univoca e senza alternative. Il libro, in questo senso, propone una lettura strutturale: la competizione non riguarda solo tariffe o bilanci commerciali, ma investe le regole, le istituzioni e le forme di legittimazione del capitalismo nel XXI secolo.
"Learning to Imagine. The Science of Discovering New Possibilities" (2024) di Andrew Shtulman
Il volume Learning to Imagine. The Science of Discovering New Possibilities, pubblicato nel 2024 da Andrew Shtulman, rappresenta un contributo significativo allo studio delle capacità immaginative e del loro ruolo nello sviluppo della conoscenza scientifica e culturale. L’autore, psicologo cognitivo e docente di psicologia e scienze cognitive, esplora come l’immaginazione non sia una facoltà marginale o puramente creativa in senso artistico, ma una componente centrale dei processi cognitivi che sostengono la scoperta, l’innovazione e l’adattamento umano. L’obiettivo dichiarato del libro è quello di chiarire i meccanismi attraverso i quali le persone riescono a concepire possibilità nuove e inattese, distinguendo l’immaginazione da altre funzioni della mente come la memoria, la percezione e il ragionamento logico. L’impostazione generale è quella di una ricognizione interdisciplinare che mette insieme psicologia sperimentale, filosofia della scienza, storia delle idee e studi sulla creatività. Shtulman mira a dimostrare che l’immaginazione non è un lusso cognitivo, ma una risorsa fondamentale per affrontare problemi complessi, generare ipotesi innovative e spostare i confini di ciò che viene considerato possibile. La prospettiva proposta si concentra dunque su come gli esseri umani apprendano a immaginare, e su come questa capacità possa essere insegnata, potenziata e orientata verso la scoperta di nuove possibilità.
"The Future of Labour. How AI, Technological Disruption and Practice Will Change the Way We Work" di Anthony Larsson e Andreas Hatzigeorgiou
Il volume The Future of Labour (2025) affronta una delle questioni più rilevanti del nostro tempo: come l’intelligenza artificiale, l’automazione e la discontinuità tecnologica stiano modificando il lavoro e le pratiche economiche e sociali a livello globale. Gli autori, Anthony Larsson e Andreas Hatzigeorgiou, si pongono l’obiettivo di esplorare in modo sistematico non soltanto le conseguenze immediate delle nuove tecnologie sull’occupazione, ma anche le implicazioni più profonde sulla natura stessa del lavoro, sulle competenze richieste, sulla struttura delle imprese e sull’organizzazione delle società contemporanee. L’impostazione è chiaramente interdisciplinare: i capitoli combinano prospettive di economia, sociologia, management e studi sull’innovazione, con un approccio che cerca di bilanciare la dimensione empirica con quella teorica. L’intento non è proporre una visione utopica o distopica, bensì fornire un quadro di riferimento che permetta di comprendere i processi in atto e di orientare decisioni politiche, scelte aziendali e percorsi individuali di adattamento. Il libro è dunque concepito come una guida critica e analitica per chiunque sia interessato a capire come il lavoro del futuro verrà plasmato dalle tecnologie emergenti e da come i sistemi sociali reagiranno a queste trasformazioni.
"A Myriad of Tongues. How Languages Reveal Differences in How We Think" di Caleb Everett
Il volume di Caleb Everett A Myriad of Tongues. How Languages Reveal Differences in How We Think affronta una questione centrale delle scienze umane e cognitive: il rapporto tra linguaggio e pensiero. L’autore parte da un dato di fatto spesso sottovalutato, cioè l’enorme varietà linguistica che caratterizza l’umanità, con migliaia di lingue oggi esistenti, molte delle quali a rischio di scomparsa. Questa diversità non è soltanto un fenomeno culturale o antropologico, ma ha profonde conseguenze cognitive, perché ogni lingua contiene al proprio interno sistemi concettuali, regole e metafore che incidono sulla percezione e sull’elaborazione mentale della realtà. Everett si colloca all’interno di un dibattito che ha visto, da un lato, i sostenitori di un universalismo cognitivo, secondo cui tutte le menti funzionerebbero nello stesso modo indipendentemente dal linguaggio parlato, e dall’altro lato i difensori del cosiddetto determinismo linguistico, che attribuiscono alla lingua il potere di definire rigidamente i limiti del pensiero. La sua posizione è intermedia: le lingue non determinano in maniera assoluta la cognizione, ma certamente la influenzano, orientando abitudini percettive, schemi di ragionamento e modi di categorizzare l’esperienza. In questo senso, il libro intende dimostrare come lo studio della diversità linguistica non sia un esercizio di erudizione marginale, ma un modo per comprendere meglio la natura stessa del pensiero umano.