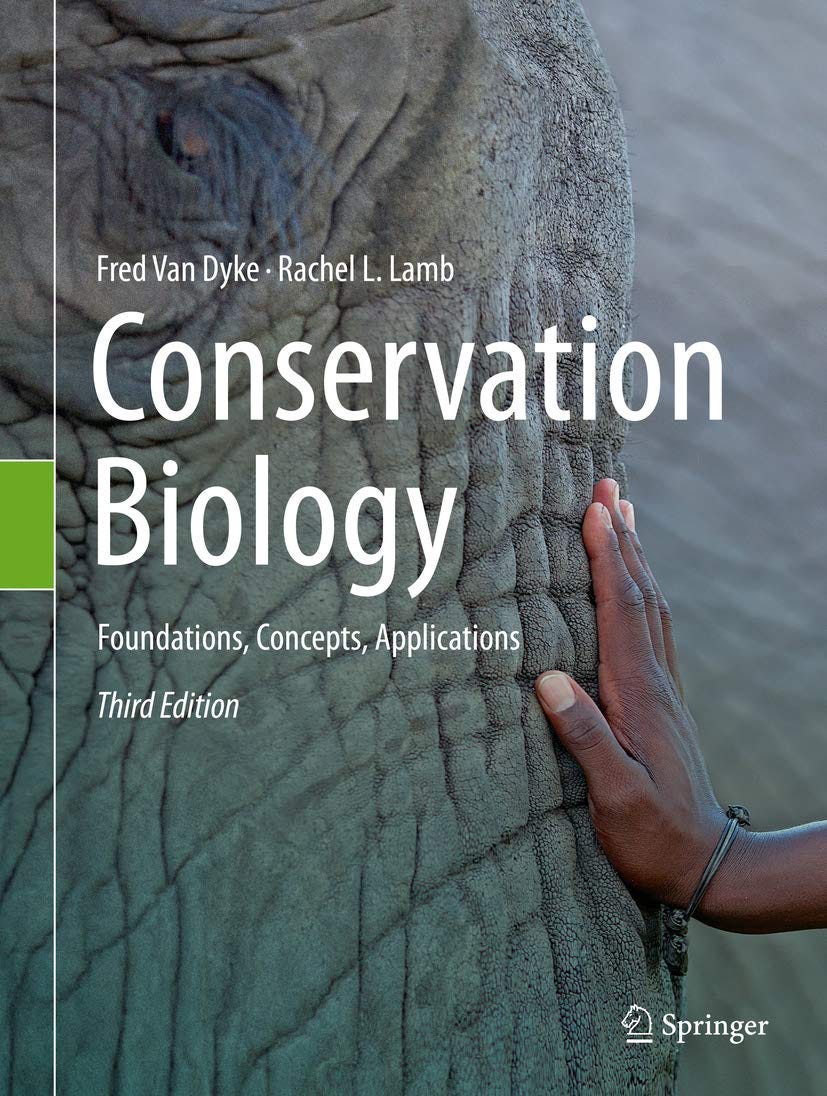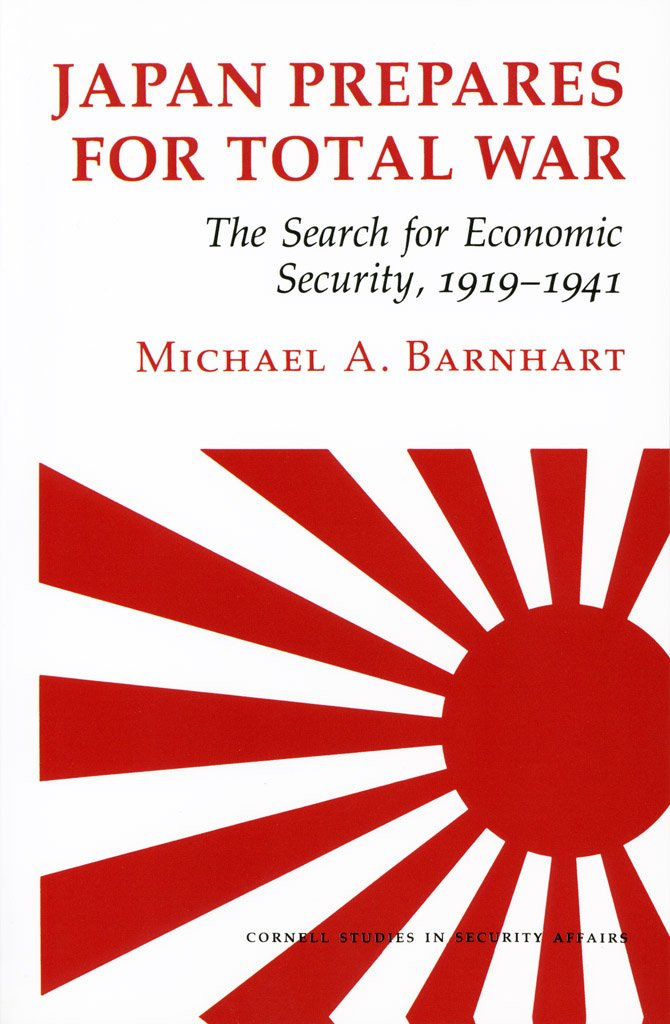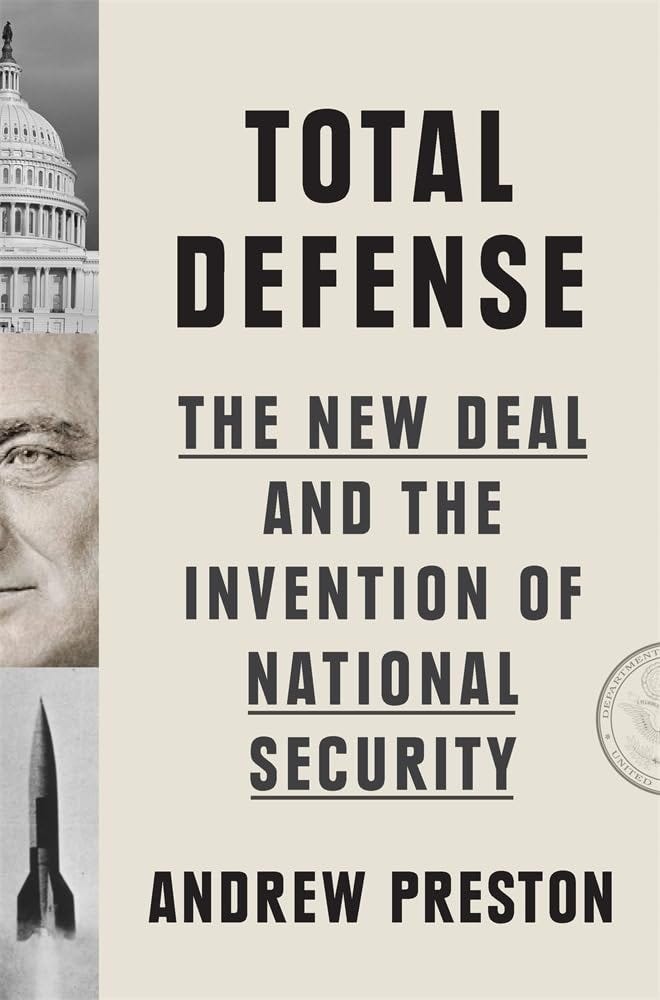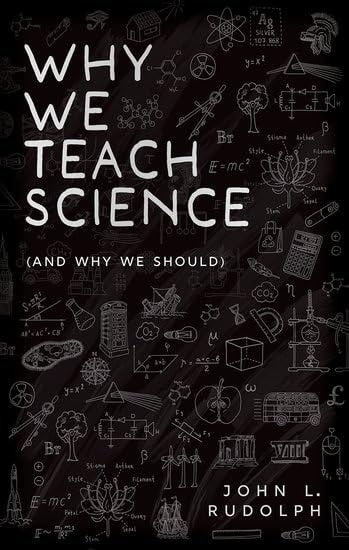Punti cardinali #3
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Ogni settimana vengono monitorate in modo sistematico le novità editoriali delle principali case editrici internazionali, con copertura delle aree linguistiche più rilevanti.
L’obiettivo di Punti Cardinali è offrire agli abbonati di Stroncature l’accesso diretto e sistematico alla saggistica più rilevante pubblicata a livello mondiale, indipendentemente dalla lingua e dalla disponibilità sul mercato editoriale italiano. Attraverso un monitoraggio sistematico delle principali case editrici internazionali, vengono selezionati i volumi più significativi per l’analisi dei grandi processi politici, economici, tecnologici e sociali contemporanei. Di ogni opera viene pubblicata una sintesi estesa in lingua italiana, redatta in modo accurato e completo, consentendo al lettore di acquisire tutti i concetti fondamentali dell’opera.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale. Un patrimonio editoriale in continua espansione, utile per studiosi, professionisti, decisori e lettori interessati ad avere una panoramica aggiornata e approfondita del pensiero contemporaneo su scala globale.
"Conservation Biology. Foundations, Concepts, Applications" di Fred Van Dyke e Rachel L. Lamb
Fred Van Dyke e Rachel L. Lamb sono gli autori della terza edizione di "Conservation Biology. Foundations, Concepts, Applications", un manuale che si propone di offrire una visione integrata e sistematica della biologia della conservazione, non come semplice somma di competenze specialistiche, ma come disciplina coerente fondata su concetti, teorie e valori condivisi. Il testo si presenta come una guida metodica all’azione conservativa, fondata su basi scientifiche solide, ma anche consapevole delle implicazioni etiche, sociali, legali ed economiche. L’opera è costruita intorno a un nucleo scientifico centrale – comprendente genetica, ecologia di popolazione, studio degli habitat ed ecosistemi – che viene però esplicitamente "circondato" da analisi sui contesti storici, concettuali, antropologici e normativi che ne condizionano l'efficacia. La struttura del libro riflette tale impianto: le prime quattro sezioni inquadrano il significato e l’evoluzione del pensiero conservazionista; segue un blocco centrale di cinque capitoli dedicato al nucleo biologico della conservazione; infine, vengono esplorate le interazioni tra etica, politica, diritto e sviluppo economico. L’ultimo capitolo introduce il tema della conservazione come vocazione personale. Gli autori insistono nel sottolineare che la conservazione non è un’attività moralmente neutra, ma una scelta intenzionale finalizzata a perseguire obiettivi giudicati "buoni", come la tutela della biodiversità. In questa prospettiva, il libro si propone di fornire strumenti teorici e applicativi per rendere tali obiettivi raggiungibili, ma anche per orientare l’azione all’interno di contesti sociali, istituzionali e culturali eterogenei. È in questo senso che l’opera rappresenta una sintesi articolata tra scienza, valori e pratiche operative.
"Japan Prepares for Total War. The Search for Economic Security, 1919–1941" di Michael A. Barnhart
Michael A. Barnhart, storico specializzato in relazioni internazionali e storia giapponese, ha pubblicato nel 1987 presso la Cornell University Press il volume Japan Prepares for Total War. The Search for Economic Security, 1919–1941, con l’intento di chiarire i meccanismi attraverso cui l’élite politico-militare giapponese ha trasformato il concetto di “sicurezza economica” in una strategia sistemica di mobilitazione totale e, infine, in un impulso imperialistico culminato nel conflitto con gli Stati Uniti. Il libro si concentra sul periodo compreso tra la fine della Prima guerra mondiale e l’inizio della Guerra del Pacifico, analizzando con precisione l’intreccio tra preparazione bellica, politica interna, ambizioni imperiali e crisi economiche. Barnhart mette in evidenza come la convinzione giapponese che "future wars would be long and grueling" ("le guerre future sarebbero lunghe e logoranti") abbia spinto il paese verso una progressiva militarizzazione dell’economia e una strategia di autarchia. L’opera si distingue per l’uso incrociato di fonti d’archivio statunitensi e giapponesi, nonché per l’attenzione metodica ai conflitti interni tra esercito, marina, burocrazia civile e classe politica. Il tema della sicurezza economica è sviluppato come chiave interpretativa della trasformazione del Giappone da potenza revisionista a potenza aggressiva, in una traiettoria segnata da decisioni strategiche progressive, non predeterminate ma determinate da contingenze e negoziazioni.
"Total Defense. The New Deal and the Invention of National Security" di Andrew Preston
Andrew Preston, docente di storia americana all’Università di Cambridge, propone in questo volume una riconsiderazione complessiva della genesi dell’idea di “sicurezza nazionale” negli Stati Uniti, mettendo al centro l’esperienza del New Deal e le trasformazioni politiche, istituzionali e concettuali degli anni Trenta e Quaranta. Total Defense non è una storia militare né un’analisi delle politiche strategiche nel senso classico; è piuttosto un’indagine storico-politica sul modo in cui lo Stato americano ha costruito, a partire dal New Deal, un concetto espanso e strutturato di sicurezza, in cui la distinzione tra difesa interna ed esterna, tra minaccia sociale e minaccia militare, viene progressivamente superata. Preston sostiene che fu proprio la cultura politica del New Deal a generare l’impulso verso una concezione integrata della sicurezza, in cui economia, società, amministrazione e difesa venivano viste come parti di un unico insieme. Il libro ricostruisce tale processo attraverso l’analisi delle pratiche di governo, delle politiche pubbliche, dei discorsi ufficiali e della trasformazione dell’amministrazione federale tra gli anni ’30 e la guerra fredda, offrendo un contributo rilevante alla storia intellettuale e istituzionale degli Stati Uniti.
"Why We Teach Science (and Why We Should)" di John L. Rudolph
John L. Rudolph, docente all’Università del Wisconsin-Madison e specialista in storia e didattica delle scienze, affronta in Why We Teach Science (and Why We Should) una questione centrale per i sistemi educativi contemporanei: le vere ragioni per cui la scienza viene insegnata nella scuola dell’obbligo e i motivi per cui, a suo avviso, tale insegnamento andrebbe profondamente ripensato. L’opera muove da un duplice interrogativo: quali scopi si attribuiscono all’educazione scientifica e se tali obiettivi vengano effettivamente perseguiti nella pratica. Il testo è diviso in tre sezioni. Nella prima l’autore ricostruisce le ragioni storicamente addotte per giustificare l’insegnamento delle scienze. Nella seconda analizza come si insegna realmente oggi. Nella terza propone un nuovo orientamento, incentrato sulla costruzione del rapporto tra scienza e società in una democrazia. La sua tesi è che l’enfasi attuale sulla preparazione tecnica e sul trasferimento di contenuti disciplinari abbia fallito, e che occorra invece formare cittadini in grado di comprendere il ruolo pubblico della scienza e di riporre fiducia in essa. La proposta consiste in un insegnamento centrato non sulle nozioni, ma sulla comprensione di come la scienza produce conoscenza e di come opera come istituzione nella società.