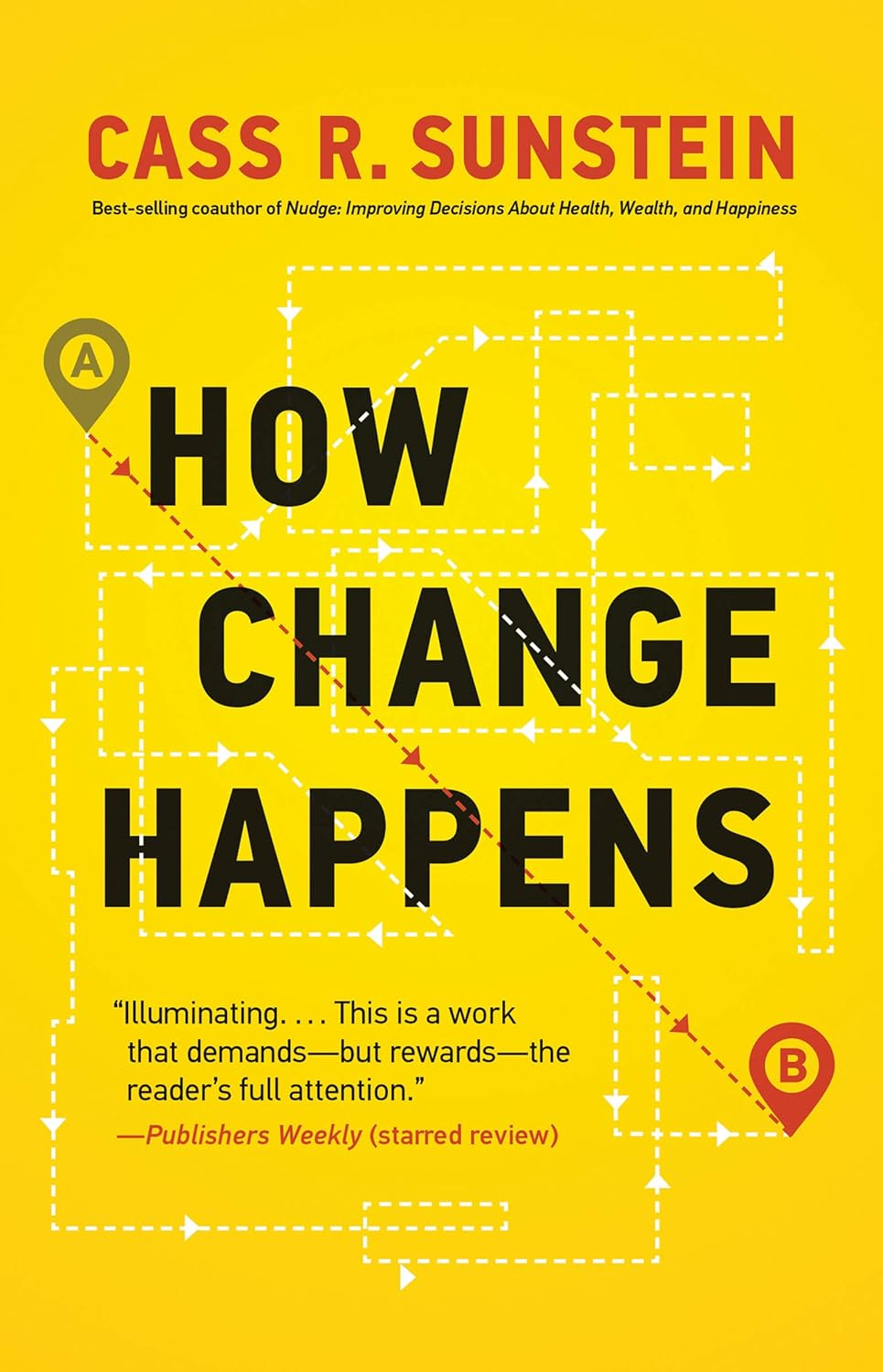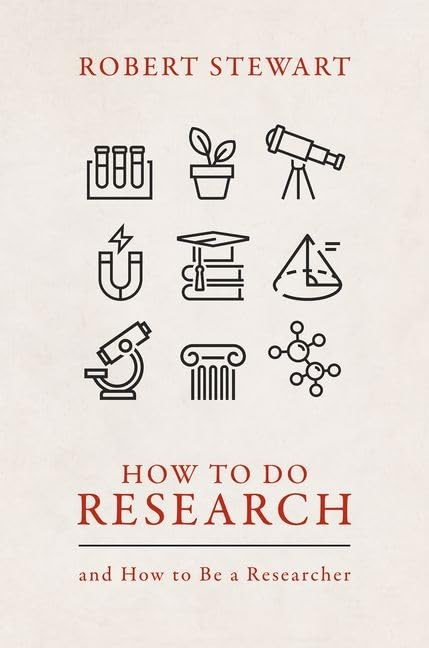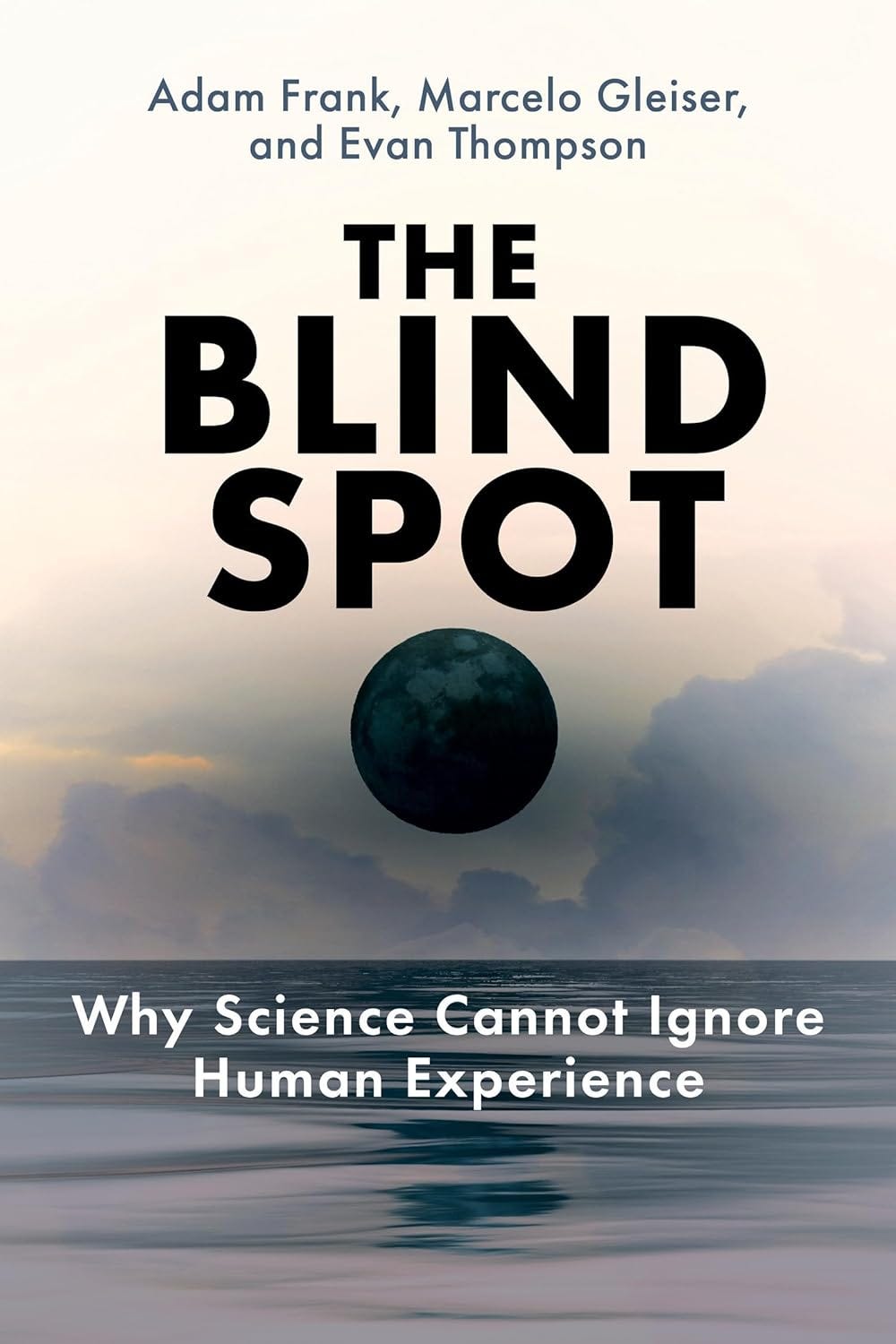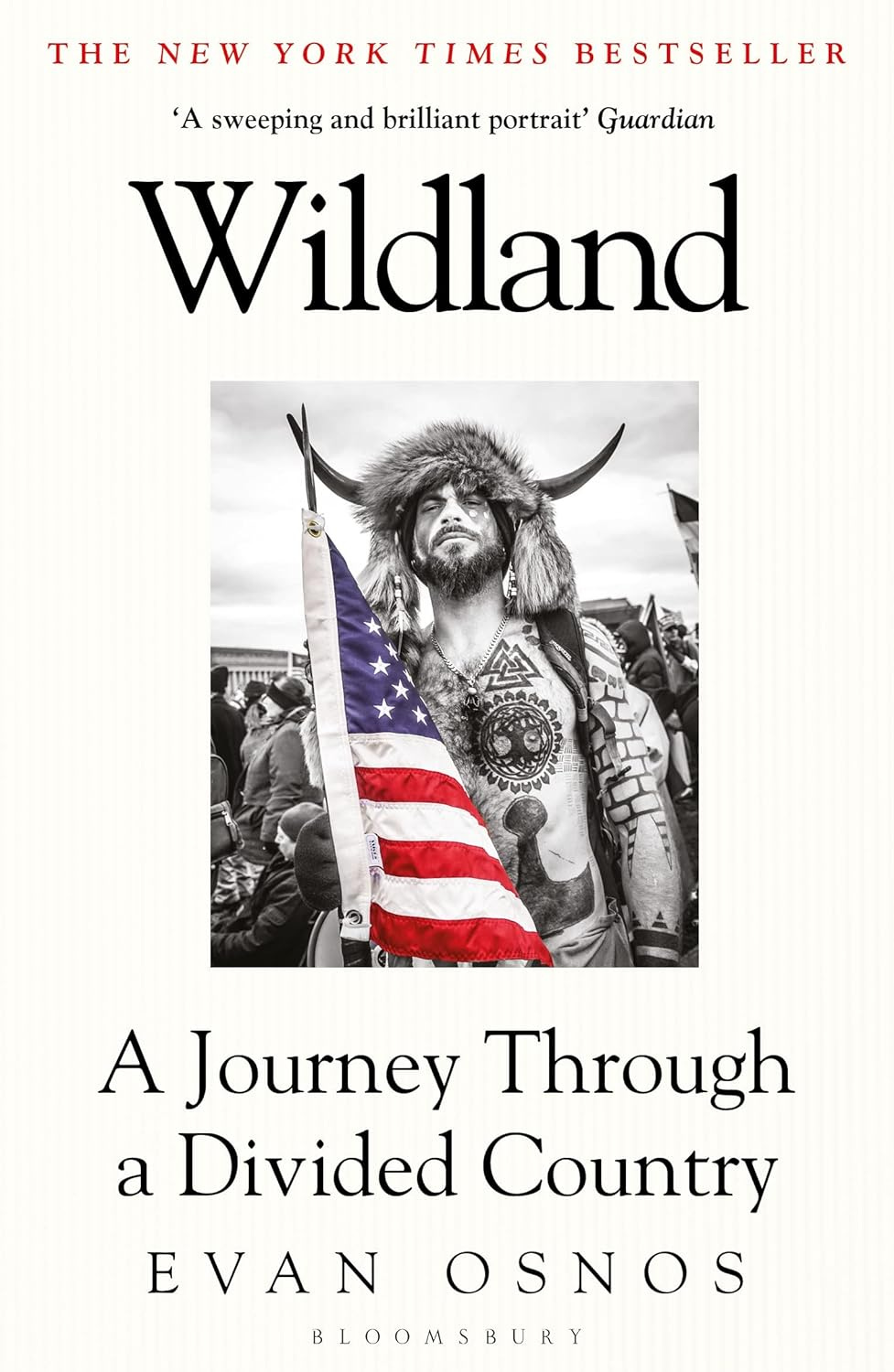Punti cardinali #5
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Ogni settimana vengono monitorate in modo sistematico le novità editoriali delle principali case editrici internazionali, con copertura delle aree linguistiche più rilevanti.
L’obiettivo di Punti Cardinali è offrire agli abbonati di Stroncature l’accesso diretto e sistematico alla saggistica più rilevante pubblicata a livello mondiale, indipendentemente dalla lingua e dalla disponibilità sul mercato editoriale italiano. Attraverso un monitoraggio sistematico delle principali case editrici internazionali, vengono selezionati i volumi più significativi per l’analisi dei grandi processi politici, economici, tecnologici e sociali contemporanei. Di ogni opera viene pubblicata una sintesi estesa in lingua italiana, redatta in modo accurato e completo, consentendo al lettore di acquisire tutti i concetti fondamentali dell’opera.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale. Un patrimonio editoriale in continua espansione, utile per studiosi, professionisti, decisori e lettori interessati ad avere una panoramica aggiornata e approfondita del pensiero contemporaneo su scala globale.
"How Change Happens" di Cass R. Sunstein
Cass R. Sunstein, docente di diritto alla Harvard Law School ed esperto di behavioral economics, è autore del volume How Change Happens, un’opera che si propone di spiegare i meccanismi attraverso cui si verificano mutamenti sociali, giuridici e normativi, spesso in modo improvviso ma non privo di struttura. Il libro indaga come si formano, si consolidano e si modificano le norme sociali, come agisce l’influenza dei gruppi e quale ruolo abbiano la legge, l’informazione, i nudge e le architetture della scelta nei processi di trasformazione collettiva. L’opera adotta un’impostazione interdisciplinare, intrecciando analisi giuridica, teoria del comportamento, scienze sociali e filosofia politica, per comprendere in che modo le opinioni individuali si trasformano in comportamenti collettivi, come si generino le cosiddette “cascate” normative o informative, e quale responsabilità abbiano gli attori pubblici e privati nella costruzione o nella dissoluzione dei sistemi normativi. L’autore articola il suo argomento intorno al concetto centrale di norm entrepreneurship, mostrando come i mutamenti sociali possano essere attivati o inibiti da azioni strategiche, spesso non coordinate, che agiscono sulle aspettative e sugli incentivi alla conformità o alla disobbedienza.
"How to Do Research and How to Be a Researcher" di Robert Stewart
Il libro How to Do Research and How to Be a Researcher di Robert Stewart affronta in modo diretto, essenziale e privo di retorica le principali questioni che definiscono il lavoro intellettuale del ricercatore, dai fondamenti teorici ai vincoli pratici che accompagnano ogni attività scientifica. L’autore si rivolge a un pubblico ampio, includendo chi è all’inizio del percorso e chi ha già maturato esperienza, con l’obiettivo di chiarire cosa significhi realmente fare ricerca e cosa comporti essere un ricercatore. Il testo non adotta una prospettiva disciplinare specifica, ma si propone come guida trasversale, utile tanto a chi opera nelle scienze sperimentali quanto a chi lavora in ambito umanistico o sociale. L’intento dichiarato è quello di restituire una visione realistica, consapevole delle contraddizioni e delle condizioni materiali in cui la ricerca viene svolta. Stewart rifiuta qualsiasi idealizzazione del sapere scientifico, sottolineando come molti progressi derivino da contingenze, errori o risultati inattesi. Fin dall’inizio, l’autore invita a considerare la ricerca non come una pratica superiore o distinta dalla realtà, ma come una delle forme attraverso cui l’essere umano cerca di orientarsi nel mondo, pur con strumenti sempre parziali. “There is a tendency for academics to portray the quest for knowledge as a high and noble endeavour […] However, in reality a lot of advances come from accidental findings”, scrive, sottolineando il carattere imprevedibile e spesso accidentale del processo conoscitivo.
"The Blind Spot. Why Science Cannot Ignore Human Experience" di Adam Frank, Marcelo Gleiser e Evan Thompson
Il volume The Blind Spot, scritto da Adam Frank, Marcelo Gleiser ed Evan Thompson e pubblicato dal MIT Press nel 2024, è un saggio filosofico-interdisciplinare che indaga le radici e le conseguenze di un problema strutturale insito nella moderna visione scientifica del mondo. Il titolo del libro rimanda a una metafora centrale: come nel campo visivo vi è un punto cieco che impedisce di vedere ciò che è alla base del vedere stesso, così nella scienza contemporanea esiste un punto cieco che oscura ciò da cui ogni conoscenza scientifica prende origine, ovvero l’esperienza diretta del soggetto conoscente. Gli autori non si pongono in opposizione alla scienza, né ne negano i successi, ma ne contestano un impianto filosofico implicito, un insieme di assunti metafisici che, pur non essendo parte integrante della pratica scientifica, si sono solidificati in una visione del mondo parziale e problematica. Lo scopo dell’opera è dunque duplice: smascherare l’invisibilità del punto cieco e suggerire un ripensamento della scienza che non escluda la dimensione esperienziale, ma la assuma come suo fondamento ineludibile. Il libro si struttura in quattro sezioni (le origini del punto cieco, il cosmo, la vita e la mente, il pianeta), affrontando questioni quali il tempo, la materia, la coscienza, l’intelligenza artificiale e la crisi climatica.
"Wildland: A Journey Through a Divided Country" di Evan Osnos
Evan Osnos, giornalista di lungo corso del New Yorker e vincitore del Premio Pulitzer, ha scritto Wildland: A Journey Through a Divided Country come resoconto di un viaggio attraverso gli Stati Uniti tra il 2016 e il 2021, durante una fase di crescente polarizzazione politica, tensioni razziali, crisi istituzionali e radicalizzazione ideologica. L’autore imposta il testo come una lunga inchiesta narrativa costruita attorno a profili individuali e biografie collettive che riflettono le trasformazioni della società americana. Il libro non adotta un approccio sistematico ma procede per immersione nelle esperienze di cittadini comuni, attivisti, ex politici e imprenditori, intrecciando l’analisi storica con il racconto del presente. L’obiettivo è comprendere da dove provenga la rabbia che ha investito la società americana, come si sia sviluppata e cosa essa significhi per la tenuta della democrazia. Osnos evita tanto la retorica del declino quanto quella del riscatto, preferendo una ricostruzione concreta delle dinamiche che hanno spinto un numero crescente di americani a sentirsi esclusi, traditi o pronti alla rivolta. L’opera si sviluppa seguendo una logica geografica e biografica, attraversando luoghi simbolici della crisi americana – come il West Virginia, il Connecticut e l’Illinois – e utilizzando storie personali come lenti attraverso cui leggere trasformazioni sistemiche. Non si tratta di un reportage impressionistico né di una tesi ideologica: Osnos cerca di far emergere il significato profondo delle scelte politiche, degli atteggiamenti sociali e delle forme di disillusione che hanno accompagnato l’ascesa di Trump, l’emergere del suprematismo bianco, la sfiducia nelle istituzioni, e l’erosione della fiducia reciproca fra cittadini. L’impianto del libro è quello di un’inchiesta civile che intende contribuire a comprendere non solo il presente americano, ma anche i rischi che corre una democrazia quando viene sistematicamente corrotta dalla diseguaglianza economica, dall’informazione manipolata e dall’identitarismo esasperato.