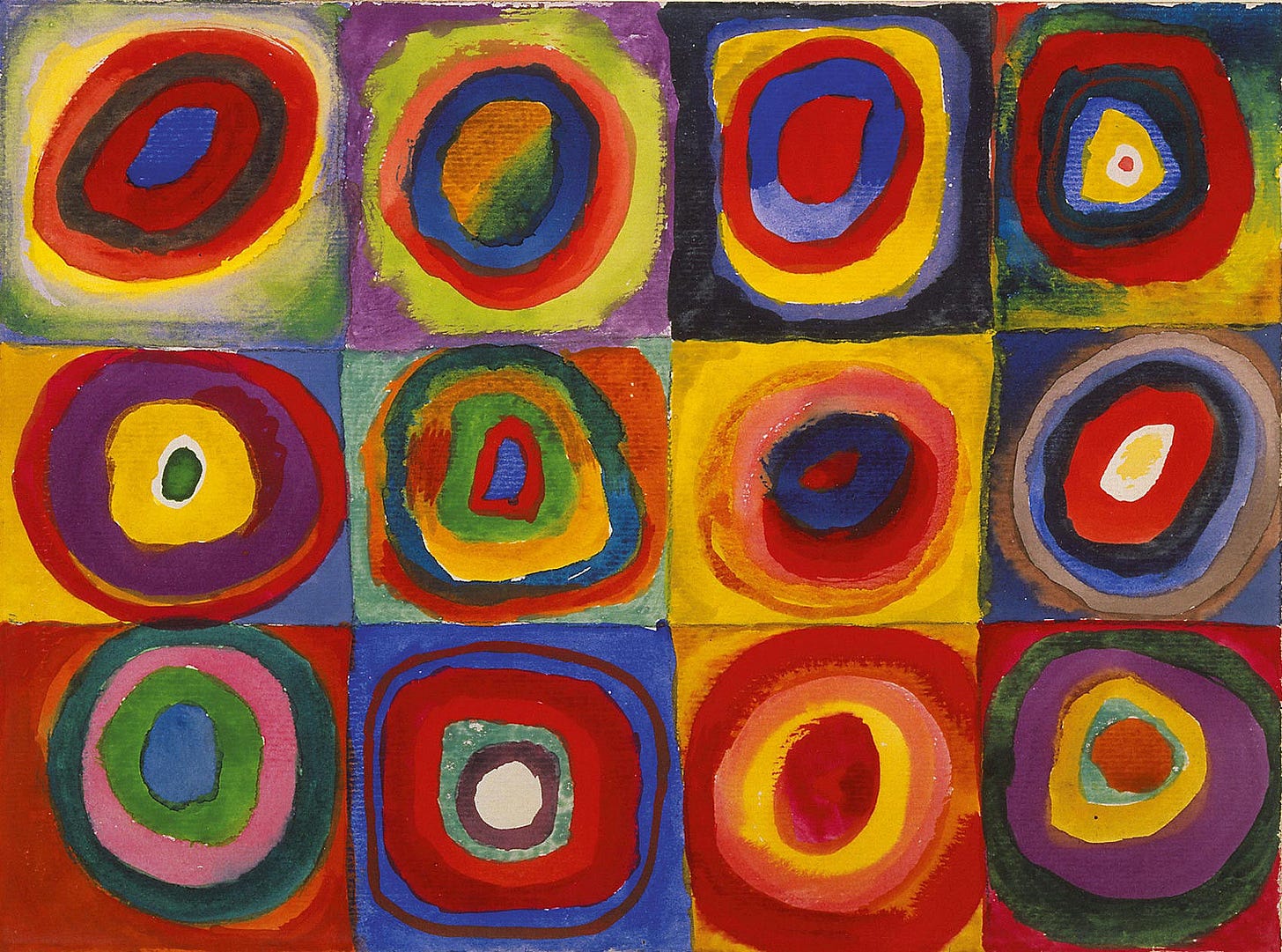Risparmio e prospettiva intergenerazionale: tempo, equilibrio e sostenibilità costituzionale
Il presente articolo è tratto dal saggio scientifico Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione della professoressa Camilla Buzzacchi, direttrice del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) e dell’Osservatorio DI.PAB dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato nel 2025 sulla rivista Dialoghi di Diritto dell’Economia (fascicolo 1/2025, pp. 285–302). La rielaborazione, curata da Stroncature nell’ambito della partnership per la Terza Missione con il Di.SEA.DE, ha lo scopo di rendere accessibile a un pubblico più ampio un tema di grande rilievo costituzionale ed economico: il ruolo del risparmio nella Costituzione italiana e nella tenuta del sistema economico e sociale del Paese. L’iniziativa si inserisce nel programma di Stroncature dedicato alla valorizzazione della ricerca universitaria attraverso attività di divulgazione culturale, che comprendono la pubblicazione di articoli, la produzione di contenuti multimediali e l’organizzazione di momenti di confronto aperti alla cittadinanza.
Il risparmio non è soltanto una pratica economica legata alla prudenza individuale, ma rappresenta un ponte tra presente e futuro, tra generazioni che si susseguono e condividono lo stesso orizzonte di vita collettiva. Ogni accantonamento di risorse, infatti, non produce effetti esclusivamente immediati, ma incide sulla possibilità di affrontare bisogni futuri, di sostenere la crescita del Paese e di garantire stabilità sociale. Questo carattere intertemporale del risparmio lo rende particolarmente rilevante in chiave costituzionale, perché si inserisce in una prospettiva di lungo periodo in cui i diritti dei cittadini di oggi si intrecciano con quelli di domani. L’articolo 47, che incoraggia e tutela il risparmio, non si limita a proteggere l’interesse privato di chi conserva il proprio reddito, ma richiama implicitamente la necessità di garantire continuità e sostenibilità al sistema economico e sociale nel suo complesso. In questo senso, il risparmio diventa un fattore di equilibrio, capace di collegare generazioni diverse attraverso un filo di responsabilità condivisa.
Il risparmio si configura anzitutto come strumento di trasferimento intertemporale delle risorse. Ciò significa che permette di rinviare una parte dei consumi dal presente al futuro, assicurando così la possibilità di affrontare eventi incerti, investire in progetti di lungo termine e sostenere la crescita collettiva. Questa funzione di garanzia intertemporale va ben oltre l’interesse del singolo, perché contribuisce alla stabilità del sistema economico. Senza risparmio, lo Stato e le imprese si troverebbero prive di risorse interne per finanziare investimenti, dovendo ricorrere in misura eccessiva a capitali esterni o all’indebitamento. La Costituzione riconosce questo ruolo centrale, trasformando il risparmio in un bene che ha natura sia privata sia collettiva. La sua protezione non serve solo a preservare patrimoni individuali, ma a garantire la continuità delle funzioni economiche che consentono a una società di trasmettere alle generazioni future condizioni di vita almeno equivalenti, se non migliori, rispetto a quelle presenti.
La questione intergenerazionale assume un rilievo ancora maggiore se si considerano i mutamenti demografici. L’invecchiamento della popolazione e l’ingresso tardivo nel mercato del lavoro stanno modificando profondamente le dinamiche del risparmio. Da un lato, l’allungamento della vita media richiede risorse più consistenti per affrontare gli anni della pensione e i crescenti bisogni di assistenza sanitaria. Dall’altro, l’instabilità lavorativa e i ritardi nell’inizio della carriera professionale riducono la capacità dei giovani di accantonare per il futuro. Questo squilibrio genera pressioni sul sistema previdenziale e mette in discussione il patto tra generazioni. La Costituzione, tutelando il risparmio, invita a considerare queste trasformazioni come elementi che devono orientare politiche pubbliche capaci di rafforzare la solidarietà tra età diverse, evitando che i costi degli squilibri ricadano solo su una parte della società. Il risparmio, in questo senso, diventa anche strumento di giustizia intergenerazionale.
Il legame tra risparmio e previdenza costituisce una delle espressioni più chiare della sua funzione orientata al futuro. I sistemi pensionistici pubblici e privati, infatti, si fondano sull’idea di accantonare oggi risorse per garantirsi un reddito domani. Anche in questo caso, il risparmio assume una dimensione collettiva: i contributi previdenziali obbligatori sono forme istituzionalizzate di risparmio, finalizzate a tutelare non solo il singolo lavoratore, ma l’intero equilibrio sociale. L’articolo 47 deve essere letto in connessione con l’articolo 38, che riconosce il diritto dei cittadini a mezzi adeguati per vivere in caso di vecchiaia o inabilità. La protezione del risparmio, dunque, non riguarda solo il denaro depositato nei conti correnti o investito nei mercati, ma si estende a tutte le forme di accumulo destinate a garantire sicurezza nel tempo. La previdenza rappresenta così un campo privilegiato in cui il risparmio mostra la sua doppia natura: strumento individuale di protezione e garanzia collettiva di coesione sociale.
La dimensione costituzionale del risparmio è stata rafforzata dalla revisione del 2022, che ha introdotto il riferimento alla responsabilità verso le generazioni future. Questo cambiamento offre una chiave interpretativa che valorizza ulteriormente l’articolo 47, collocandolo in una prospettiva temporale ampia. La tutela del risparmio non può essere concepita come un obiettivo isolato, ma deve integrarsi con l’esigenza di assicurare sostenibilità e continuità nel lungo periodo. Ciò significa che le politiche pubbliche devono tener conto non solo della protezione immediata dei risparmiatori, ma anche degli effetti che le scelte odierne avranno sulle generazioni che verranno. La Costituzione invita dunque a interpretare il risparmio come responsabilità collettiva, che lega il presente al futuro e che richiede di evitare pratiche miopi o orientate solo al breve termine. La sua tutela si traduce così in un impegno intergenerazionale che riguarda tutti i cittadini.
I rischi di squilibrio emergono con evidenza quando il risparmio non viene adeguatamente tutelato o indirizzato. Se i cittadini non hanno la possibilità di accantonare risorse sufficienti, i costi della sicurezza economica si scaricano inevitabilmente sulle generazioni successive, che si trovano a sostenere oneri aggiuntivi per il welfare o il debito pubblico. Allo stesso modo, politiche che favoriscono un risparmio speculativo o mal regolato possono generare crisi che compromettono il futuro di interi settori sociali. La Costituzione, ponendo al centro la tutela del risparmio, richiama implicitamente la necessità di politiche lungimiranti che evitino di trasferire squilibri e fragilità da una generazione all’altra. L’equilibrio intergenerazionale non è quindi un obiettivo secondario, ma una condizione essenziale per garantire che il risparmio continui a svolgere la sua funzione di stabilità e di giustizia sociale, senza trasformarsi in strumento di diseguaglianza o precarietà.
Infine, la prospettiva di lungo periodo permette di collocare la tutela del risparmio in un quadro più ampio, che comprende politiche sul tempo come la ricerca scientifica, la sostenibilità ambientale e la previdenza. Tutte queste dimensioni condividono la stessa logica: l’impegno a trasferire alle generazioni future un patrimonio di risorse, conoscenze e condizioni di vita che consenta loro di affrontare le sfide del domani. Il risparmio, in questo senso, non è un elemento isolato, ma parte di una più ampia strategia costituzionale che guarda al futuro come orizzonte imprescindibile. L’articolo 47, letto in questa chiave, non è una norma del passato, ma un richiamo costante a pensare il presente in funzione del domani. Solo interpretato così, esso può continuare a offrire un contributo decisivo alla sostenibilità economica e sociale del Paese, rafforzando il legame tra tempo, equilibrio e responsabilità intergenerazionale.