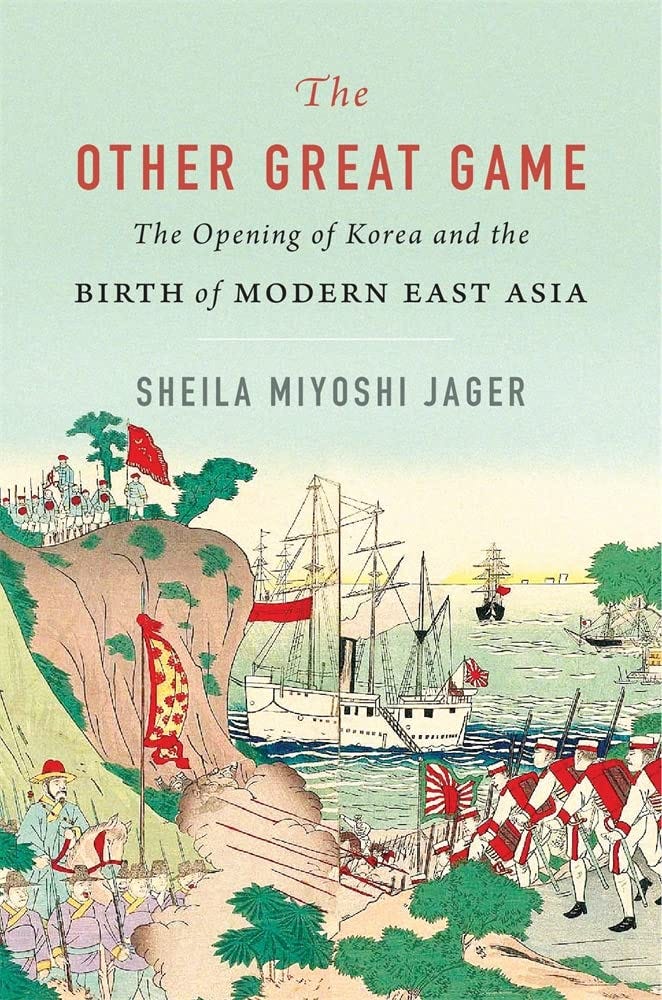"The Other Great Game. The Opening of Korea and the Birth of Modern East Asia" di Sheila Miyoshi Jager (Harvard University Press, 2023)
1. Introduzione generale al libro, al tema e all’impianto analitico
The Other Great Game (Harvard University Press, 2023) di Sheila Miyoshi Jager ricostruisce la trasformazione dell’Asia orientale tra metà Ottocento e primi anni del Novecento, concentrandosi sul ruolo della Corea come punto di intersezione tra Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti e potenze europee. Il volume sviluppa una tesi chiara: la nascita dell’ordine internazionale moderno in Asia non può essere compresa senza analizzare la competizione per la penisola coreana, vero motore dei conflitti regionali e delle riconfigurazioni geopolitiche che portarono alla fine dell’ordine sinocentrico confuciano e all’emergere di nuove potenze asiatiche. L’autrice definisce “moderno” l’ordine asiatico come transizione verso un sistema di Stati sovrani di tipo westfaliano, superando il sistema gerarchico dell’Impero cinese. In questo quadro, l’“apertura” della Corea non viene interpretata come un processo imposto dall’esterno, ma come un percorso complesso in cui gli attori coreani ebbero ruolo attivo. La struttura del libro segue uno sviluppo cronologico che parte dall’avanzata russa verso il Pacifico, attraversa le crisi diplomatiche tra Cina, Giappone e Russia, analizza le guerre del 1894–1895 e del 1904–1905, e si conclude con l’annessione della Corea al Giappone e con le eredità lasciate da questi eventi. Jager insiste sul fatto che il periodo 1876–1910 rappresenta un momento di trasformazione paragonabile, per impatto e conseguenze, ai grandi rivolgimenti europei dello stesso secolo: la presenza russa in Manciuria, il ridimensionamento cinese dopo le guerre dell’oppio, l’espansione giapponese e l’ingresso degli Stati Uniti come potenza del Pacifico contribuiscono a un quadro in cui la Corea non è semplice vittima, ma catalizzatore di processi continentali e globali. L’opera alterna analisi geopolitica, ricostruzione militare dettagliata e studio dei processi decisionali delle élite dei quattro principali protagonisti asiatici, con l’obiettivo di mostrare come le rivalità per il controllo della penisola abbiano segnato la formazione dell’Asia moderna.
2. Le origini del problema coreano: declino dell’ordine confuciano e avanzata russa
Il libro si apre con una ricostruzione dell’espansione russa in Asia orientale, sottolineando come la conquista della Siberia, il consolidamento sul Pacifico e la progressiva pressione su Manciuria e Corea abbiano avuto un ruolo cruciale nella destabilizzazione dell’ordine tradizionale cinese. Il prologo dedica ampio spazio all’eredità delle invasioni mongole e della dominazione tatara, evidenziando come la Russia imperiale costruì la propria identità anche attraverso un confronto costante con le potenze asiatiche. L’avanzata verso l’Est, culminata tra il 1858 e il 1860 con gli accordi che garantirono a San Pietroburgo il controllo dell’Amur e del Primor’e, condusse inevitabilmente al contatto diretto con la Corea. Jager insiste sul fatto che questo ingresso fu il vero punto di rottura: non furono solo le navi occidentali a destabilizzare l’ordine sinocentrico, ma la trasformazione degli equilibri regionali provocata dall’improvvisa vicinanza tra Russia e Corea. L’autrice richiama episodi storici che dimostrano come la penisola coreana, nei secoli precedenti, fosse già stata teatro di invasioni devastanti: le campagne mongole, le due spedizioni contro il Giappone nel XIII secolo, l’invasione giapponese di Hideyoshi (1592–1598) e le incursioni mancesi culminate con l’invasione del 1636. Questo lungo passato di vulnerabilità aveva consolidato una cultura politica fortemente orientata alla chiusura e alla prudenza diplomatica, che però risultò inefficace nel contesto dell’Ottocento, quando gli equilibri tradizionali erano già compromessi dal declino della Cina Qing. Jager utilizza questo sfondo storico per spiegare come la Corea, nel XIX secolo, si trovò esposta a una pressione militare, politica ed economica senza precedenti, generando una reazione a catena che avrebbe coinvolto tutte le potenze dell’area.
3. Corea, Cina e Giappone: un sistema in trasformazione prima del 1876
Il primo capitolo dedicato all’Ottocento coreano analizza la situazione interna della dinastia Chosŏn dopo le guerre del XVI e XVII secolo. L’autrice sottolinea che la scelta coreana della seclusione non era un tratto culturale immutabile, ma una risposta a specifiche minacce storiche e geografiche. La Corea aveva mantenuto per secoli una relazione stretta con la Cina, concepita come potenza protettrice nell’ambito del sistema tributario. Con l’indebolimento cinese a seguito delle guerre dell’Oppio, questa relazione divenne fonte di incertezza. Jager mostra come la Cina Qing fosse ancora percepita come un punto di riferimento, ma sempre meno capace di garantire sicurezza. Parallelamente, il Giappone viveva la transizione della Restaurazione Meiji, e guardava alla Corea come elemento indispensabile per la propria sicurezza strategica e per il consolidamento del nuovo Stato moderno. Documenti citati dall’autrice, come memoriali politici e rapporti diplomatici dell’epoca, mostrano come già negli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento i leader giapponesi considerassero la penisola una minaccia se controllata da potenze ostili. La Corea, dal canto suo, reagiva alle pressioni mantenendo la linea della seclusione, celebrando come “vittorie” i rari episodi in cui riusciva a respingere incursioni straniere, come nel caso della spedizione francese del 1866 e dell’episodio della nave statunitense General Sherman nel 1871. Ma questi successi, osserva Jager, diedero l’illusione che la chiusura fosse ancora sostenibile, mentre in realtà la situazione internazionale stava cambiando rapidamente e irreversibilmente. L’autrice insiste sulla dinamica interna coreana: divisioni tra fazioni, tensioni tra modernizzatori e conservatori, e debolezza delle istituzioni resero il Paese incapace di reagire efficacemente alle pressioni esterne.
4. Il trattato di Kanghwa del 1876 e l’avvio della trasformazione
Il 1876 rappresenta un punto di svolta decisivo: sotto la minaccia delle cannoniere giapponesi, la Corea firma il Trattato di Kanghwa, che riconosce la sua piena indipendenza, attribuendo però al Giappone una posizione privilegiata. Jager mostra come questo riconoscimento dell’indipendenza fosse in realtà funzionale alla strategia giapponese: separare giuridicamente la Corea dalla Cina, indebolendo il quadro tributario tradizionale. Il trattato aprì porti coreani al commercio estero, introdusse regole diplomatiche moderne e impose una logica paritaria che scardinava l’ordine gerarchico sino-coreano. L’autrice sottolinea che l’“apertura” non significò semplice accesso commerciale, ma trasformazione profonda dei rapporti di potere regionali. La Cina percepì il trattato come un attacco al proprio ruolo storico sulla penisola e reagì attivando una nuova politica diplomatica, formalizzata nel celebre memoriale di Huang Zunxian del 1880, nel quale si delineava una strategia per proteggere la Corea dal rischio di cadere sotto controllo russo. La proposta includeva il rafforzamento dell’alleanza con la Cina, la cooperazione con il Giappone e l’apertura a relazioni con gli Stati Uniti. Questa “strategia per la Corea”, riportata testualmente nel libro, evidenziava il timore crescente che l’espansione russa rendesse urgente un ripensamento del sistema regionale. La Corea, tuttavia, era divisa al proprio interno: le élite non condividevano una visione comune su come reagire, e la fragilità interna divenne un fattore strutturale che Jager considera centrale nell’intera vicenda.
5. La Cina dei Qing e la nuova competizione diplomatica per la Corea
La sezione dedicata alla politica cinese nei confronti della Corea mostra come la dinastia Qing tentò di riformulare la relazione tributaria in senso più moderno, cercando di adattare antichi principi alle nuove logiche della politica internazionale occidentale. Jager analizza in dettaglio la dottrina del “controllare i barbari con i barbari”, reinterpretata da Huang Zunxian per promuovere un equilibrio di potere tra le potenze interessate alla penisola. La Cina, pur indebolita, tentò di mantenere un ruolo attivo inviando truppe a Seoul in seguito alla rivolta militare del 1882 e assumendo responsabilità operative che andavano oltre il tradizionale non intervento. Questo intervento segnò, secondo Jager, l’inizio della fine del sistema tributario: nel momento stesso in cui la Cina si comportava come una potenza coloniale protettrice, violava la logica tradizionale della relazione con la Corea. Il Giappone rispose con una presenza militare crescente, mentre la Russia osservava attentamente, pronta a intervenire. L’autrice evidenzia come questo periodo – tra 1880 e 1890 – fosse caratterizzato da un triangolo instabile: Cina, Giappone e Russia cercavano di stabilire la propria influenza sulla Corea, mentre quest’ultima diventava sempre più il centro delle manovre, non un attore passivo ma un terreno sul quale diverse fazioni coreane cercavano di sfruttare l’una o l’altra potenza per rafforzare la propria posizione interna. L’effetto cumulativo di queste dinamiche, nota Jager, fu la progressiva militarizzazione della questione coreana, preludio alla guerra del 1894–1895.
6. Verso la guerra: rivalità sino-giapponese, crisi coreane e crescita dell’interesse russo
Il libro dedica un’attenzione molto ampia alle dinamiche che condussero alla Prima guerra sino-giapponese, sottolineando come la Corea fosse al centro non solo di un confronto diplomatico, ma anche di un conflitto interno che rifletteva tensioni di lungo periodo. Il movimento Tonghak del 1894, nato come protesta religiosa e sociale contro corruzione e ingerenze straniere, esplose in un momento in cui Cina e Giappone erano pronte a intervenire militarmente. La Cina inviò truppe su richiesta della corte coreana; il Giappone rispose inviando un contingente più ampio e assumendo il controllo della capitale. Jager ricostruisce con dovizia di dettagli le fasi di escalation, mostrando come entrambi i Paesi considerassero il controllo della Corea essenziale per la propria sicurezza strategica. La Russia, nel frattempo, avanzava la costruzione della ferrovia transiberiana, progetto destinato a modificare radicalmente gli equilibri in Manciuria e Corea, e osservava con crescente attenzione il deterioramento dei rapporti tra Pechino e Tokyo. Questa fase, secondo l’autrice, rivela la natura sistemica del conflitto: la Corea non era più solo un territorio conteso, ma l’elemento che metteva in relazione modelli diversi di potere. La Cina tentava di preservare un ordine tradizionale in declino; il Giappone perseguiva una transizione rapida verso la modernità politico-militare; la Russia cercava sbocchi verso mari caldi e porti strategici; gli Stati Uniti iniziavano a riconsiderare il proprio ruolo nell’area, in nome dei principi commerciali della dottrina dell’Open Door. Tutti questi fattori confluirono nella guerra del 1894–1895, che segnò l’ingresso violento dell’Asia orientale nell’età degli imperialismi moderni.
7. La Prima guerra sino-giapponese e il crollo dell’ordine tributario
Jager dedica un’ampia sezione alla Prima guerra sino-giapponese (1894-1895), descrivendone non solo la dinamica militare, ma soprattutto il significato geopolitico. La guerra nasce formalmente dal caos interno coreano, ma l’autrice mostra come fosse in realtà l’esito inevitabile di due strategie opposte: da un lato la Cina, che cercava di preservare la sua posizione privilegiata sulla penisola, dall’altro il Giappone, che considerava la Corea un elemento essenziale della propria sicurezza e del proprio progetto di trasformazione nazionale. La narrazione dei combattimenti è accurata, ricca di dettagli sulle manovre, sugli spostamenti di truppe e sul ruolo della marina giapponese nelle battaglie decisive come quella del Fiume Yalu. Il Giappone si presentò al conflitto con un apparato militare modernizzato e ispirato ai modelli occidentali, mentre la Cina, pur numericamente superiore, era ostacolata da corruzione, disorganizzazione e assenza di una strategia coerente. L’esito della guerra fu rapido: la Cina subì una sconfitta schiacciante che segnò il collasso simbolico dell’ordine sinocentrico. Il trattato di Shimonoseki sancì l’indipendenza formale della Corea e attribuì al Giappone Taiwan e la penisola del Liaodong, elementi che conferivano a Tokyo un controllo avanzato sia sui mari sia sulla terraferma. Jager interpreta questo evento come il momento in cui il vecchio sistema tributario cessò definitivamente di avere rilevanza. La Corea cessava di essere un’estensione della Cina e diventava l’oggetto di una competizione internazionale in stile westfaliano, con conseguenze che avrebbero preparato il terreno alla successiva rivalità russo-giapponese.
8. La Triplice Intervento, le riforme coreane e la crisi del sistema regionale
Subito dopo la vittoria giapponese, l’intervento simultaneo di Russia, Francia e Germania costrinse Tokyo a restituire il Liaodong. Jager interpreta la Triplice Intervento del 1895 come uno degli episodi diplomatici più significativi del periodo, perché rivelò il limite strutturale dell’ascesa giapponese e aprì uno spazio inatteso alla Russia, che ottenne un ruolo sempre più rilevante nella penisola e in Manciuria. L’autrice ricostruisce gli effetti psicologici e politici di questo episodio: in Giappone alimentò un profondo risentimento verso le potenze europee e convinse le élite che solo un rafforzamento ulteriore dello Stato e delle forze armate avrebbe potuto garantire l’autonomia strategica del Paese. Allo stesso tempo, il vuoto lasciato dalla Cina e il disorientamento seguito al trattato di Shimonoseki produssero in Corea una stagione di riforme note come le “Riforme Kabo”, che cercarono di modernizzare l’amministrazione, l’esercito e il sistema fiscale. Jager mostra come queste riforme furono profondamente condizionate dall’ingerenza giapponese e dalla progressiva presenza russa. L’assassinio della regina Min da parte di agenti giapponesi, episodio ricostruito nel dettaglio, è presentato come un simbolo della radicalizzazione delle tensioni e del fallimento del tentativo coreano di mantenere un margine di autonomia. L’autrice documenta come la corte di Seoul oscillasse tra appoggiarsi al Giappone o alla Russia, mentre il Paese rimaneva politicamente frammentato e socialmente instabile. L’intervento russo nel palazzo reale e la protezione garantita al re Kojong evidenziarono ulteriormente come la Corea fosse ormai divenuta un teatro aperto in cui le grandi potenze imponevano le proprie priorità strategiche.
9. La Russia in Manciuria: ferrovia, diplomazia e il progressivo confronto con il Giappone
Il libro dedica molto spazio all’espansione russa in Manciuria e alla costruzione della ferrovia transiberiana, interpretata da Jager come una delle trasformazioni infrastrutturali più importanti dell’epoca. La ferrovia non era solo un’opera ingegneristica, ma una piattaforma di potere che permetteva a San Pietroburgo di proiettare forze militari e influenza economica in una regione cruciale. La presenza russa in Manciuria, inizialmente presentata come temporanea dopo la rivolta dei Boxer del 1900, si trasformò rapidamente in occupazione di fatto. Jager analizza con precisione la dinamica diplomatica tra Russia e Cina, il ruolo di Li Hongzhang e l’incapacità dell’impero Qing di contenere l’espansione delle potenze straniere. Questa avanzata produceva inevitabilmente una reazione giapponese: Tokyo temeva che un controllo russo stabile su Manciuria e Corea avrebbe soffocato ogni prospettiva di sicurezza. Documenti e negoziati dell’epoca, riportati nel testo, mostrano come il Giappone cercasse di proporre accordi di delimitazione delle rispettive sfere d’influenza. La Russia rifiutò sistematicamente tali proposte, convinta che la propria superiorità territoriale e militare avrebbe scoraggiato qualunque reazione giapponese. Jager sottolinea che questo errore di valutazione fu decisivo: la Russia non comprese la determinazione giapponese a impedire una minaccia diretta ai confini coreani e non percepì l’effettivo grado di modernizzazione dell’apparato militare nipponico. La tensione latente tra i due imperi si trasformò progressivamente in un conflitto inevitabile.
10. La guerra russo-giapponese: strategia, battaglie e significato storico
La guerra del 1904-1905 rappresenta il cuore del libro e Jager ne offre una narrazione estremamente dettagliata, definendola “World War Zero” per l’ampiezza dei mezzi impiegati, per l’impatto tecnologico e per il valore simbolico del primo conflitto moderno in cui una potenza asiatica sconfisse una potenza europea. La descrizione delle battaglie – Yalu, Port Arthur, Liaoyang, Mukden, Tsushima – è ricca di elementi tattici e di testimonianze sulla vita dei soldati, sugli spostamenti di truppe e sulle condizioni logistiche. L’autrice evidenzia come la guerra segnò un salto qualitativo nella storia militare: l’uso esteso di filo spinato, mitragliatrici, artiglieria pesante e posizioni fortificate anticipava le logiche della Prima guerra mondiale. La Russia si trovò a combattere a migliaia di chilometri dai propri centri industriali, mentre il Giappone combatté su linee di comunicazione corte e con un comando unificato. L’esito fu una serie di vittorie giapponesi che culminarono nella caduta di Port Arthur e nella grande battaglia di Mukden, una delle più grandi battaglie terrestri combattute prima del 1914. La sconfitta russa non fu solo militare ma politica: mise in crisi la stabilità interna dell’impero zarista e aprì la strada alla rivoluzione del 1905. Il trattato di Portsmouth, mediato dagli Stati Uniti, consacrò il ruolo di Tokyo come nuova potenza continentale in Asia orientale e riconobbe la sua posizione dominante sulla Corea. Questo momento, sottolinea Jager, segna il passaggio definitivo della Corea dalla sfera cinese a quella giapponese.
11. Il nuovo ordine dell’Asia orientale: Corea come protettorato e annessione del 1910
Dopo Portsmouth, il Giappone consolidò rapidamente la propria presenza in Corea. Jager descrive la progressiva istituzionalizzazione del controllo giapponese: trattati, “riforme amministrative”, imposizione di consiglieri giapponesi, limitazione dell’autonomia coreana e crescente sorveglianza militare. L’autrice analizza in particolare il ruolo di Itō Hirobumi come Residente Generale, evidenziando come egli tentasse inizialmente un approccio relativamente moderato, volto a rafforzare l’amministrazione coloniale senza annessione immediata. Tuttavia, la resistenza coreana, i conflitti interni, la pressione dei militari giapponesi e la rivalità internazionale portarono rapidamente a un irrigidimento della linea politica. Jager ricostruisce anche la delegazione coreana alla Conferenza dell’Aia del 1907, tentativo disperato di ottenere riconoscimento internazionale che si concluse con un fallimento totale e con l’ulteriore riduzione della sovranità coreana. La crisi culminò nelle dimissioni forzate del re Kojong e nella firma del trattato di annessione del 1910. La Corea cessava di esistere come Stato indipendente e diventava colonia giapponese. L’autrice osserva che questo risultato non fu inevitabile, ma fu il prodotto di una serie di scelte politiche, errori strategici e rivalità internazionali in cui il ruolo della Corea fu sempre attivo ma frequentemente contraddittorio. L’ordine asiatico risultante vedeva il Giappone come potenza dominante, la Cina come semi-colonia, la Russia ridimensionata e gli Stati Uniti come potenza marittima emergente.
12. Le eredità dell’“altro Grande Gioco” e la lunga storia della Corea moderna
Nell’epilogo, Jager collega il periodo 1860-1910 alle dinamiche geopolitiche del XX secolo, mostrando come il conflitto sulla Corea non si chiuse con l’annessione giapponese, ma continuò a svilupparsi sotto nuove forme. La sconfitta russa aprì la strada alla rivoluzione del 1905, l’ascesa giapponese portò alle future tensioni con gli Stati Uniti e l’indebolimento definitivo della Cina aprì la strada al crollo della dinastia Qing nel 1911. L’autrice analizza anche il ruolo delle élite coreane dopo l’annessione, dividendo due percorsi divergenti: i guerriglieri comunisti che operarono in Manciuria e che confluirono poi nel movimento che portò al regime nordcoreano, e la diaspora nazionalista moderata, che formò nel 1919 a Shanghai il Governo Provvisorio della Corea. Jager mostra come la divisione del 1945 e la guerra del 1950 siano parte della stessa lunga traiettoria aperta nel XIX secolo: la Corea è rimasta un nodo strategico e un punto di frizione internazionale. Le ambizioni russe, la protezione americana del Giappone, la rivoluzione cinese e la logica della Guerra fredda si inscrivono in una continuità storica che il libro mette in luce con chiarezza. L’autrice conclude sostenendo che l’Asia orientale moderna nasce da questo lungo “altro Grande Gioco”, nel quale la Corea ebbe un ruolo decisivo non come oggetto passivo, ma come catalizzatore di conflitti, riforme, reazioni e nuove configurazioni del potere regionale.
Sintesi finale
Il libro di Sheila Miyoshi Jager propone una tesi precisa: l’ordine internazionale moderno in Asia orientale nasce dalla competizione per la Corea tra Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti e potenze europee tra il 1860 e il 1910. La Corea non fu un semplice territorio conteso, ma un attore che contribuì attivamente a trasformare il sistema regionale. La tesi centrale è che la caduta dell’ordine confuciano e il passaggio a un sistema westfaliano non derivarono solo dall’arrivo delle potenze occidentali, ma dalla combinazione tra espansione russa, modernizzazione giapponese, declino cinese e frammentazione politica coreana. Jager mostra come la guerra sino-giapponese del 1894-1895 segnò il collasso dell’ordine tributario, mentre la guerra russo-giapponese del 1904-1905 definì il nuovo equilibrio, con il Giappone potenza continentale e gli Stati Uniti potenza marittima emergente. I principali “findings” dell’autrice riguardano: il ruolo decisivo della ferrovia transiberiana e dell’espansione russa; l’importanza delle riforme giapponesi Meiji per la capacità militare di Tokyo; la crisi strutturale dell’impero Qing e la sua incapacità di adattarsi; la natura interna delle lotte coreane, che resero il Paese vulnerabile alle ingerenze straniere. L’analisi mostra anche che la Corea cercò più volte di giocare un ruolo autonomo, ma la divisione delle élite e la pressione esterna impedirono la formazione di una strategia coerente. Il metodo adottato da Jager combina ricostruzione militare, analisi diplomatica e studio dei processi decisionali. La conclusione dell’opera è che la Corea rappresenta la chiave interpretativa dell’Asia moderna e che le tensioni contemporanee nella penisola sono eredità dirette dell’“altro Grande Gioco” del XIX e XX secolo.
Scheda metadati
Autore: Sheila Miyoshi Jager
Titolo in originale: “The Other Great Game. The Opening of Korea and the Birth of Modern East Asia”
Casa editrice: Harvard University Press (The Belknap Press)
Anno di pubblicazione: 2023
Categoria: Storia e archeologia