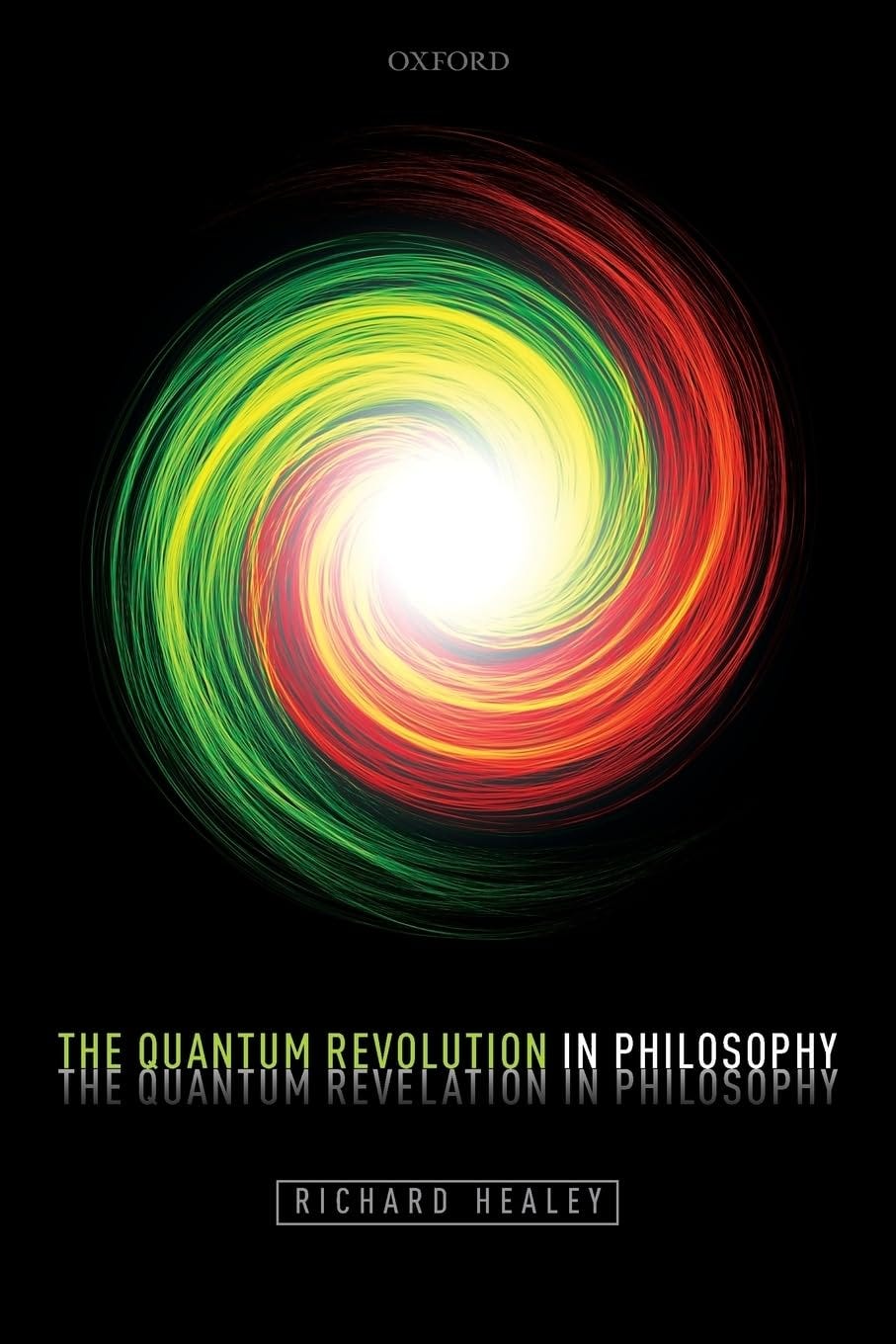I nuovi gatekeeper: come la moderazione automatica riscrive lo spazio pubblico
Nel dibattito pubblico contemporaneo si tende ancora a considerare i social media come spazi di comunicazione liberi e orizzontali, in cui ogni utente può esprimersi, condividere contenuti e raggiungere un pubblico potenzialmente globale. Ma questa rappresentazione è ormai fuorviante. I social non sono infrastrutture neutre: sono architetture computazionali progettate per selezionare, ordinare e mostrare i contenuti in base a logiche interne, spesso opache, determinate da algoritmi proprietari. L’utente non comunica liberamente: l’algoritmo decide in ogni istante chi vedrà cosa, in base a criteri di engagement, profilazione, previsione comportamentale e massimizzazione del tempo di permanenza. In questo quadro, anche la semplice visibilità di un contenuto dipende da una selezione automatica e poco chiare. Post non conformi ai modelli dominanti, oppure ritenuti poco coinvolgenti, sono declassati, resi invisibili, o rimossi in modo definitivo. Il risultato è che la comunicazione non segue più il principio della rilevanza o della qualità, ma quello dell’aderenza ai criteri funzionali della piattaforma stessa.
Il mondo non segue una linea retta: capire come funziona davvero la complessità
La teoria della complessità rappresenta un cambio di paradigma epistemologico nelle scienze contemporanee. Il fisico Stephen Hawking predisse che il XXI secolo sarebbe stato “il secolo della complessità”, riconoscendo l’emergere di un nuovo approccio scientifico trasversale. La scienza della complessità studia sistemi composti da un gran numero di elementi interagenti, i quali danno luogo a sorprendenti fenomeni emergenti su più scale. Questa prospettiva transdisciplinare segna una deviazione dal precedente paradigma riduzionista, abbracciando l’incertezza e la necessità di integrare competenze diverse per affrontare sistemi altamente interconnessi. La visione scientifica tradizionale, di impronta cartesiano-newtoniana, ricercava infatti leggi fondamentali semplici e considerava i fenomeni complessi come sommatoria prevedibile delle parti. La teoria della complessità mette in discussione tale impostazione: il comportamento di un sistema complesso non può essere ricondotto linearmente alle proprietà dei singoli componenti, ma emerge dalle loro interazioni non lineari. In altre parole, la capacità di ridurre ogni fenomeno a leggi elementari non implica la capacità di risalire da quelle leggi al funzionamento dell’insieme. Questa consapevolezza ha spinto, a partire dalla fine del XX secolo, allo sviluppo di nuovi quadri teorici e metodologici per studiare i sistemi complessi sia nelle scienze naturali sia in quelle sociali. L’intuizione chiave è che la realtà vada compresa in termini di processi dinamici e interdipendenti, anziché tramite modelli lineari statici incapaci di cogliere comportamenti emergenti e auto-organizzati. Si è aperta così una nuova direzione di ricerca che costituisce il nucleo della svolta epistemologica della complessità.
“Ai confini del mondo. Storie da isole lontane” di Marco Lupis
Il libro di Marco Lupis Ai confini del mondo. Storie da isole lontane, pubblicato da Il Mulino, è stato al centro del dibattito su Stroncature che ha messo in luce il carattere ibrido e profondo dell’opera. Non si tratta di un reportage giornalistico né di una semplice narrazione di viaggio, ma di un testo che unisce l’indagine sul campo con una scrittura capace di evocare il senso di isolamento, ambiguità e appartenenza incerta che caratterizza molte delle isole descritte. Le voci di Francesca Gorgoni e Giovanni discorrono con l’autore sulla distanza, non solo geografica ma anche politica e culturale, che separa queste terre dal mondo organizzato e riconosciuto degli stati. Le isole, così come raccontate, risultano essere confini materiali e simbolici dell’esperienza umana, luoghi remoti che riflettono in scala ridotta tensioni globali, contraddizioni politiche e derive storiche.
Lupis insiste sull’esigenza di testimonianza diretta, tratto distintivo del giornalismo sul campo, e sulla necessità di uno sguardo presente, corporeo, radicato nell’incontro con le persone. Le sue isole sono microcosmi nei quali le storie collettive si sedimentano: da Nauru, devastata dall’estrazione dei fosfati e ora simbolo di una modernità autodistruttiva, a Tristan da Cunha, luogo inaccessibile dove la comunità ha scelto di tornare pur avendo la possibilità di restare nel Regno Unito. Le isole rappresentano una soglia tra la nostalgia dell’altrove e la coscienza del limite. La riflessione finale riafferma l'importanza della scrittura di viaggio come forma autonoma di conoscenza, e del giornalismo di presenza come strumento insostituibile per comprendere ciò che accade nel mondo, al di là delle sintesi offerte dai media e dalle cancellerie.
"The Quantum Revolution in Philosophy" di Richard Healey
Nel libro The Quantum Revolution in Philosophy, Richard Healey affronta in modo sistematico le implicazioni concettuali e filosofiche della teoria quantistica. Il testo si articola in due parti principali: nella prima viene esposta la struttura formale e fenomenologica della meccanica quantistica, mentre la seconda approfondisce le questioni epistemologiche e ontologiche. L’autore sostiene che la rivoluzione quantistica non consiste soltanto in un cambiamento teorico all'interno della fisica, ma rappresenta un passaggio profondo nel modo in cui pensiamo il rapporto tra rappresentazione e realtà. Il libro non propone un’ulteriore interpretazione metafisica, ma una revisione critica del modo in cui la teoria quantistica viene usata per fornire spiegazioni, predizioni e rappresentazioni. L’analisi parte dall’osservazione che molte interpretazioni della meccanica quantistica risultano parziali e contraddittorie, come nel caso della celebre analogia dell’elefante visto da punti di vista differenti. L’obiettivo di Healey è superare questa frammentazione, restituendo un quadro coerente che tenga conto della funzione effettiva della teoria quantistica: non descrivere la realtà ultima, ma fornire strumenti affidabili per orientarsi nel mondo fisico.