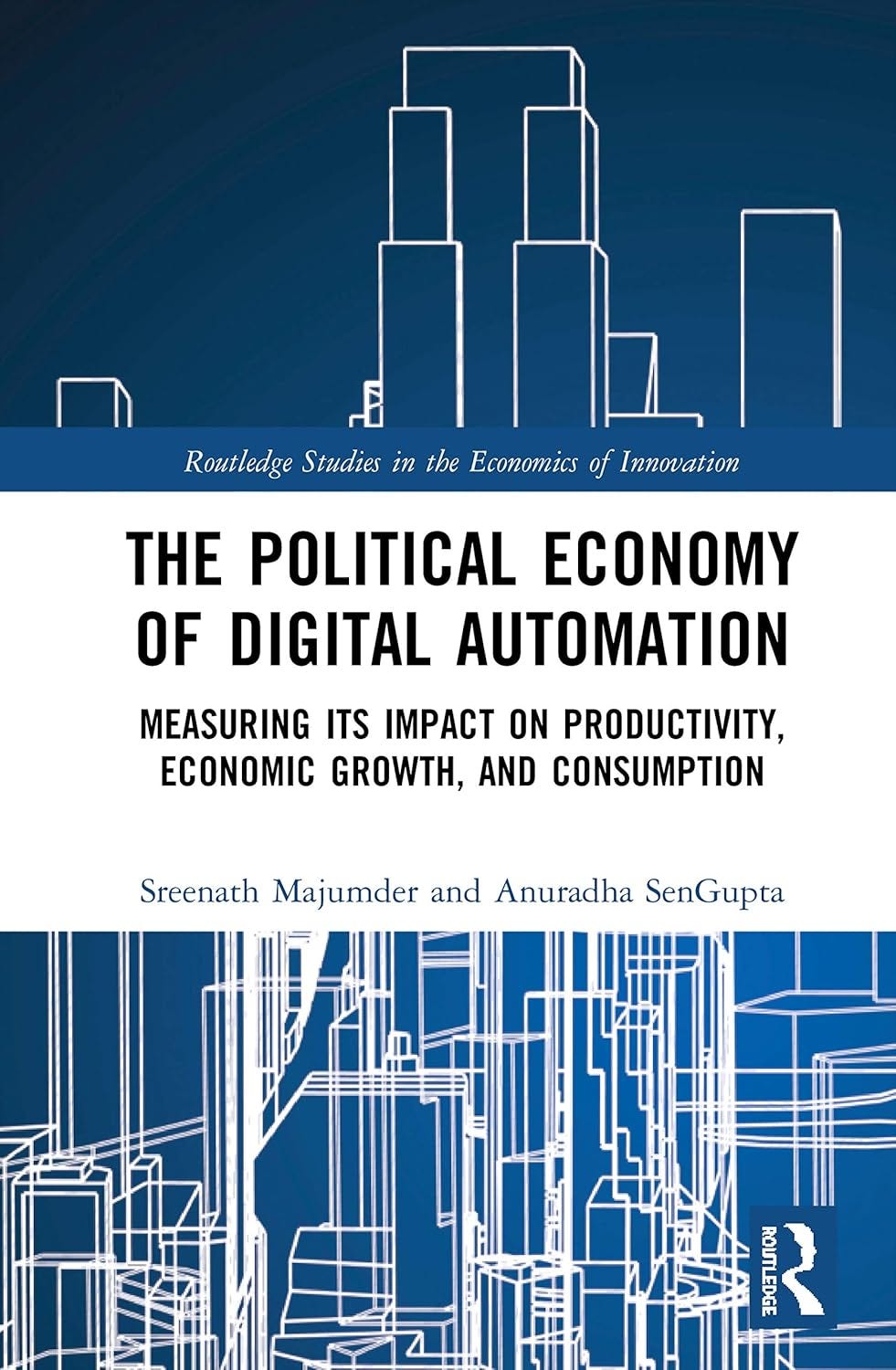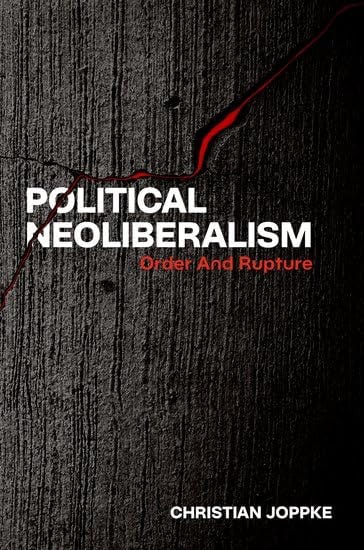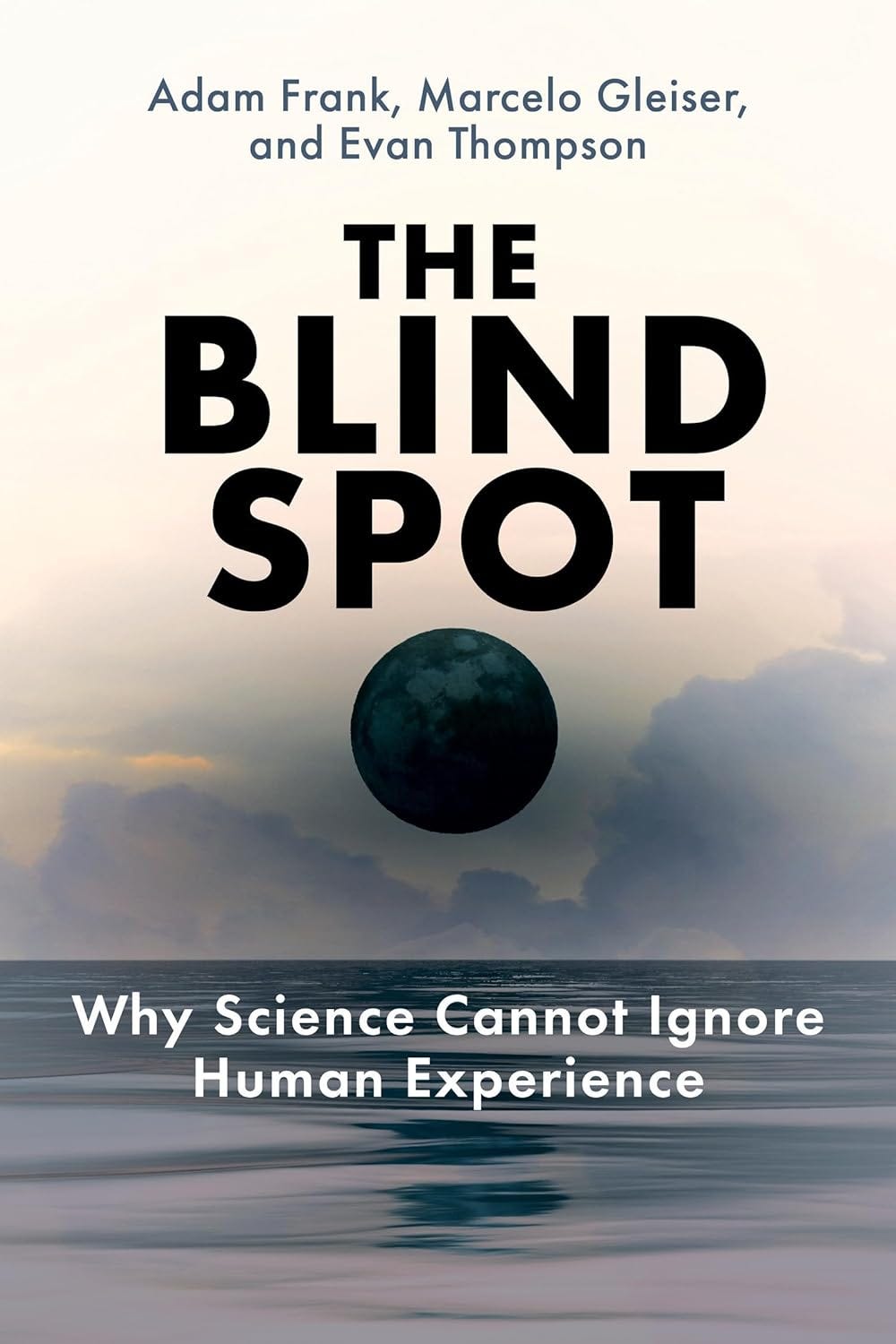Potrebbe andare sempre peggio
Da Rimini alla Toscana, dal Trentino alle Tremiti, i dati sugli ombrelloni vuoti, sulle vacanze mordi e fuggi, spesso un fine settimana, a volte il tempo di un bagno al mare in giornata, senza nemmeno aspettare che il costume si asciughi, si moltiplicano. Studi recenti non ce ne sono, nè qualcuno ha certificato una correlazione, ma a chi scrive l’idea che le nuove ondate tecnologiche c’entrino in qualche modo, inizia a ronzare in testa con una certa frequenza. Per dirla in modo diretto, il dubbio che i processi di automazione (più o meno intelligenti) stiano impattando sempre più sui posti di lavoro e sulla loro remunerazione e quindi sul tenore di vita delle persone, è forte. Parafrasando Solow, i numeri dell’intelligenza artificiale forse non si vedono nei dati delle produttività, ma nel numero di ombrelloni vuoti sì.
Perché la Costituzione protegge il risparmio?
Il testo è tratto dall’articolo scientifico “Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione” della prof.ssa Camilla Buzzacchi, direttrice del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) e dell’Osservatorio DI.PAB, rielaborato in forma divulgativa per favorirne la diffusione e la comprensione al di fuori dei contesti accademici. Realizzato nell’ambito della partnership per la Terza Missione tra Stroncature e il Di.SEA.DE dell’Università di Milano-Bicocca, questo contributo si propone di rendere accessibile al pubblico non specialista un tema di grande rilevanza pubblica: il ruolo del risparmio nella Costituzione italiana e nella tenuta economico-sociale del Paese. La rielaborazione divulgativa dell’articolo si inserisce tra le attività promosse da Stroncature per la Terza Missione, che comprendono anche video, podcast, infografiche e altri contenuti ispirati alla ricerca accademica.
"The Political Economy of Digital Automation" di Sreenath Majumder e Anuradha SenGupta
Il volume The Political Economy of Digital Automation. Measuring its Impact on Productivity, Economic Growth, and Consumption di Sreenath Majumder e Anuradha SenGupta si propone di indagare il modo in cui la crescente automazione digitale stia ridefinendo l’equilibrio tra produttori e consumatori, con un focus specifico sul contesto statunitense. Gli autori adottano un’impostazione interdisciplinare che intreccia economia politica, sociologia, tecnologia e politiche pubbliche, con l’obiettivo di comprendere le profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali indotte da ciò che definiscono “digitomation” (digital automation). L’opera analizza le conseguenze di questa trasformazione sia sul piano delle identità lavorative (i “venditori” di forza-lavoro) sia su quello delle identità di consumo (i “compratori” di beni e servizi), evidenziando come il divario tra queste due sfere stia generando tensioni crescenti, diseguaglianze e instabilità politica. Il libro si articola attorno a una tesi centrale: il processo di automazione non è soltanto il prodotto dell’innovazione tecnologica promossa dalle imprese, ma è sostenuto e accelerato anche dalla domanda dei consumatori per prodotti sempre più veloci, perfetti e gratuiti. Tale dinamica endogena, se non corretta da adeguate politiche pubbliche, rischia di compromettere la coesione sociale e la sostenibilità democratica delle società avanzate.
"Political Neoliberalism. Order and Rupture" di Christian Joppke
Christian Joppke, professore di sociologia, affronta in questo volume la natura politica del neoliberismo, distanziandosi da letture puramente economiche o riduttive del concetto. L’obiettivo dichiarato del libro è distinguere chiaramente tra liberalismo e neoliberismo, non negandone la parentela storica ma insistendo sulla loro differente funzione come principi ordinatori della politica contemporanea. Il termine “neoliberismo” viene spesso rifiutato come retorico o eccessivamente esteso; tuttavia, Joppke ne difende un uso ampio e articolato, capace di coglierne l’effettiva pervasività come razionalità di governo delle società occidentali. Il libro è strutturato intorno alla tensione concettuale tra ordine e rottura: da un lato, analizza le forme istituzionali con cui il neoliberismo si è stabilito come nuovo ordine politico; dall’altro, studia le rotture generate da forze populiste e identitarie, che si presentano come reazioni, ma che in realtà operano all’interno dello stesso quadro neoliberale. L’argomentazione si dispiega in una genealogia del neoliberismo, nella descrizione delle sue forme istituzionali e nella critica alle risposte politiche di destra e sinistra, mostrandone l’inadeguatezza a fuoriuscire dal paradigma dominante.
"The Blind Spot. Why Science Cannot Ignore Human Experience" di Adam Frank, Marcelo Gleiser e Evan Thompson
Il volume The Blind Spot, scritto da Adam Frank, Marcelo Gleiser ed Evan Thompson e pubblicato dal MIT Press nel 2024, è un saggio filosofico-interdisciplinare che indaga le radici e le conseguenze di un problema strutturale insito nella moderna visione scientifica del mondo. Il titolo del libro rimanda a una metafora centrale: come nel campo visivo vi è un punto cieco che impedisce di vedere ciò che è alla base del vedere stesso, così nella scienza contemporanea esiste un punto cieco che oscura ciò da cui ogni conoscenza scientifica prende origine, ovvero l’esperienza diretta del soggetto conoscente. Gli autori non si pongono in opposizione alla scienza, né ne negano i successi, ma ne contestano un impianto filosofico implicito, un insieme di assunti metafisici che, pur non essendo parte integrante della pratica scientifica, si sono solidificati in una visione del mondo parziale e problematica. Lo scopo dell’opera è dunque duplice: smascherare l’invisibilità del punto cieco e suggerire un ripensamento della scienza che non escluda la dimensione esperienziale, ma la assuma come suo fondamento ineludibile. Il libro si struttura in quattro sezioni (le origini del punto cieco, il cosmo, la vita e la mente, il pianeta), affrontando questioni quali il tempo, la materia, la coscienza, l’intelligenza artificiale e la crisi climatica.