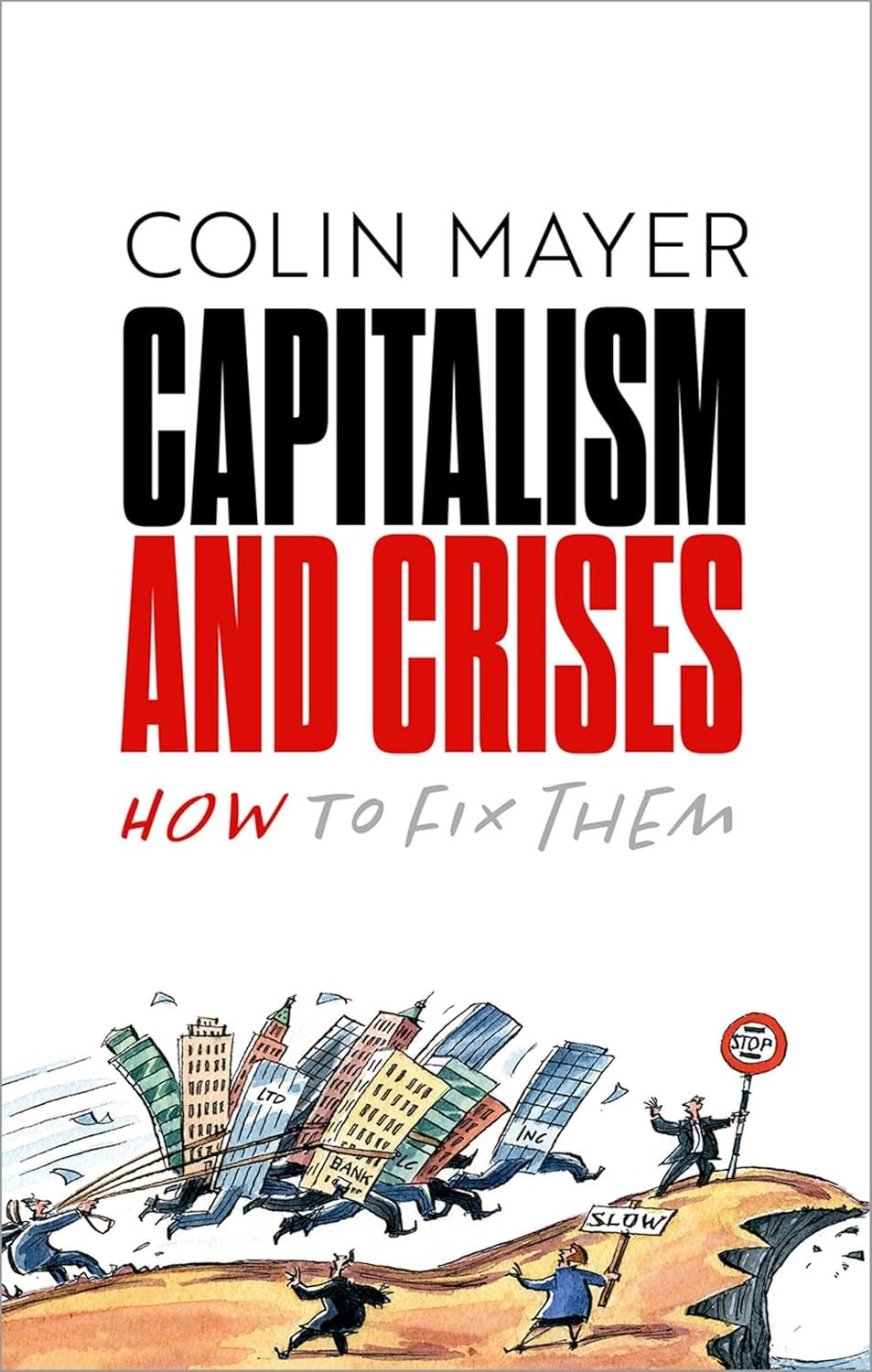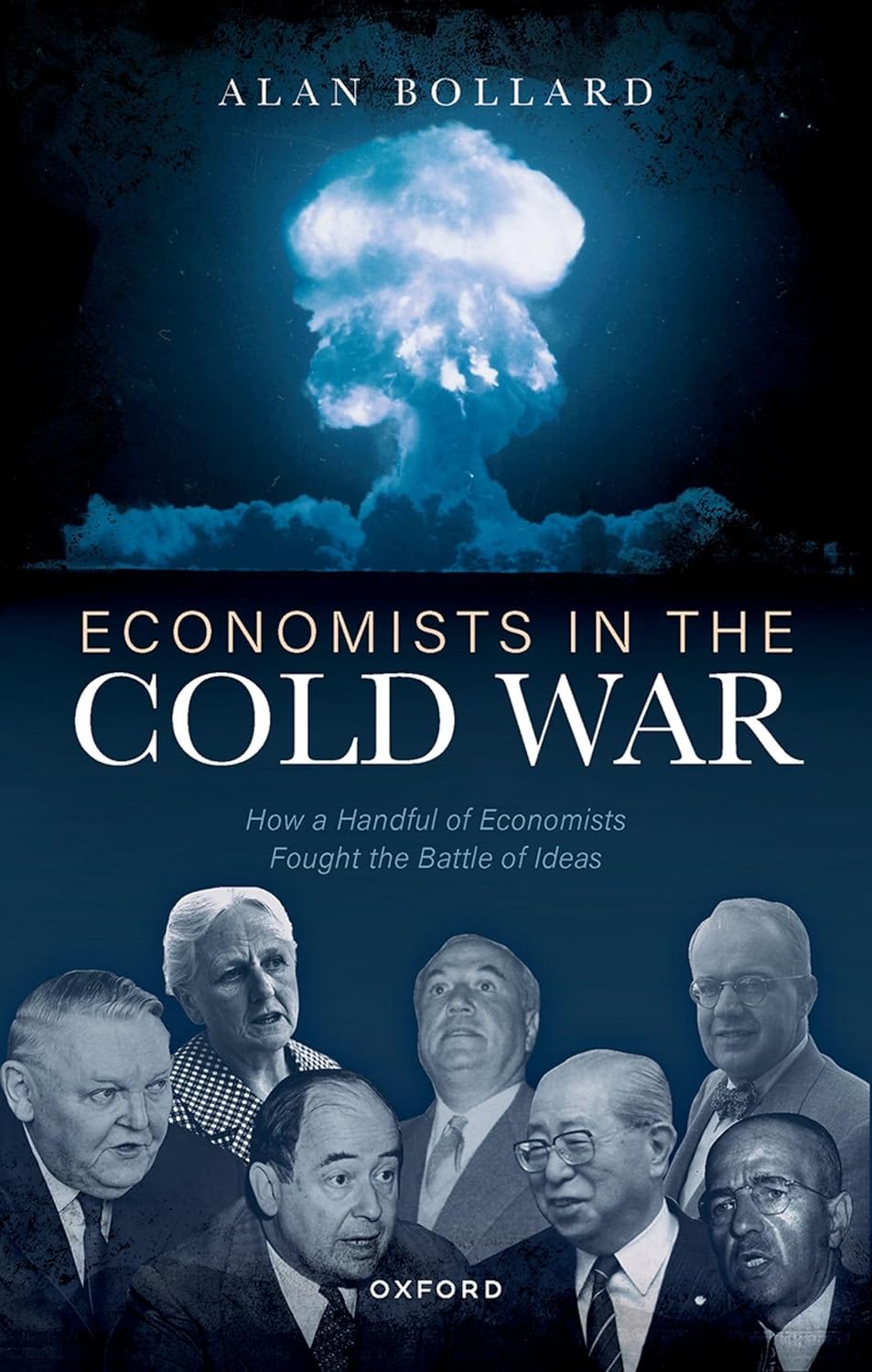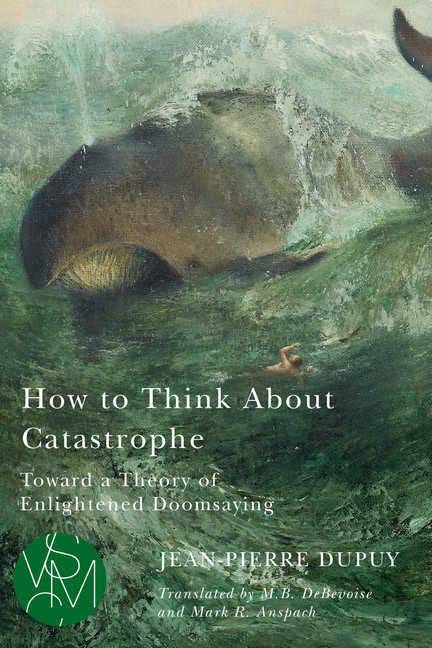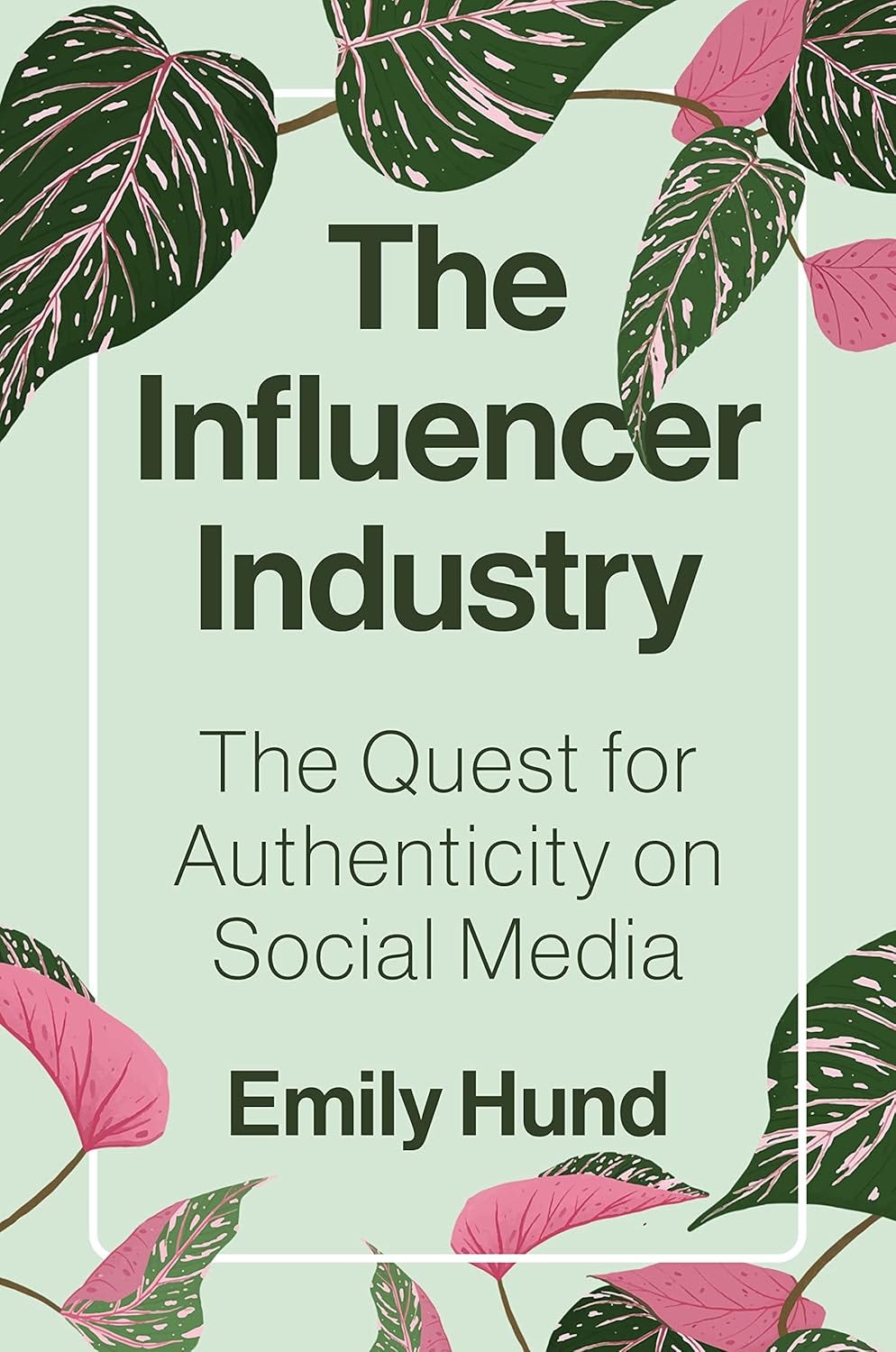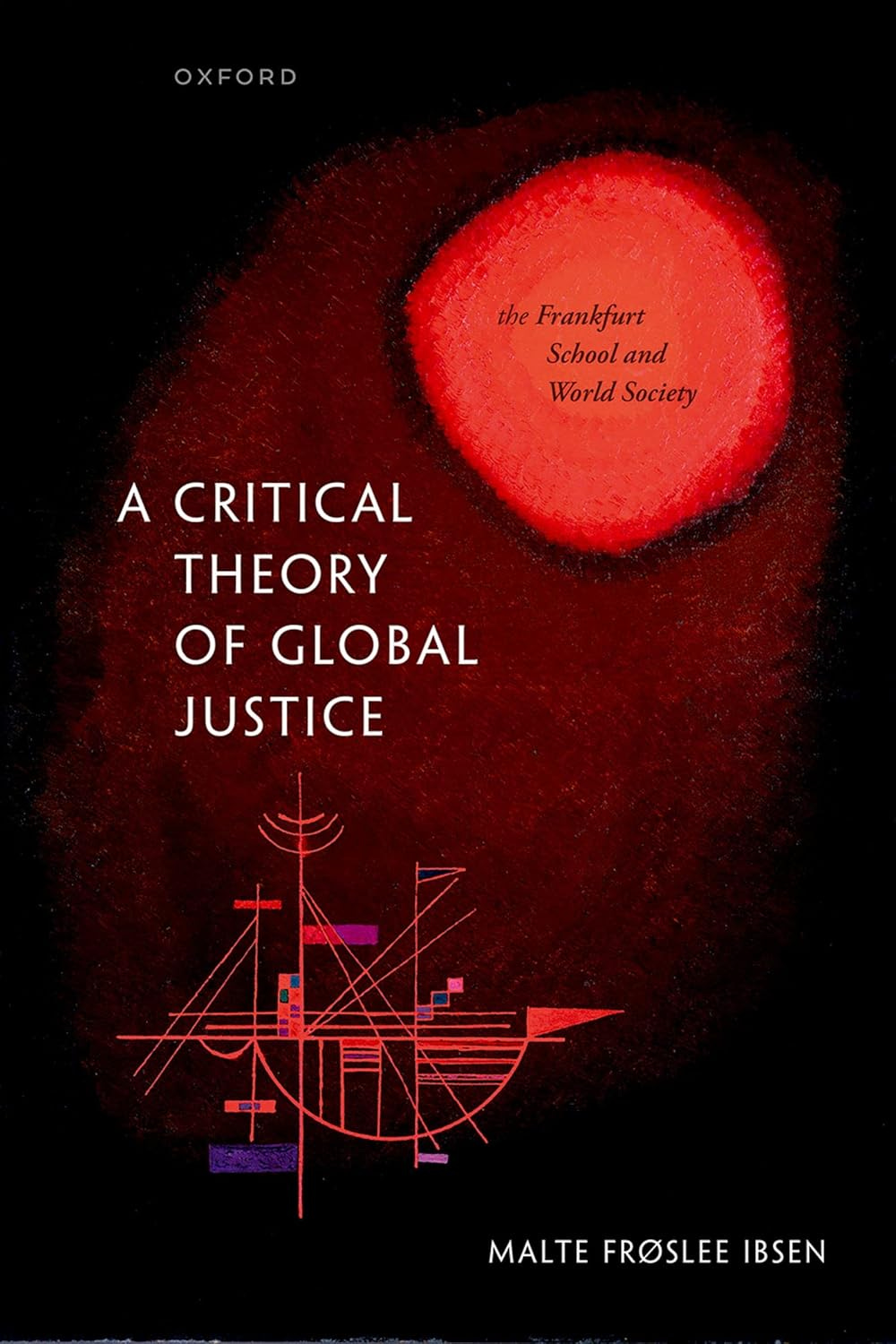Punti cardinali #24
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Per ogni testo viene redatta una scheda dettagliata e approfondita che consente di accedere a tutti i contenuti del libro, alle sue tesi, concetti ed argomentazioni, in modo completo.
I vantaggi sono enormi. In breve tempo è possibile accedere ai contenuti completi di testi di saggistica di grande complessità e di difficile accesso, potendo spaziare dalle scienze sociali a quelle della natura, e facendo così propri in modo facile ed economico i frutti della ricerca dei maggiori studiosi e studiose e delle più prestigiose case editrici a livello globale, come se si fosse letto l’intero libro.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale.
"Capitalism and Crises" di Colin Mayer
Il libro di Colin Mayer Capitalism and Crises si colloca al crocevia di tre grandi tradizioni di pensiero: l’analisi storica delle istituzioni economiche, la teoria normativa dell’impresa e la riflessione politica sulla sostenibilità dei sistemi socioeconomici. Mayer, professore alla Saïd Business School di Oxford e tra i più autorevoli studiosi contemporanei di corporate governance, non intende proporre un manifesto ideologico o un atto di accusa generico contro il capitalismo, ma costruire un’argomentazione rigorosa, basata su dati storici e su analisi teoriche, per spiegare perché le crisi siano diventate così frequenti e pervasive e come esse siano legate al funzionamento stesso delle istituzioni economiche moderne. Il punto di partenza è che non si tratta di crisi isolate, ciascuna confinata al proprio ambito (finanza, clima, sanità, politica), bensì di un sistema in cui il modo stesso di funzionare delle imprese e dei mercati produce effetti cumulativi che alimentano instabilità ricorrenti. L’obiettivo del libro non è quindi soltanto diagnostico ma progettuale: mostrare come il capitalismo possa essere riformato dall’interno attraverso una ridefinizione del ruolo dell’impresa, del diritto societario, delle istituzioni finanziarie e dei criteri con cui misuriamo il successo economico. In questo senso, Capitalism and Crises rappresenta l’ultimo tassello di una trilogia che include Firm Commitment (2013), dedicato alla fiducia e alla responsabilità delle imprese, e Prosperity (2018), incentrato sullo scopo e sul senso delle organizzazioni. Qui l’attenzione si sposta sul legame strutturale tra capitalismo e crisi, e sulla possibilità di concepire un “capitalismo che risolve problemi” invece di uno che ne crea di nuovi.
"Economists in the Cold War. How a Handful of Economists Fought the Battle of Ideas" di Alan Bollard
Il libro di Alan Bollard Economists in the Cold War. How a Handful of Economists Fought the Battle of Ideas offre una ricostruzione storica e intellettuale di un tema spesso trascurato: il ruolo delle idee economiche e dei loro principali interpreti nella lunga competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La Guerra fredda, di solito descritta come una sfida militare, tecnologica e diplomatica, viene qui osservata attraverso la lente delle teorie economiche e delle battaglie intellettuali combattute da una ristretta élite di studiosi. Bollard mostra come economisti di primo piano, spesso legati a governi, istituzioni internazionali e centri di ricerca, abbiano contribuito a definire le strategie di entrambi i blocchi e ad alimentare la legittimazione ideologica dei rispettivi sistemi. Il volume ricostruisce in chiave comparativa il contributo di economisti occidentali e sovietici, inserendoli nel contesto delle decisioni di politica economica, delle crisi internazionali e degli snodi strategici del dopoguerra. L’impostazione non è quella di un manuale tecnico, ma di una narrazione ampia, che illustra come le idee economiche siano state strumenti di potere, di confronto ideologico e di influenza globale, incidendo sulla direzione della storia mondiale. Il libro, pubblicato da Oxford University Press, si caratterizza per una scrittura accessibile ma rigorosa, che combina biografie intellettuali, analisi teoriche e descrizione di episodi concreti.
"How to Think About Catastrophe. Toward a Theory of Enlightened Doomsaying" di Jean-Pierre Dupuy
Il libro di Jean-Pierre Dupuy, How to Think About Catastrophe. Toward a Theory of Enlightened Doomsaying, traduzione inglese di Pour un catastrophisme éclairéaffronta una delle questioni più delicate e al tempo stesso più ineludibili del nostro tempo: come pensare la catastrofe. L’autore propone di abbandonare sia le forme tradizionali del fatalismo rassegnato, che paralizza l’azione e porta a un atteggiamento di impotenza, sia le illusioni ottimistiche di chi confida che la tecnica e il progresso sapranno sempre trovare soluzioni. Al centro della sua analisi sta il concetto di “catastrofismo illuminato”, una prospettiva che invita a considerare le catastrofi come inevitabili e già inscritte nel futuro, non per abbandonarsi alla disperazione, ma per sviluppare una nuova forma di responsabilità. Secondo Dupuy, infatti, solo se si immagina la catastrofe come certa e reale si potrà agire in tempo per evitarla. Questo paradosso è il nucleo della sua riflessione, che si muove tra filosofia, economia, teoria della decisione, etica e metafisica. L’opera, nata da una conferenza tenuta nel 2001 e profondamente segnata dagli eventi dell’11 settembre, intende elaborare un metodo per affrontare le minacce che incombono sulla nostra epoca: il cambiamento climatico, il rischio nucleare, l’autonomia incontrollata della tecnologia, le pandemie, il collasso degli ecosistemi. Tutte queste sfide sono espressione del potere dell’uomo di distruggere se stesso e il mondo che abita.
"The Influencer Industry. The Quest for Authenticity on Social Media" di Emily Hund
Emily Hund, nel libro The Influencer Industry. The Quest for Authenticity on Social Media, affronta in maniera sistematica il fenomeno che negli ultimi due decenni ha trasformato radicalmente la comunicazione digitale, la cultura del consumo e le logiche del marketing. L’autrice parte da una considerazione di fondo: ciò che oggi chiamiamo “industria degli influencer” non è nato come progetto intenzionale, ma si è sviluppato attraverso processi graduali, spesso disordinati, che hanno coinvolto una pluralità di attori, dalle piattaforme ai brand, dalle agenzie pubblicitarie ai singoli creatori di contenuti. L’obiettivo principale del libro è mostrare come la ricerca di autenticità, concetto centrale nella cultura digitale contemporanea, sia stata al tempo stesso la promessa, il motore e la contraddizione interna di un settore che ha reso commerciabile la rappresentazione del sé. Hund chiarisce subito che non intende limitarsi a descrivere i protagonisti più noti del fenomeno, ma vuole ricostruire il quadro strutturale che ha reso possibile la legittimazione di un’attività inizialmente marginale, fino alla sua istituzionalizzazione come componente stabile dell’economia globale. Lo stile dell’autrice è quello di una studiosa che unisce rigore analitico e chiarezza divulgativa, proponendo una narrazione che combina dati storici, testimonianze e interpretazioni teoriche.
"A Critical Theory of Global Justice" di Malte Frøslee Ibsen
Il libro A Critical Theory of Global Justice. The Frankfurt School and World Society di Malte Frøslee Ibsen si colloca all’incrocio tra filosofia politica, teoria critica e studi sulla giustizia globale. L’autore intende esplorare in che modo la tradizione della Scuola di Francoforte, con le sue categorie concettuali e la sua attenzione alla critica delle strutture di potere, possa contribuire a una comprensione rinnovata della giustizia in un mondo globalizzato. L’impostazione complessiva è teorica ma sempre connessa a problematiche concrete, quali la governance internazionale, le diseguaglianze economiche, le dinamiche ambientali e i diritti umani. Ibsen parte dall’assunto che la globalizzazione abbia messo in crisi i tradizionali confini entro i quali la filosofia politica moderna aveva elaborato i concetti di giustizia, cittadinanza e sovranità, rendendo necessario un approccio capace di superare la dimensione esclusivamente statale. L’obiettivo è sviluppare una teoria critica della giustizia globale che non si limiti a un ideale normativo astratto, ma che sia in grado di analizzare i meccanismi istituzionali e le relazioni sociali che producono ingiustizie su scala mondiale, mantenendo al contempo un orizzonte di emancipazione.