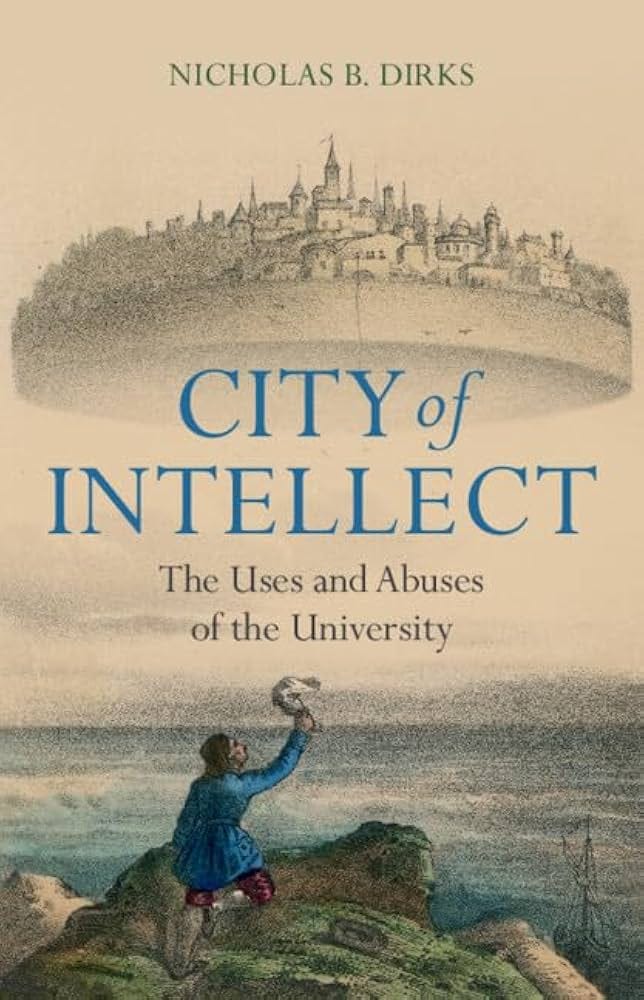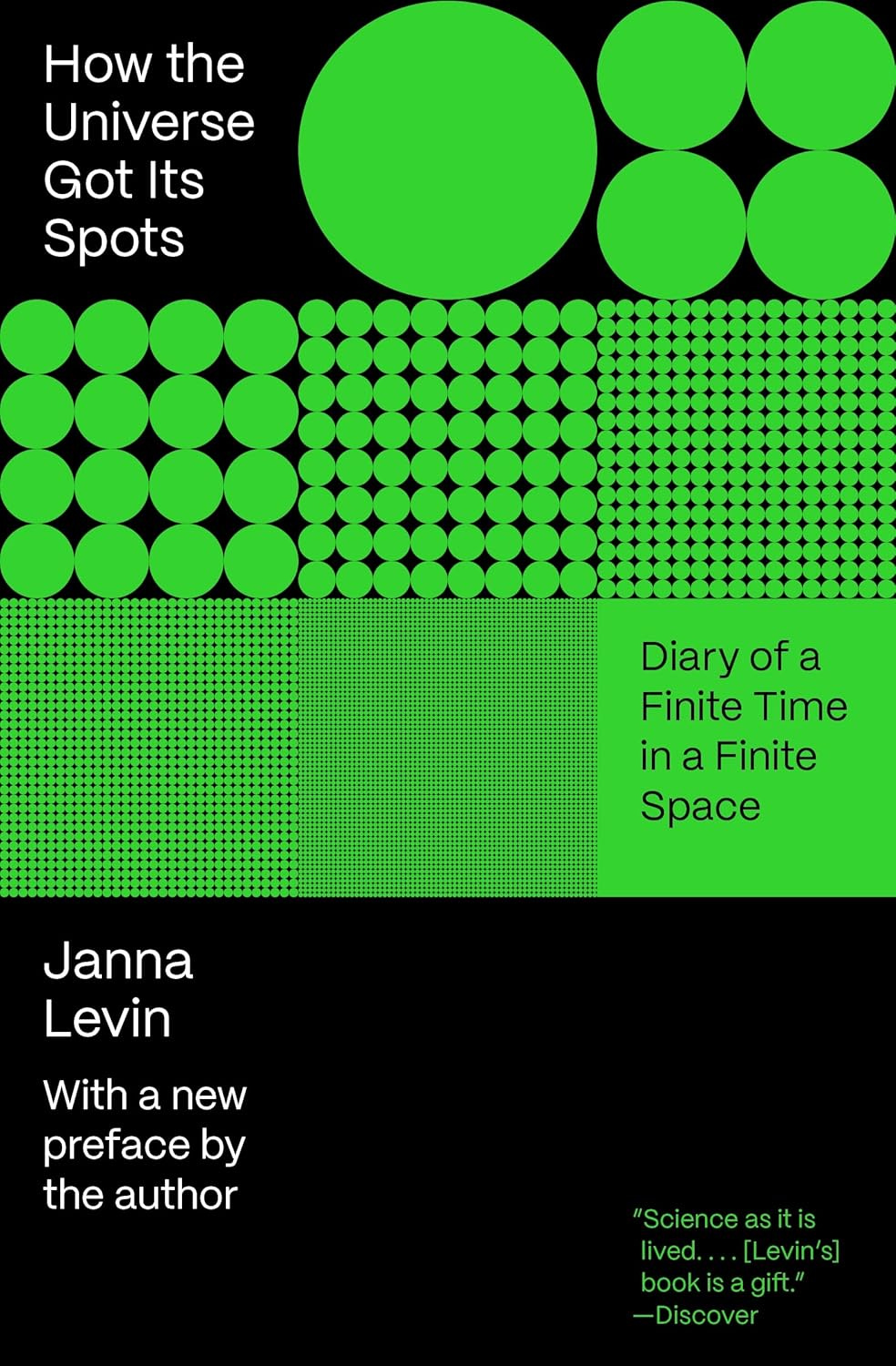Terza Missione #10
Stroncature affianca Università e Centri di ricerca in tutte le fasi del processo dei di public engagement e valorizzazione economica della ricerca. Il servizio è concepito in un’ottica full spectrum: dalla produzione di contenuti divulgativi (video, podcast, infografica, testi di divulgazione) alla rendicontazione delle attività per la compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA), passando per la distribuzione e promozione dei contenuti prodotti attraverso propri canali. Nello sviluppo delle attività di Terza Missione, Stroncature si impegna ad ampliare l’impatto su società civile e mondo produttivo delle ricerche condotte dai Dipartimenti, perchè possano diventare motore di sviluppo economico e progresso sociale; e nel contempo suscitare l’entusiasmo delle giovani menti, mostrando le sfide su cui la comunità accademica è impegnata: favorendo così nuove iscrizioni e individuando nuove esigenze di sviluppo scientifico che possono emergere dal confronto. In questo modo Prima Missione (Didattica), Seconda Missione (Ricerca) e Terza Missione, si legano e si rafforzano a vicenda.
Terza Missione
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) dell’Università di Milano-Bicocca
Comunità energetiche e incentivi: le regole da rispettare per non perdere i benefici (1 di 10)
Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano oggi una delle innovazioni più significative nel panorama della transizione ecologica, perché consentono a cittadini, piccole imprese e amministrazioni locali di unirsi per produrre e condividere energia pulita. La loro importanza non si misura soltanto nella capacità di ridurre le bollette o di promuovere comportamenti sostenibili, ma anche nella possibilità di accedere a incentivi pubblici che rendono economicamente sostenibile la gestione di questi progetti. Senza il sostegno di strumenti come la tariffa premio, il contributo ARERA e le misure del PNRR, molte iniziative rischierebbero di rimanere sulla carta. Tuttavia, questi benefici non sono automatici e non possono essere dati per scontati. La legge prevede vincoli precisi che devono essere rispettati già nella fase di costituzione della comunità, attraverso l’atto costitutivo e lo statuto. In altre parole, non basta la buona volontà di mettersi insieme: per ottenere e mantenere gli incentivi occorre strutturarsi come un soggetto giuridico conforme alla normativa e alle regole fissate dal Gestore dei Servizi Energetici. È proprio questa la condizione che distingue una comunità energetica destinata a durare da un progetto fragile, che potrebbe essere escluso dai benefici economici.
Credit scoring e algoritmi sotto la lente della Corte UE
Negli ultimi anni, le valutazioni automatizzate dell’affidabilità creditizia – il cosiddetto credit scoring – sono diventate uno strumento centrale per banche, società di servizi e operatori digitali. Tuttavia, fino a tempi recenti, chi elaborava questi punteggi non era sempre sottoposto a vincoli normativi stringenti, soprattutto se si presentava come semplice fornitore di dati per soggetti terzi. Le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea analizzate dalla professoressa Francesca Mattassoglio, dell’Università di Milano-Bicocca, segnano un’importante svolta in questa direzione.
Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino
Nanoparticelle di ossido di zinco: come le microonde aprono la strada a una produzione più sostenibile
Negli ultimi decenni la produzione di materiali innovativi ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico, ma si è sempre più accompagnata a un problema cruciale: come ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali. Molti procedimenti tradizionali richiedono consumi energetici elevati, l’uso di solventi tossici o la produzione di sottoprodotti inquinanti. Per affrontare queste sfide, la ricerca in chimica dei materiali ha puntato a sviluppare metodi più sostenibili, capaci di combinare efficienza, qualità del prodotto e rispetto dell’ambiente. L’ossido di zinco, formato dall’elemento zinco e dall’ossigeno (ZnO), è un esempio emblematico: le sue proprietà elettroniche e ottiche lo rendono utile in campi molto diversi tra loro, dai semiconduttori alle celle solari, dalle creme solari ai rivestimenti anticorrosione. La questione è quindi come ottenere nanoparticelle di ossido di zinco – particelle minuscole, fino a mille volte più piccole di un capello umano – in modo più rapido, economico e rispettoso della sostenibilità ambientale. Due approcci si prestano al confronto: la decomposizione termica, una tecnica tradizionale ben consolidata, e la sintesi assistita da microonde, che rappresenta un’alternativa innovativa e potenzialmente più “verde”.
Punti cardinali
“City of Intellect. The Uses and Abuses of the University” di Nicholas B. Dirks (Princeton University Press, 2023)
Il volume City of Intellect. The Uses and Abuses of the University, pubblicato da Princeton University Press nel 2023, rappresenta un contributo di grande rilievo al dibattito contemporaneo sul ruolo e sul destino delle università. Nicholas B. Dirks, antropologo e storico di formazione, già docente alla Columbia University e cancelliere della University of California, Berkeley, propone una riflessione ampia e articolata sulle trasformazioni che hanno investito l’istituzione universitaria, in particolare negli Stati Uniti, ma con implicazioni che toccano anche il contesto globale. L’opera prende le mosse da una prospettiva storico-comparativa: l’autore si sofferma sul lungo percorso che ha fatto dell’università il luogo privilegiato della produzione e della trasmissione del sapere, sottolineando le tensioni tra la sua missione originaria e le pressioni che oggi ne condizionano l’operato. Gli obiettivi dichiarati del volume sono due: da un lato, ricostruire la genealogia culturale e politica dell’università moderna, evidenziandone i valori fondativi; dall’altro, denunciare le derive funzionalistiche, burocratiche ed economiche che ne hanno eroso progressivamente la legittimità sociale. L’impostazione complessiva è critica ma costruttiva: Dirks non si limita a denunciare le “abuses” del titolo, ma intende anche avanzare proposte per rivitalizzare il progetto intellettuale che ha reso l’università un attore insostituibile nella società moderna. Ne risulta un testo insieme divulgativo e rigoroso, che si rivolge non solo agli specialisti di politiche educative, ma anche a un pubblico più ampio di cittadini interessati al destino delle istituzioni culturali e democratiche.
“How the Universe Got Its Spots” di Janna Levin (Random House, 2002)
Il libro How the Universe Got Its Spots. Diary of a Finite Time in a Finite Space di Janna Levin, pubblicato nel 2002 da Random House, si presenta come un testo a metà tra la divulgazione scientifica e il diario personale, con l’obiettivo di introdurre il lettore non specialista alle grandi domande della cosmologia contemporanea. Levin, astrofisica e teorica della relatività, adotta una forma epistolare e riflessiva, scrivendo come se si rivolgesse direttamente a un interlocutore amico o collega. La scelta stilistica consente di combinare rigore scientifico e dimensione esistenziale, rendendo più accessibili temi complessi come la geometria dell’universo, la relatività generale, le onde gravitazionali e l’eventuale finitezza dello spazio. Il testo si colloca così nel solco di una divulgazione che non semplifica ma accompagna il lettore dentro i nodi teorici, con la volontà di trasmettere il senso dell’incertezza e della ricerca scientifica più che fornire risposte definitive. La struttura narrativa permette di collegare i grandi concetti scientifici con riflessioni personali, domande di senso e osservazioni sulla condizione umana di fronte all’universo.