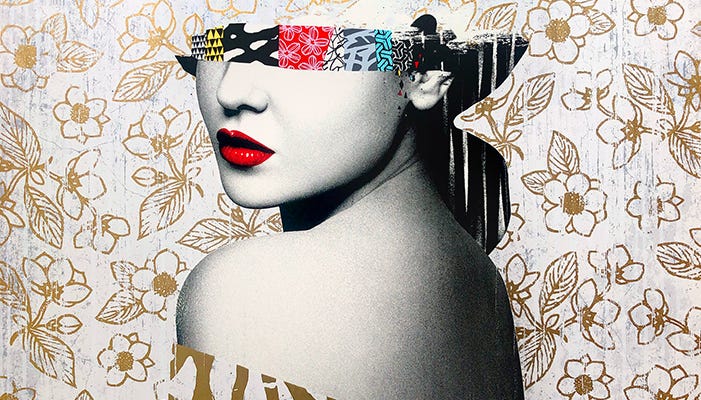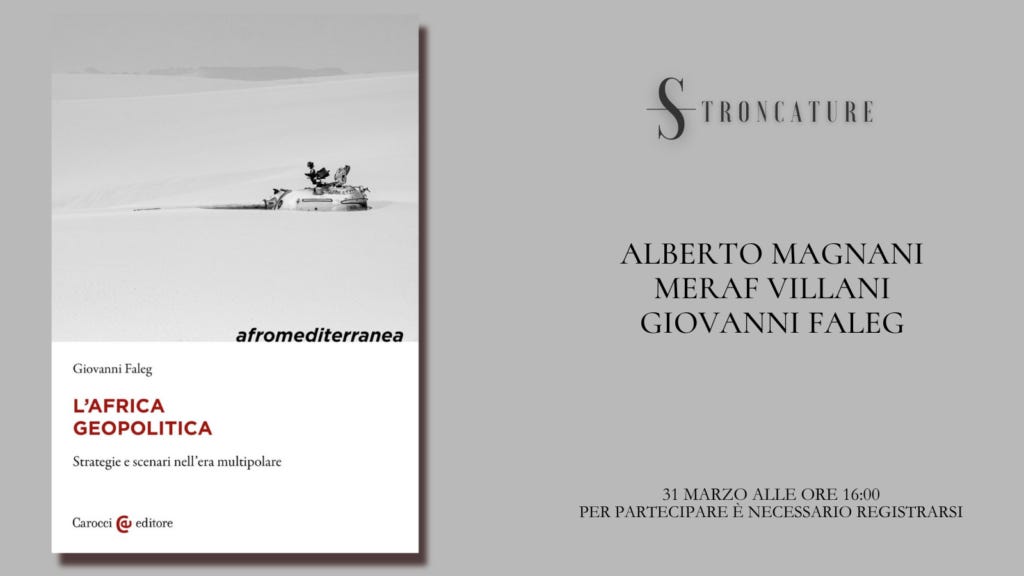Dazi, regolamenti e il commercio come strumento di potere
Il commercio internazionale non è soltanto un fatto economico: è anche uno strumento di potere nelle relazioni internazionali. Dazi, quote, sanzioni e regolamenti tecnici possono essere usati dai governi non solo per proteggere industrie domestiche, ma anche per esercitare pressione su altri paesi e perseguire obiettivi geopolitici. In un mondo interdipendente, l’accesso al mercato di un grande paese o a risorse critiche può diventare una leva potente: concederlo o negarlo ha implicazioni strategiche. La storia offre esempi, dall’embargo petrolifero degli anni ’70 alle attuali guerre commerciali, di come il commercio sia stato “armato” per fini politici. Con la crescente rivalità tra grandi potenze e l’erosione di alcuni meccanismi multilaterali, il ricorso al commercio come arma di coercizione o di influenza è tornato di attualità.
L'industria automobilistica come modello delle catene globali di produzione
Il settore automobilistico è spesso citato come paradigma delle moderne catene globali di produzione. Fin dagli ultimi decenni del Novecento, le case automobilistiche hanno esternalizzato e disperso geograficamente gran parte della produzione di componenti, creando reti di fornitori a livello regionale e globale. Un’automobile moderna contiene migliaia di parti (si stima tra 20.000 e 30.000 componenti) provenienti da dozzine di paesi diversi. Ad esempio, un’autovettura assemblata in Germania può montare un motore prodotto in Ungheria, una centralina elettronica fabbricata in Italia con chip provenienti dal Taiwan, pneumatici da uno stabilimento in Francia e cablaggi elettrici realizzati in Marocco. Questa frammentazione produttiva, coordinata dai grandi costruttori (OEM), ha permesso di ridurre i costi e sfruttare specializzazioni locali, ma ha anche reso le filiere complesse e interdipendenti. L’industria auto fornisce quindi un modello emblematico per studiare le opportunità e le vulnerabilità delle catene globali.
"The Myth of Artificial Intelligence: Why Computers Can't Think the Way We Do" di Erik J. Larson
Nel suo libro intitolato The Myth of Artificial Intelligence: Why Computers Can't Think the Way We Do, Erik J. Larson analizza criticamente lo stato attuale della ricerca sull'intelligenza artificiale (IA) e mette in discussione la comune convinzione che si stia progredendo verso la creazione di una vera intelligenza artificiale generale (AGI). L'autore sostiene che la cultura dell'IA ha semplificato la comprensione dell'intelligenza umana, portando a "errori di intelligenza" fin dai tempi di Alan Turing. Questi errori iniziali sono stati amplificati dall'idea di "ultraintelligenza" di I.J. Good, creando un mito moderno dell'IA che si manifesta in quella che Larson definisce "kitsch tecnologico". Il libro si divide in due parti: la prima esplora il "mondo semplificato" dell'IA, mentre la seconda si concentra sul "problema dell'inferenza", sostenendo che l'inferenza abduttiva, cruciale per l'intelligenza generale, è trascurata dalla ricerca attuale.
"L’africa geopolitica" di Giovanni Faleg
Il prossimo 31 marzo alle 16:00, Stroncature ospiterà la presentazione del libro "L’africa geopolitica" di Giovanni Faleg (Carocci, 2024).
Il volume esamina la complessa situazione geopolitica dell’Africa, evidenziando come il continente sia teatro di una significativa trasformazione dovuta a pressioni esterne e interne. Tra le sfide menzionate, vi sono la competizione globale per l’influenza sull’Africa e le tensioni interne che influenzano la stabilità politica e la crescita economica. L’opera analizza gli attori chiave e le dinamiche geopolitiche emergenti, proponendo scenari futuri e delineando le possibili traiettorie per gli Stati africani. Questo testo si propone di orientare efficacemente il dialogo internazionale e le strategie di cooperazione con l’Africa.
Con l’autore dialogheranno: Alberto Magnani (Il Sole 24 Ore) e Meraf Villani (Luiss School of Government - Mediterranean Platform). Modera l’incontro Riccardo Pennisi.
Per partecipare è necessario registrarsi.