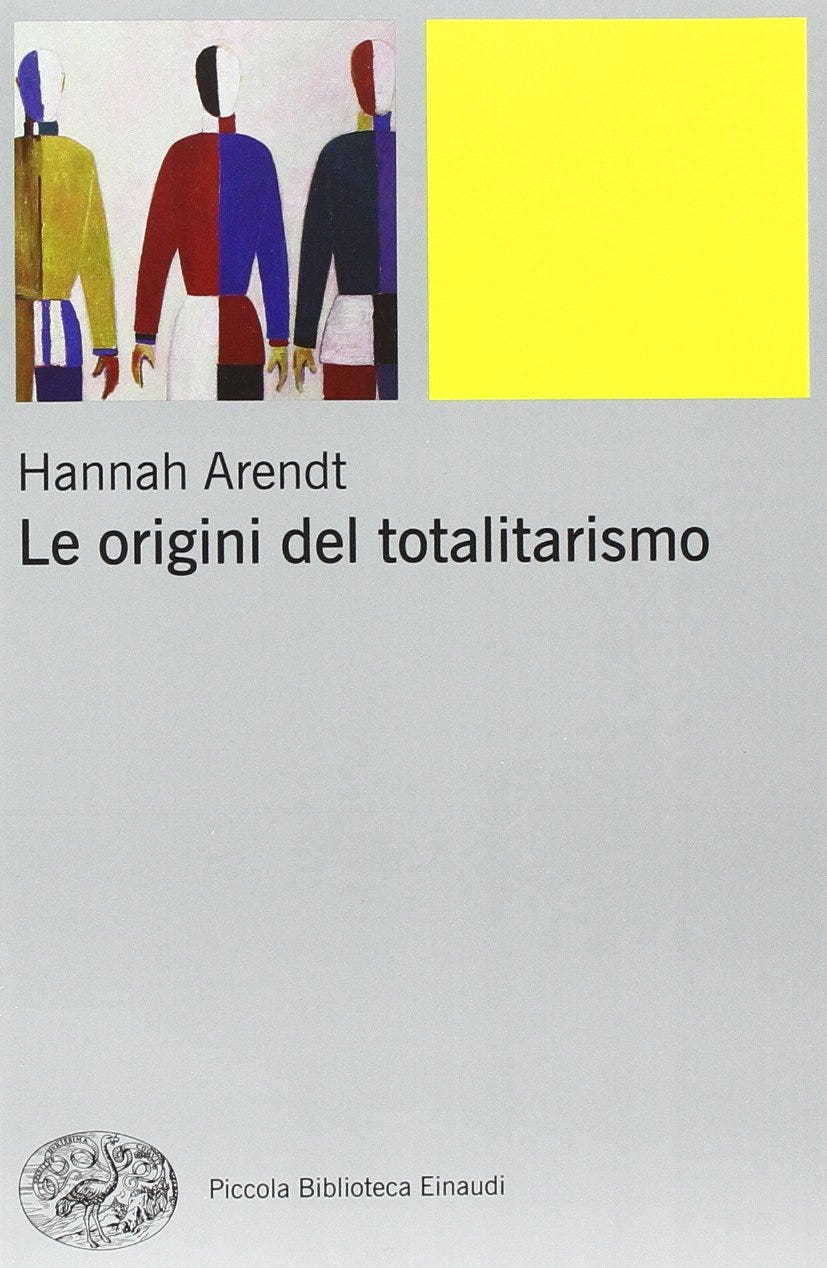Fiducia e ordine internazionale
La fiducia costituisce il fondamento invisibile ma imprescindibile dell’ordine politico e finanziario internazionale. Non si impone né si acquista, ma nasce da un libero consenso costruito in temi lunghi intorno a regole prevedibili, istituzioni stabili e benefici equamente distribuiti. L’egemonia americana nel secondo dopoguerra si è retta su questo equilibrio: gli Stati Uniti hanno garantito un contesto in cui alleati, partner e mercati potevano crescere all’interno di un sistema inclusivo e cooperativo, mutualmente vantaggioso. In questo senso, la fiducia è il prodotto di un ordine percepito come giusto. In un tale ordine, la fiducia era sostenuta dalla convinzione che il gioco non fosse a somma zero, ma che tutti, a condizioni diverse, potessero trarne vantaggio, con la possibilità di avere maggiore sicurezza, crescita e libertà.
L’Unione europea come pilastro dell’ordine economico globale
L’instabilità dell’amministrazione Trump, evidenziata da decisioni commerciali arbitrarie, contraddittorie rispetto agli obiettivi dichiarati e scollegate da una coerenza strategica, mostra la fragilità di un ordine internazionale fondato sul primato esclusivo di un solo paese. Il sistema attuale somiglia a una piramide rovesciata, in cui la tenuta dell’equilibrio globale dipende in modo eccessivo da un singolo paese, in cui le vicende interna (la questione sociale non risolta) si amplificano e generano ondate di instabilità che impattano a livello globale. Da oltre vent’anni, negli USA si registra una questione sociale irrisolta – diseguaglianze profonde, polarizzazione politica, degrado del consenso istituzionale – di cui Trump è un sintomo più che un’anomalia. In questo contesto, la capacità del paese di garantire prevedibilità e leadership multilaterale è seriamente compromessa. La necessità di un secondo punto di appoggio per l’ordine internazionale non è più un’opzione teorica, ma una condizione di stabilità sistemica sempre più necessaria. L’Unione europea rappresenta oggi l’unico attore in grado di assumere questa funzione, a partire dal rafforzamento dell’euro come valuta rifugio e dalla creazione di un mercato profondo di debito comune in grado di attrarre risparmio globale. Proviamo a fare qualche ragionamento.
Su quali leve psicologiche agiscono le fake news
Le fake news non fanno presa sul pubblico in modo casuale: per diffondersi con successo, esse agiscono su precise leve psicologiche insite nel modo in cui gli esseri umani percepiscono e valutano le informazioni. L’analisi di questi meccanismi mentali è fondamentale per comprendere perché anche persone istruite possano talvolta cadere vittima di notizie palesemente infondate. In questo articolo si adotta un approccio per tentare di sezionar i fattori cognitivi ed emotivi che rendono le fake news così persuasive.
Punti cardinali
"The Origins of Political Order" di Francis Fukuyama
Ne The Origins of Political Order, Francis Fukuyama ricostruisce l’evoluzione delle istituzioni politiche dall’epoca preumana fino alla Rivoluzione francese, articolando la sua analisi intorno a tre pilastri fondamentali: lo Stato, il primato del diritto e la responsabilità del governo. L’opera non intende fornire una narrazione cronologica, ma analizzare comparativamente le traiettorie seguite da società differenti nel costruire sistemi politici complessi. Fukuyama assume una prospettiva evolutiva, integrando contributi di storia, antropologia, sociologia e biologia per spiegare le radici della coesione sociale, le modalità di superamento dell’organizzazione tribale e l’emergere di forme statali centralizzate. Ogni società ha compiuto un percorso specifico, ma alcuni modelli ricorrenti si ripresentano in contesti distanti. L’autore rifiuta le teorie lineari e deterministiche, sottolineando come l’evoluzione istituzionale sia spesso frutto di contingenze, conflitti e innovazioni involontarie. L’obiettivo è chiarire le condizioni storiche che hanno reso possibile la combinazione di autorità statale, legalità e responsabilità politica, e mostrare come questi elementi si siano affermati in tempi e modalità differenti in Cina, India, Medio Oriente ed Europa. L’interesse per l’origine delle istituzioni risponde a una necessità attuale: comprendere perché alcuni stati contemporanei siano deboli, corrotti o incapaci di assicurare ordine e prosperità. Il primo volume si ferma al Settecento, ma pone le basi teoriche per affrontare la questione della modernizzazione politica nel mondo contemporaneo. L’intero lavoro è orientato a identificare non un modello ideale, ma una griglia analitica utile a confrontare i diversi esiti dell’evoluzione istituzionale.
"The Power of Myth" di Joseph Campbell
Nel libro The Power of Myth, Joseph Campbell, in dialogo con il giornalista Bill Moyers, riflette sul ruolo dei miti nell’esperienza umana. Secondo Campbell, l’uomo non cerca tanto un significato astratto della vita, ma un’esperienza che gli consenta di sentirsi vivo. I miti, come narrazioni collettive, permettono di attraversare i passaggi cruciali dell’esistenza: nascita, maturità, morte e rinnovamento. Non sono da intendersi come racconti letterali, ma come strumenti simbolici capaci di rivelare verità interiori profonde. Essi parlano in modo figurato di ciò che accade nell’animo umano, accompagnando il soggetto nei momenti di trasformazione. In un mondo disincantato e secolarizzato, dove le narrazioni religiose perdono forza, i miti continuano a offrire un linguaggio per confrontarsi con le questioni ultime. Campbell insiste sul fatto che il mito deve toccare l’interiorità e aprire l’individuo alla comprensione di sé e del mondo. Non si tratta di aderire a un sistema dogmatico, ma di riconoscere negli archetipi mitici le strutture universali dell’esperienza umana. In questo senso, il mito diventa uno strumento educativo, spirituale e culturale. Esso aiuta a superare il senso di frammentazione tipico dell’età moderna e offre un linguaggio per articolare le emozioni e i desideri fondamentali. Il mito funziona come una mappa interiore, capace di orientare l’individuo nel suo percorso esistenziale. Campbell vede nella perdita del mito una delle cause del disorientamento e della crisi spirituale del mondo contemporaneo.
"Le origini del totalitarismo" di Hannah Arendt
Nel saggio Le origini del totalitarismo, pubblicato nel 1951, Hannah Arendt analizza la genesi e lo sviluppo del totalitarismo come nuova forma di potere politico. Il libro si articola in tre sezioni: l’antisemitismo, l’imperialismo e il totalitarismo propriamente detto. Arendt sostiene che i regimi totalitari del Novecento, in particolare il nazismo e lo stalinismo, rappresentano una discontinuità radicale rispetto a ogni precedente forma di governo, poiché mirano al dominio totale sull’uomo. L’opera si propone di comprendere il totalitarismo nei suoi elementi strutturali e storici, individuando le condizioni che ne hanno permesso l’affermazione. Arendt rifiuta ogni spiegazione fondata sull’irrazionalità o sulla contingenza e sottolinea come l’emergere del totalitarismo sia stato reso possibile dalla crisi dello Stato-nazione, dal fallimento dell’idea di diritti universali e dall’atomizzazione degli individui. L’obiettivo dell’autrice è restituire alla riflessione politica la capacità di giudicare e di resistere, opponendosi alla banalità del male e all’indifferenza. Il libro è anche un appello alla responsabilità individuale di fronte ai processi storici distruttivi.
Eleatiche
È una pubblicazione di Stroncature dedicata alle imprese che ha come focus l’impatto delle nuove tecnologia sul business, sulle nuove opportunità e possibilità che si aprono.
Crisi cicliche e settori tradizionali: come trasformare la vulnerabilità in resilienza
L’economia italiana, fortemente basata su settori industriali tradizionali (come la meccanica, la moda, l’arredamento, l’alimentare), è periodicamente soggetta alle oscillazioni dei cicli economici globali. Le cosiddette crisi cicliche – recessioni o forti rallentamenti che si verificano in media ogni 7-10 anni per effetto di shock finanziari, energetici o di domanda – colpiscono in modo particolare i settori manifatturieri durevoli, cioè quelli che producono beni il cui acquisto può essere posposto nei periodi difficili. Ad esempio, durante la Grande Recessione 2008-2009 la produzione manifatturiera italiana subì cali a doppia cifra percentuale, più accentuati della contrazione del PIL complessivo. Studi sull’economia statunitense hanno mostrato che nell’industria dei beni durevoli il calo di produzione in recessione è circa doppio rispetto alla media dell’economia. Tuttavia, questi settori tendono anche a rimbalzare più velocemente quando torna la crescita, recuperando terreno più rapidamente del resto dell’economia. Ciò suggerisce che i settori tradizionali, pur altamente ciclici, possono adottare modelli di adattamento che li aiutino a sopravvivere alle fasi avverse e a sfruttare appieno le riprese.