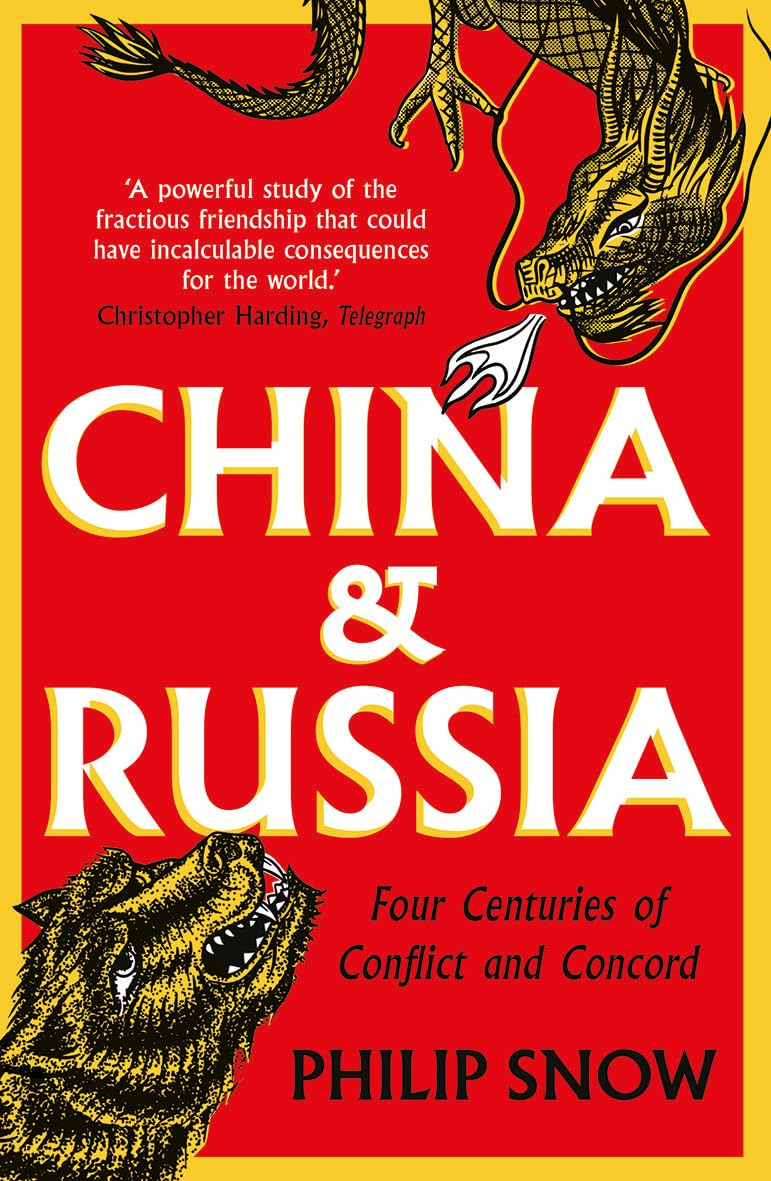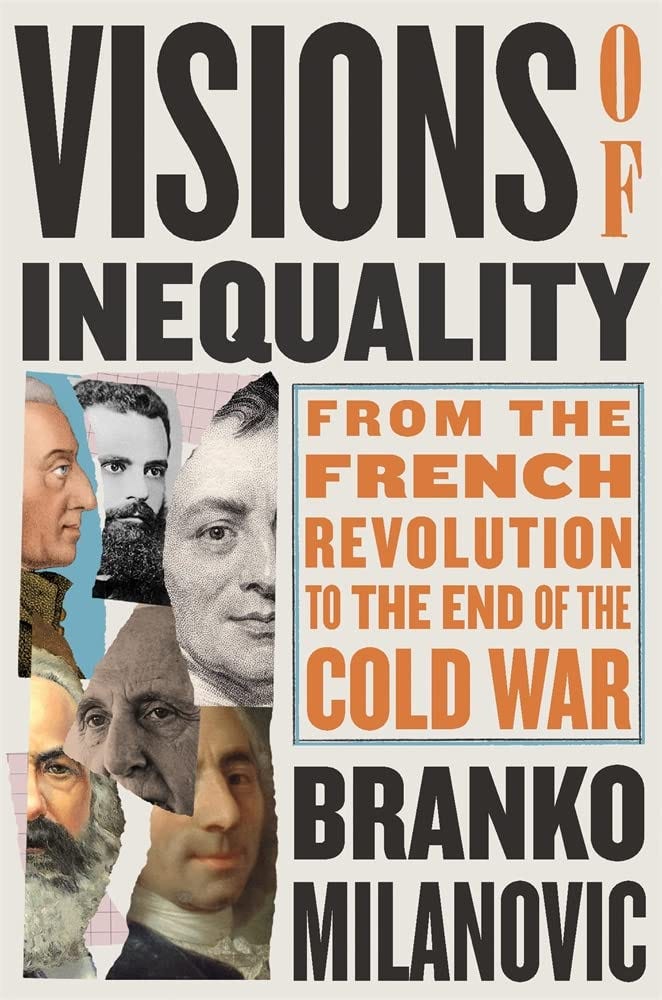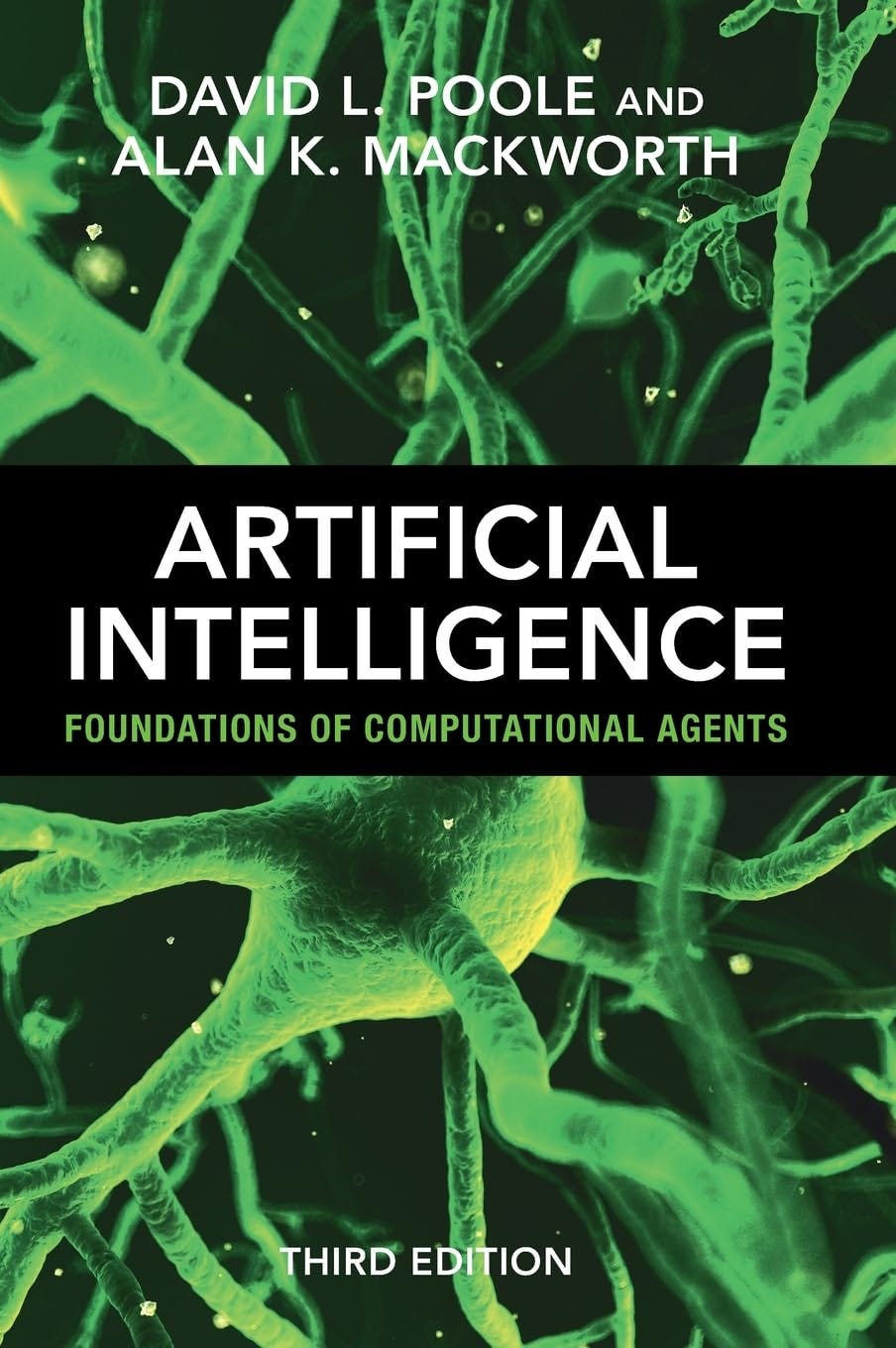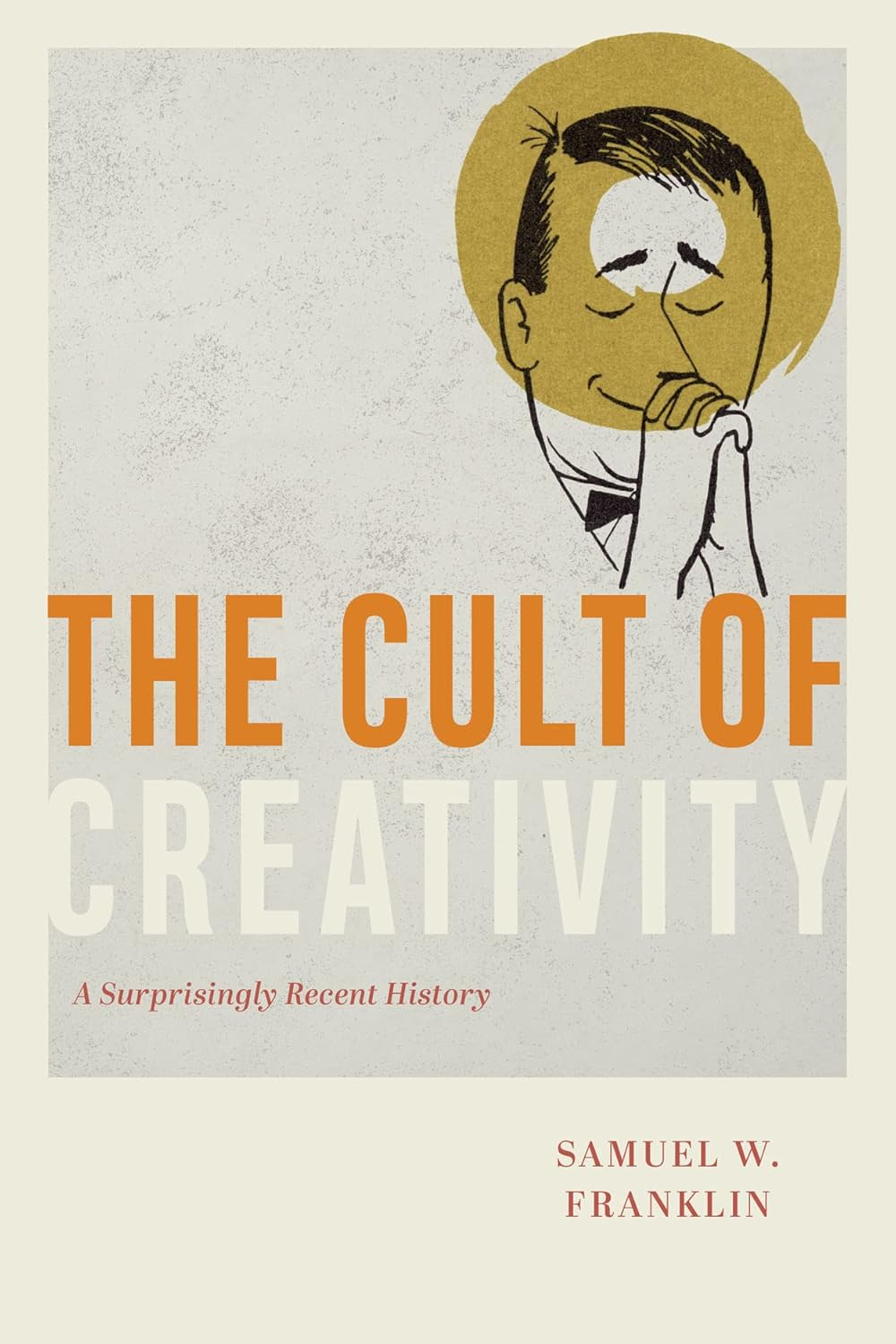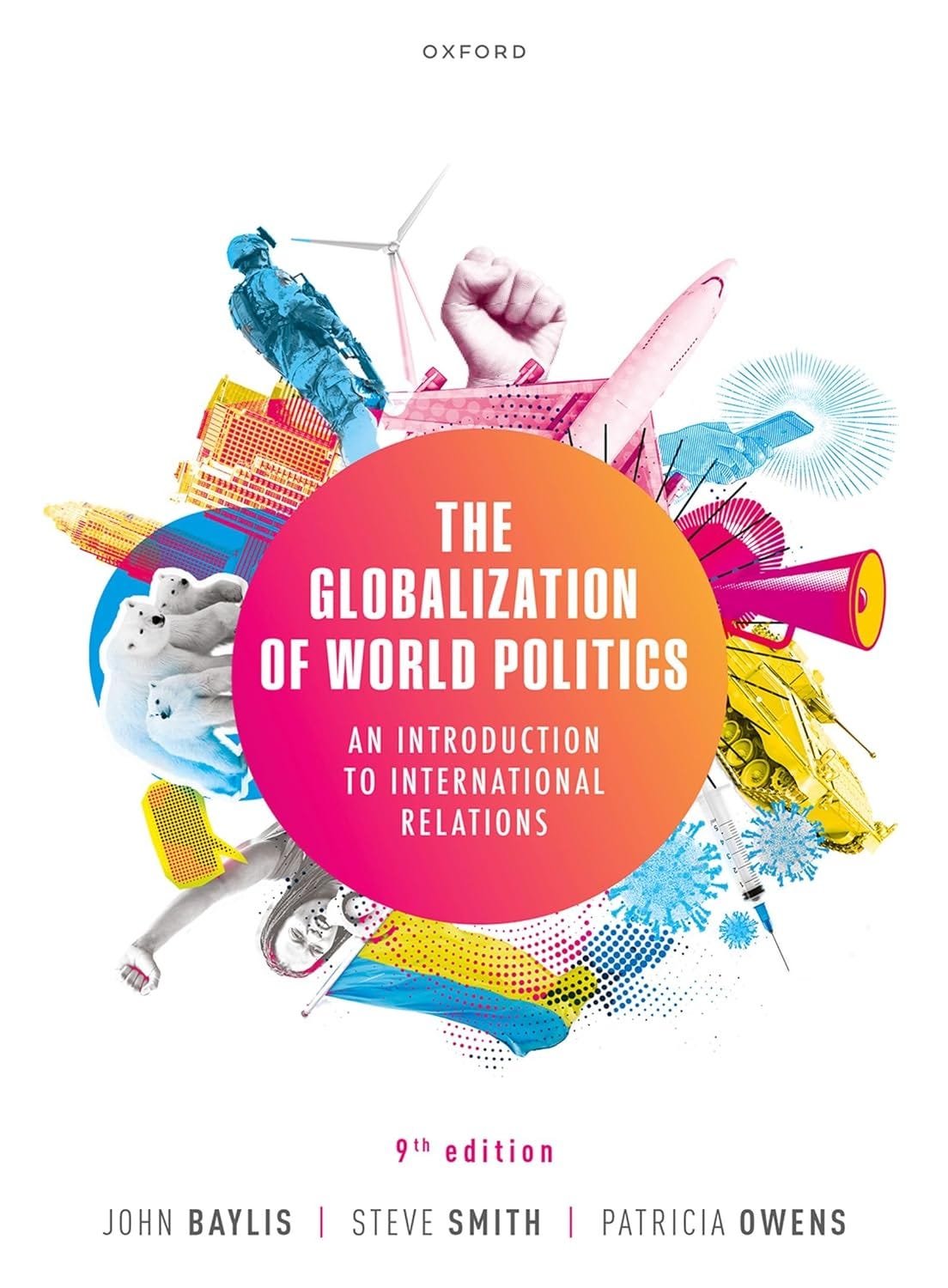Punti cardinali #26
Punti Cardinali è il servizio di Stroncature dedicato alla selezione, analisi e sintesi dei più importanti saggi pubblicati all’estero, in lingua originale, e non ancora tradotti o distribuiti in Italia. Per ogni testo viene redatta una scheda dettagliata e approfondita che consente di accedere a tutti i contenuti del libro, alle sue tesi, concetti ed argomentazioni, in modo completo.
I vantaggi sono enormi. In breve tempo è possibile accedere ai contenuti completi di testi di saggistica di grande complessità e di difficile accesso, potendo spaziare dalle scienze sociali a quelle della natura, e facendo così propri in modo facile ed economico i frutti della ricerca dei maggiori studiosi e studiose e delle più prestigiose case editrici a livello globale, come se si fosse letto l’intero libro.
Abbonandosi a Stroncature si accede all’archivio completo di Punti Cardinali, aggiornato settimanalmente, che raccoglie già migliaia di volumi della saggistica globale.
"China and Russia. Four Centuries of Conflict and Concord" (Yale University Press, 2023) di Philip Snow
Il libro di Philip Snow propone una ricostruzione di quattro secoli di rapporti tra Cina e Russia, due potenze che condividono una lunghissima frontiera ma che, nonostante la vicinanza geografica, hanno avuto relazioni segnate da oscillazioni continue tra diffidenza, rivalità e momenti di cooperazione. L’autore, storico specializzato nelle relazioni eurasiatiche, adotta una prospettiva di lunga durata che consente di leggere la storia sino-russa come un susseguirsi di conflitti e accomodamenti, senza mai giungere a una stabilità definitiva. L’impostazione non è soltanto cronologica, ma intreccia la narrazione storica con riflessioni geopolitiche e culturali. Snow parte dal XVII secolo, con l’espansione russa verso est e i primi contatti con la dinastia Qing, e giunge fino al XXI secolo, analizzando la cooperazione attuale seguita all’invasione russa dell’Ucraina. L’obiettivo è mostrare come, al di là dei contesti contingenti, vi siano linee di continuità che rendono la relazione strutturalmente ambivalente. Il libro si rivolge a un pubblico ampio, non limitato agli specialisti, e presenta in modo accessibile trattati, guerre, alleanze e divergenze che hanno segnato l’intera storia moderna ed economica di Eurasia.
"Visions of Inequality. From the French Revolution to the End of the Cold War" di Branko Milanovic
Il libro di Branko Milanovic, Visions of Inequality. From the French Revolution to the End of the Cold War, è un percorso nella storia delle idee che hanno cercato di spiegare, descrivere e valutare l’ineguaglianza economica dall’età della Rivoluzione francese fino alla fine della Guerra fredda. L’autore, noto economista specializzato nello studio della distribuzione del reddito e della ricchezza, sceglie un approccio che non si limita alla presentazione dei dati, ma ricostruisce il modo in cui gli economisti e i filosofi hanno concettualizzato l’ineguaglianza nei diversi contesti storici. La sua tesi di fondo è che nessuna visione dell’ineguaglianza sia neutrale: ogni autore, da Quesnay a Nozick, ha elaborato una rappresentazione della distribuzione dei redditi che rispecchiava i problemi, i conflitti e le trasformazioni della propria epoca. Milanovic organizza il testo in capitoli dedicati a figure centrali come Quesnay, Smith, Malthus e Ricardo, Marx, Pareto, Bowley, Kuznets, Rawls e Nozick. Per ciascuno di essi mette in evidenza non solo la struttura teorica, ma anche i casi concreti a cui si riferivano: la crisi della società agraria francese, la rivoluzione industriale, la lotta di classe ottocentesca, la stabilità delle quote di reddito nel Novecento, l’ottimismo del dopoguerra e il confronto filosofico degli anni Settanta. In questo modo, il libro non offre solo una storia dell’economia, ma anche una storia sociale e politica dell’idea stessa di giustizia economica.
"Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents" di David L. Poole e Alan K. Mackworth
Il libro Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents si apre con un obiettivo ambizioso e ben definito: costruire una cornice concettuale rigorosa dell’intelligenza artificiale intesa come studio degli agenti computazionali. Gli autori non si limitano a raccogliere tecniche e algoritmi, ma propongono un quadro sistematico in cui ogni elemento — percezione, ragionamento, apprendimento, azione — è compreso come parte di un sistema integrato. L’approccio è fondazionale: l’IA non è presentata come insieme disordinato di strumenti, ma come disciplina scientifica che studia come agenti autonomi possano agire razionalmente in ambienti complessi e incerti. Fin dalle prime pagine gli autori introducono la nozione centrale di “agente razionale”, definito come un’entità che percepisce l’ambiente attraverso sensori e agisce tramite attuatori, scegliendo le azioni che massimizzano un criterio di prestazione. Questo concetto funge da filo conduttore del volume, che si sviluppa in modo progressivo, partendo da strumenti di base come la logica proposizionale, per arrivare a tecniche avanzate come le reti bayesiane, i processi decisionali di Markov, i metodi di apprendimento e le architetture multi-agente. Lo stile rimane costantemente didattico: ogni teoria è accompagnata da esempi e applicazioni, che permettono di vedere come i principi trovino riscontro in situazioni concrete, dalla diagnostica medica ai sistemi robotici.
"The Cult of Creativity. A Surprisingly Recent History" di Samuel W. Franklin
Il libro di Samuel W. Franklin, The Cult of Creativity. A Surprisingly Recent History, parte da un presupposto tanto semplice quanto destabilizzante: ciò che oggi consideriamo un attributo naturale dell’essere umano, ovvero la creatività, è in realtà una costruzione storica sorprendentemente recente. L’autore invita il lettore a riflettere sul fatto che la parola stessa “creativity” non faceva parte del vocabolario comune fino alla metà del Novecento, e che la sua ascesa a concetto cardine nella psicologia, nell’educazione, nel management e nella cultura popolare americana si colloca tra gli anni Quaranta e Sessanta. L’obiettivo dichiarato di Franklin è quello di smontare l’apparente naturalità del termine, mostrando come sia nato in circostanze precise, rispondendo a esigenze contingenti e assumendo via via lo statuto di valore universale. In questo senso, il libro non è solo una storia della creatività, ma una genealogia che mostra come la categoria sia stata inventata, istituzionalizzata e infine celebrata come culto. Franklin affronta la questione intrecciando storia intellettuale, analisi culturale e ricostruzione politica, muovendosi tra gli archivi della psicologia accademica, i documenti governativi della Guerra fredda, le pratiche scolastiche, i manuali di business e le retoriche pubblicitarie. Il suo intento non è demolitorio, ma critico: mostrare che la creatività non è un’essenza eterna, bensì un dispositivo culturale che ha avuto successo perché capace di rispondere a tensioni profonde delle società moderne.
The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations
Il manuale The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations è pensato come il punto di partenza per comprendere lo studio delle relazioni internazionali in chiave contemporanea. A differenza di altre opere introduttive, che si limitano a proporre una panoramica rapida delle principali teorie, il volume curato da John Baylis, Steve Smith e Patricia Owens costruisce un percorso sistematico che integra approcci teorici, contesto storico, strutture istituzionali e temi globali. L’obiettivo degli autori è rendere accessibile un campo di studi complesso senza rinunciare al rigore analitico. Per questo motivo il testo si articola in più parti: si apre con un’introduzione alla globalizzazione e al significato stesso delle relazioni internazionali, prosegue con un inquadramento storico che dal sistema westfaliano conduce fino alla fine della Guerra fredda, dedica un ampio segmento alle teorie – dal realismo al costruttivismo fino agli approcci critici come femminismo e postcolonialismo – e affronta poi le strutture centrali (guerra, sicurezza, economia, diritto internazionale, ONU, regionalismo), concludendo infine sui temi trasversali: ambiente, salute, terrorismo, povertà, diritti umani. L’impostazione complessiva è pluralista, perché non propone una singola teoria dominante, ma invita a considerare come diverse prospettive possano illuminare differenti aspetti di uno stesso fenomeno.