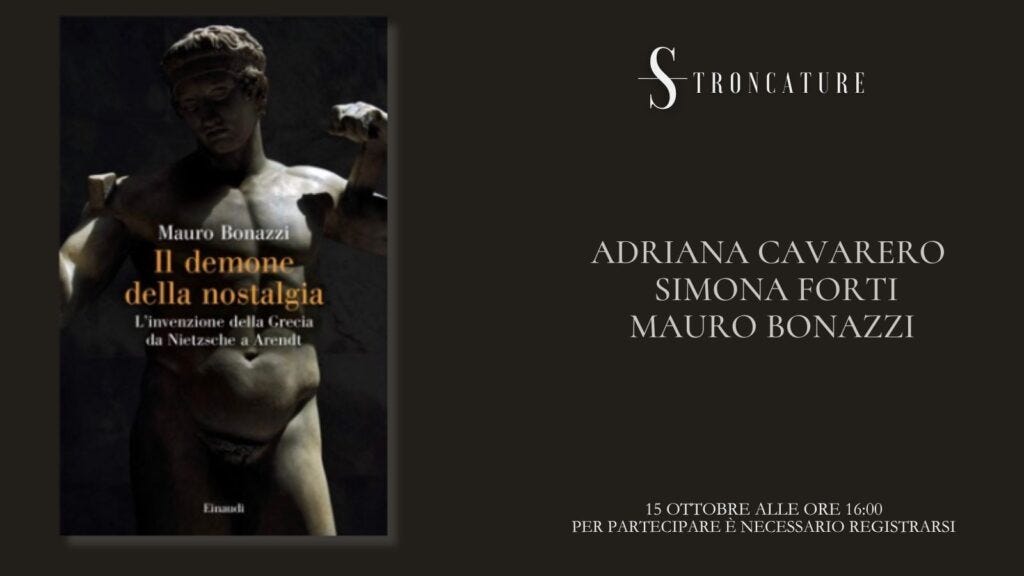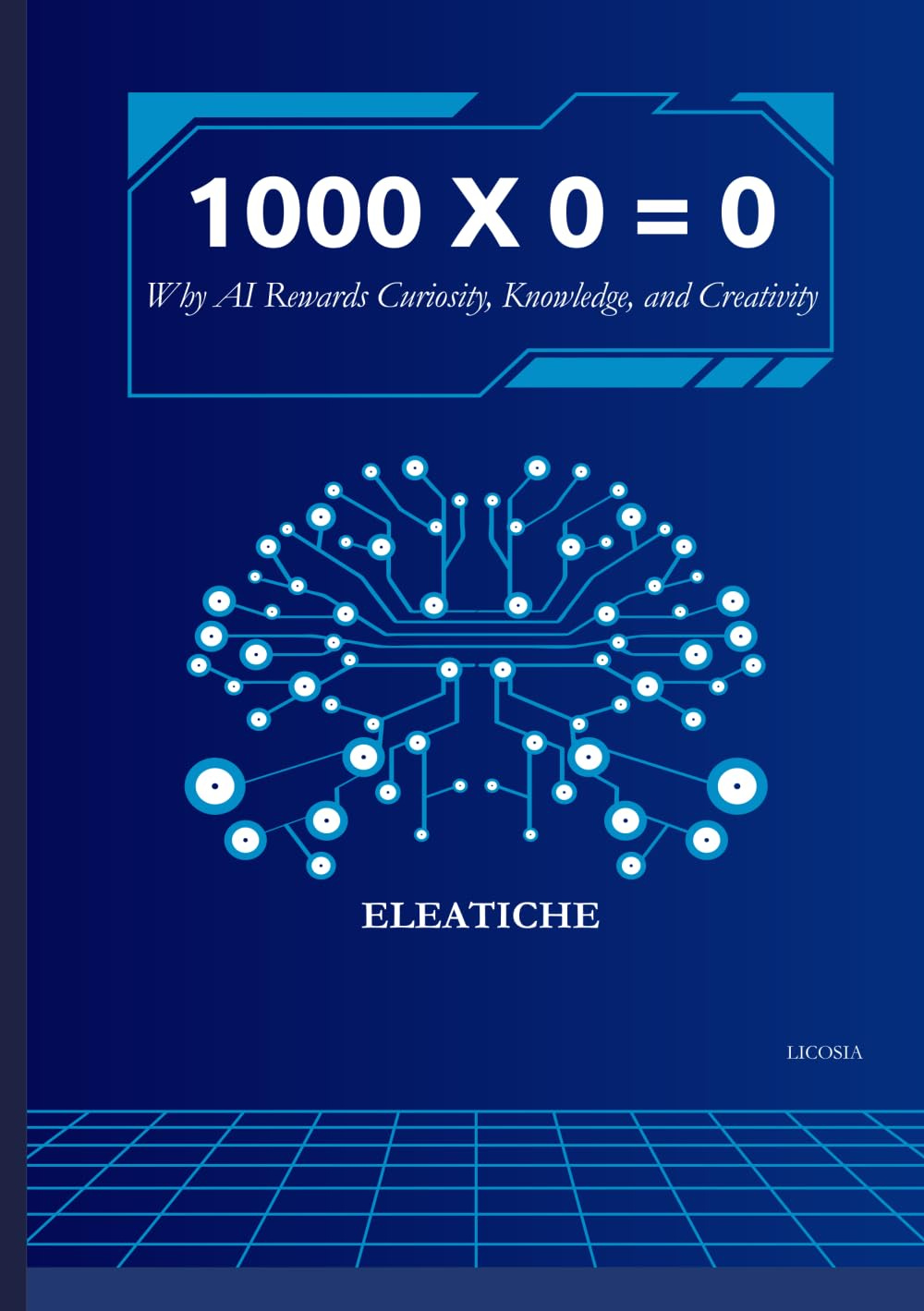Stroncature Digest #100
Stroncature è la piattaforma per la Terza missione, per la disseminazione scientifica e culturale e il trasferimento tecnologico. In collaborazione con Università ed Enti di ricerca pubblici produce contenuti e formati (video, podcast, testi divulgativi, infografiche) che servono alla diffusione, valorizzazione e trasferimento dei frutti della ricerca pubblica, nella convinzione che l’Università e la Ricerca, in una economia della conoscenza, siano il vero motore di progresso sociale e sviluppo economico. C’è di più: c’è la convinzione che raccontare le storie della Ricerca, le sfide a cui ricercatori e ricercatrici, studiose e studiosi dedicano la loro esistenza sia il modo migliore per suscitare l’entusiasmo delle giovani menti, per accettare la sfida a risolvere problemi sempre più complessi e difficili, spostando così un po’ più in là il confine che separa il noto e a ridurre il campo dell’ignoto.
Valori, ideali e neutralità nelle scienze sociali
È possibile che i valori personali e gli ideali politici o culturali di uno studioso o di una studiosa delle scienze sociali possano condizionare, alterare o addirittura offuscare i risultati della loro ricerca? Questa domanda rappresenta uno dei nodi più complessi della riflessione epistemologica in questo campo. A differenza delle scienze naturali, che trattano oggetti inanimati e processi indipendenti dall’osservatore, le scienze sociali si confrontano con soggetti umani, portatori di significati, intenzioni e visioni normative. Il ricercatore o la ricercatrice non osserva dall’esterno, ma sceglie, interpreta e ricostruisce fenomeni che hanno già un carico simbolico e valoriale. Ne consegue che la pretesa di neutralità assoluta appare problematica: la selezione degli oggetti di studio, la formulazione delle domande, la definizione delle categorie concettuali possono essere influenzate, consapevolmente o meno, dai valori del ricercatore o della ricercatrice. La questione diventa allora: come conciliare il rigore scientifico con l’inevitabile presenza di presupposti normativi?
“Leggere Salman Rushdie” di Silvia Albertazzi (Carocci editore, 2025)
Lo scorso 26 settembre, Stroncature ha ospitato la presentazione del libro “Leggere Salman Rushdie” di Silvia Albertazzi (Carocci editore, 2025). Il volume propone un’introduzione complessiva all’opera di Salman Rushdie, non limitandosi alla sua vicenda biografica più nota – la condanna a morte pronunciata da Khomeini nel 1989 per I versi satanici e il successivo attentato del 2022 – ma analizzando l’intera produzione letteraria, dal romanzo d’esordio Grimus (1975) fino al memoir Coltello pubblicato nel 2024. Al centro dell’analisi vi è la “mitografia fantastica” che caratterizza la scrittura di Rushdie, una poetica che intreccia realismo magico, memoria storica e consapevolezza ideologica dell’atto narrativo. L’autore viene così presentato come uno “scrittore contro” per eccellenza: capace di sfidare le ortodossie, di reinventare identità e genealogie culturali, e di affermare la centralità della finzione nella costruzione del pensiero critico contemporaneo. Con l’autrice dialogano: il prof. Mauro Pala la prof.ssa Valentina Vetri.
“Il demone della nostalgia” di Mauro Bonazzi
Il prossimo 15 ottobre alle 16:00, Stroncature ospiterà la presentazione del libro “Il demone della nostalgia” di Mauro Bonazzi (Einaudi, 2025). Il saggio di Mauro Bonazzi ricostruisce una delle grandi battaglie culturali dell’Europa tra Otto e Novecento: il confronto con l’eredità della Grecia antica. In un’epoca segnata da inquietudine e trasformazioni radicali, filosofi, filologi e intellettuali guardano alla Grecia come a una patria perduta, origine simbolica da cui sentirsi esuli ma a cui tornare per interrogarsi su chi siamo. Il libro esplora il ruolo del passato nella definizione dell’identità europea e occidentale, sia individuale sia collettiva. Attraverso le letture, spesso contrastanti, di autori come Nietzsche, Heidegger, Adorno, Popper e Arendt, Bonazzi mostra come la Grecia sia stata costantemente reinventata per rispondere alle crisi della modernità. Ne emerge un’idea di passato tutt’altro che pacificata: un terreno di scontro da cui continua a dipendere la forma del nostro futuro. Con l’autore dialogheranno: la prof.ssa Adriana Cavarero e la prof.ssa Simona Forti. Modera l’incontro Riccardo Pennisi. Per partecipare è necessario registrarsi.
Licosia
1000 × 0 = 0: Why AI Rewards Curiosity, Knowledge, and Creativity is not a book about AI itself, but about how to live and work with it.
It shows why AI does not replace human work but multiplies it – and why, without skills, data, and creativity, the result is still zero.
Clear, rigorous, and accessible, it explains how AI is transforming careers, business models, education, and institutions.
A book for professionals, educators, policymakers, and leaders who want to understand not just the risks, but the opportunities of the AI era.