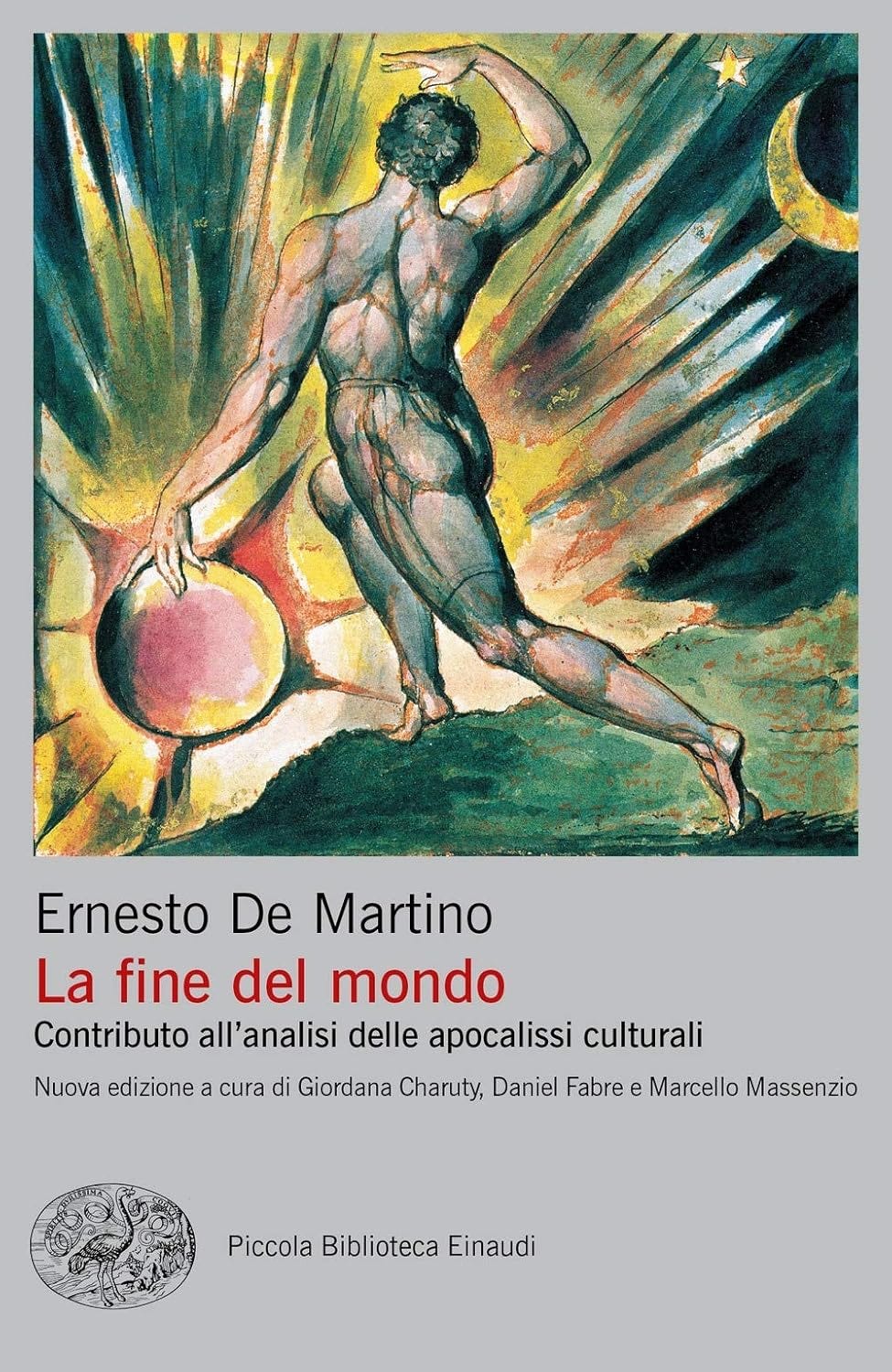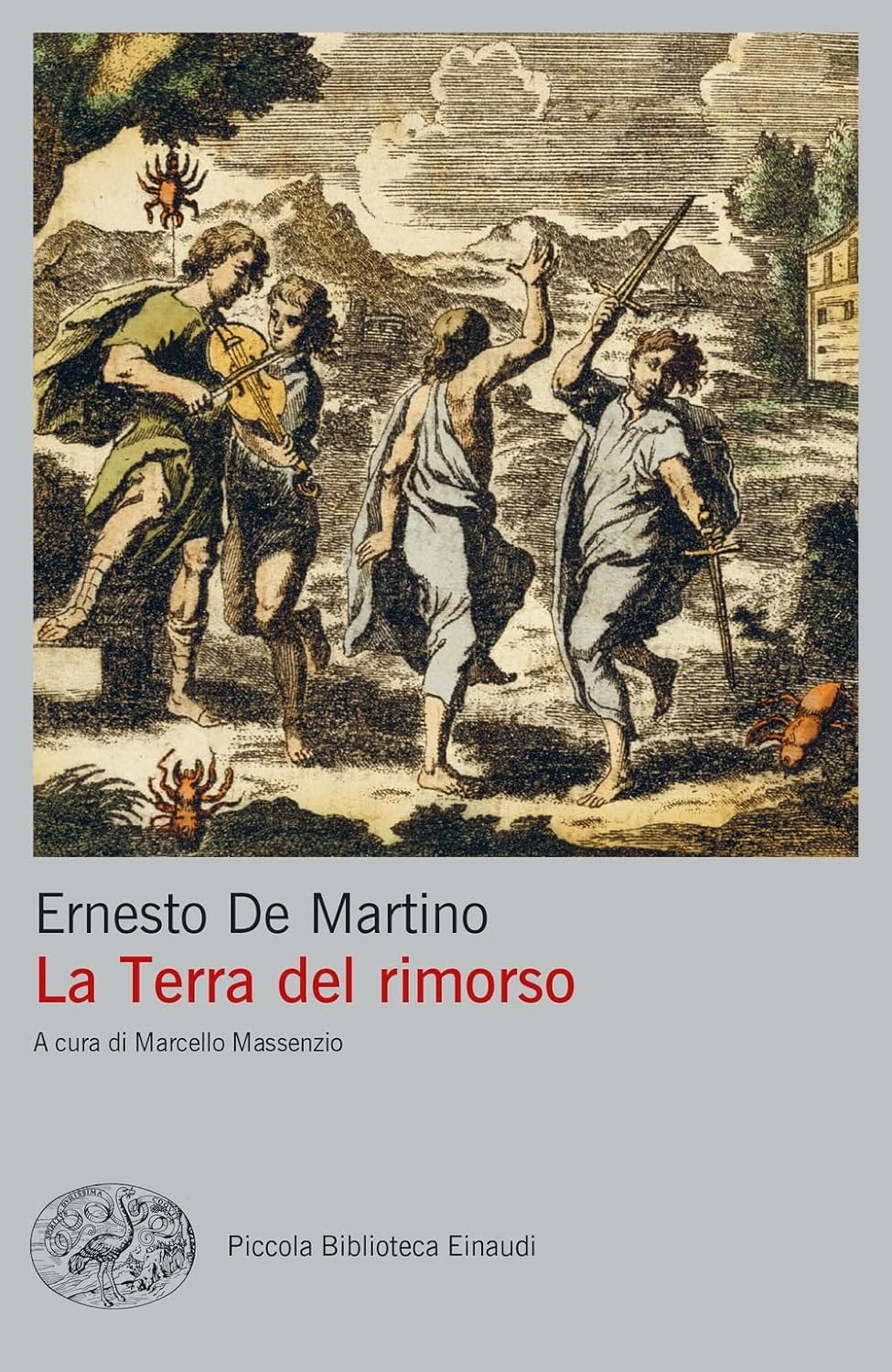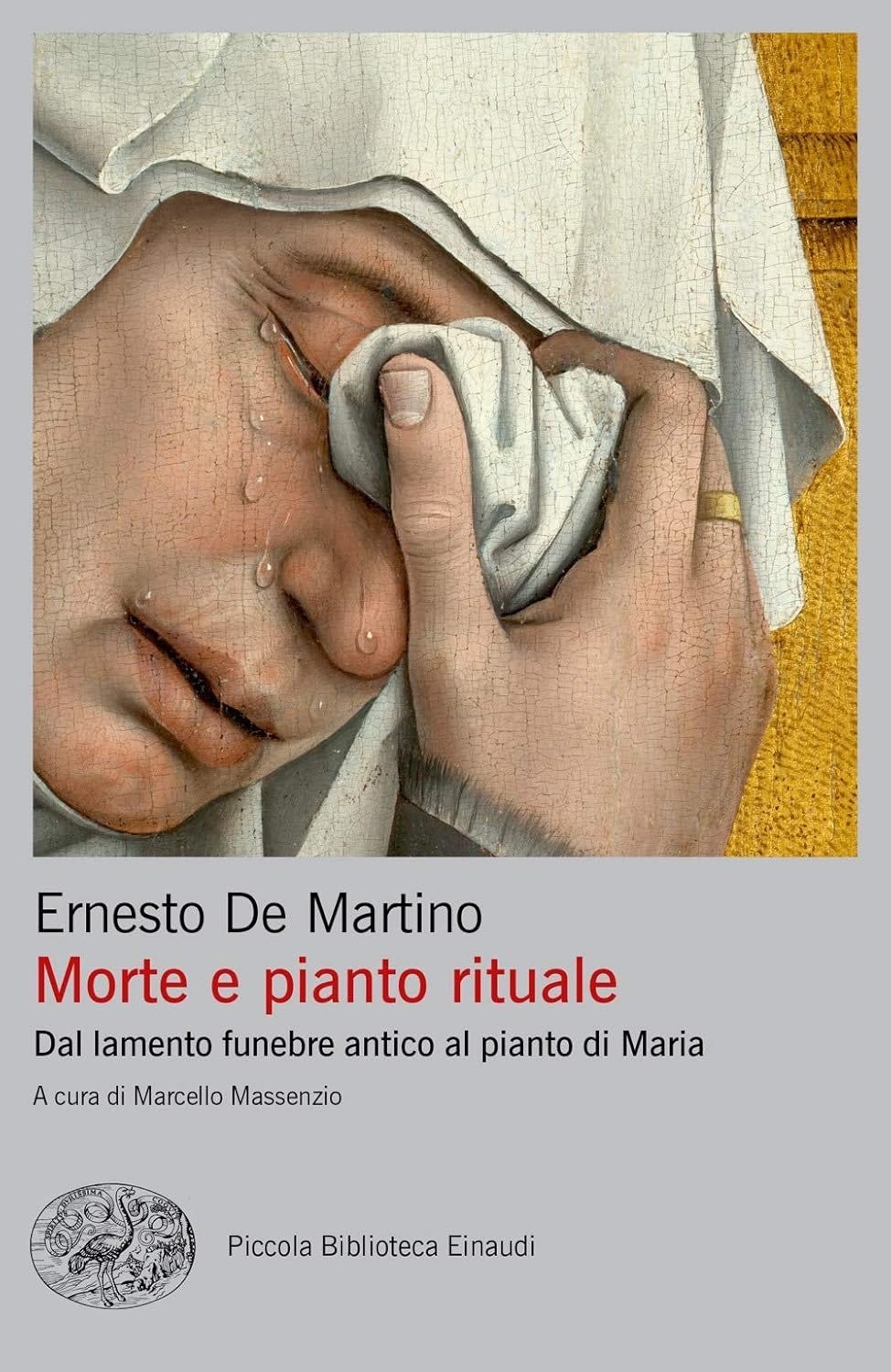Stroncature Digest #43
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce analisi basate sulla complessità e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della ricerca, contribuendo alla terza missione delle università. L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico e società. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e dell’engagement. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità, Stroncature propone un modello alternativo: pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
Analisi & Ricerche
Causalità, meccanismi e spiegazione scientifica
Gran parte della scienza mira a rispondere alla domanda “perché?”: perché avviene un certo fenomeno, qual è la sua causa o il suo meccanismo sottostante. La causalità occupa dunque un ruolo centrale nella spiegazione scientifica. Intuire nessi causa-effetto permette non solo di comprendere i fenomeni, ma anche di prevederli e controllarli. Ad esempio, identificare la causa di una malattia (un virus) consente di spiegare i sintomi e sviluppare cure. Tuttavia, la nozione di causa ha anche posto sfide filosofiche: da Hume in poi ci si interroga su cosa significhi che A “causa” B (è una regolarità costante? un rapporto di dipendenza controfattuale? una produzione fisica?). Nonostante queste articolazioni, nella pratica scientifica si opera tipicamente con l’idea che determinati fattori producano determinati effetti secondo leggi o meccanismi.
Intelligenza sistemica
L’intelligenza sistemica è la capacità di analizzare fenomeni tenendo conto delle interdipendenze, delle retroazioni e degli effetti non intenzionali che ogni azione può generare in un sistema complesso. Le attività di analisi di Stroncature si pongono questo obiettivo: rendere complesso ciò che sembra semplice.
Falsificabilità e complessità: cosa resta del metodo scientifico?
L’avvento della complessità come paradigma scientifico ha sollevato interrogativi sulla validità e l’applicabilità dei criteri classici del metodo scientifico, primo fra tutti quello di falsificabilità di una teoria (reso celebre da Karl Popper). In campi come la fisica o la chimica, un esperimento controllato può spesso confermare o confutare con chiarezza una previsione teorica. Ma nei sistemi complessi – si pensi all’economia, all’ecologia, alle scienze sociali – le cose sono meno nitide: le teorie abbracciano tanti fattori interagenti che le loro previsioni sono per lo più probabilistiche o qualitative; inoltre gli “esperimenti” nel mondo reale sono difficili se non impossibili da eseguire in condizioni controllate. Di conseguenza, alcuni studiosi hanno messo in dubbio che la falsificabilità, intesa in senso rigido, sia un criterio operativo in questi campi, arrivando persino a parlare di crisi del metodo scientifico tradizionale. È dunque lecito chiedersi: cosa resta del metodo scientifico nello studio della complessità? Dobbiamo abbandonare l’ideale popperiano oppure reinterpretarlo?
Punti cardinali
"La fine del mondo" di Ernesto De Martino
L’opera postumo di Ernesto De Martino, La fine del mondo, si presenta come una riflessione teorica e antropologica sulla crisi della presenza umana nel proprio orizzonte culturale. L’espressione "fine del mondo" non si riferisce a una catastrofe cosmica, ma all’esperienza vissuta del crollo del proprio mondo storico e simbolico. L’opera esplora le modalità attraverso cui le società storiche hanno affrontato queste crisi tramite dispositivi simbolici e religiosi. Il volume è composto da materiali redatti in varie fasi, raccolti e riorganizzati in forma unitaria dai curatori, ed esprime un pensiero che connette storia delle religioni, antropologia, filosofia e psichiatria. De Martino individua nell’apocalisse culturale un evento critico che colpisce la capacità dell’uomo di orientarsi storicamente, minacciando la tenuta del suo mondo di senso.
"La terra del rimorso" di Ernesto De Martino
Nel La terra del rimorso di Ernesto De Martino analizza il fenomeno del tarantismo nel Salento, indagandone le radici, le manifestazioni rituali e il significato culturale all’interno di una prospettiva storico-religiosa. La ricerca, condotta nel 1959 con una équipe interdisciplinare, mira a studiare le dinamiche simboliche e terapeutiche legate alla figura del ragno, al morso della taranta e al rituale coreutico-musicale che si svolge prevalentemente nel periodo estivo, culminando nella visita alla cappella di San Paolo a Galatina. De Martino considera il tarantismo come un caso esemplare di sopravvivenza culturale, in cui confluiscono elementi pagani, cristiani e magici, e che riflette, in forma drammatica, la crisi della presenza in ambienti segnati dalla marginalità sociale e dal disagio psichico. Il libro si inserisce nel più ampio progetto dell’autore di una storia religiosa del Sud come contributo alla comprensione delle tensioni fra cultura egemonica e subalternità. Il titolo richiama un’intera regione, la Puglia, e in senso più ampio l’intera Italia meridionale, come terra di un passato non scelto che ritorna e condiziona il presente. L'opera si caratterizza per la fusione tra indagine etnografica, riflessione teorica e partecipazione critica, facendo del tarantismo un osservatorio privilegiato della relazione tra cultura, simbolo e sofferenza.
"Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria" di Ernesto De Martino
Il libro Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, scritto da Ernesto De Martino e pubblicato nel 1958, analizza in profondità il modo in cui le culture affrontano la morte attraverso pratiche rituali. L’autore parte dal lamento funebre come risposta culturale alla crisi provocata dalla perdita di una persona cara. Secondo De Martino, ogni civiltà elabora strumenti simbolici per proteggere la “presenza” umana dal rischio di dissolversi nel dolore e nel disordine che la morte porta con sé. Il lamento rituale non è visto come una manifestazione emotiva spontanea, ma come una tecnica codificata, socialmente condivisa, che ha la funzione di disciplinare e orientare il cordoglio. Il testo unisce l’osservazione diretta di fenomeni contemporanei nel Sud Italia con lo studio storico delle pratiche funebri nell’antichità mediterranea. De Martino collega queste pratiche a una visione filosofica della cultura come mezzo per dare ordine e forma alle esperienze critiche. Il pianto rituale diventa quindi uno strumento per salvare la comunità e l’individuo dal disorientamento esistenziale che la morte genera. L’opera è strutturata su due piani: quello etnografico, basato su inchieste in Lucania, e quello storico, che ricostruisce l’evoluzione del lamento funebre fino all’epoca cristiana. L’intero discorso si fonda sulla relazione tra crisi, cultura e rito, attraverso l’idea centrale di “presenza”.
Eleatiche
Eleatiche è una piattaforma editoriale pensata per imprenditori, manager, consulenti e investitori che operano in contesti ad alta complessità. Offre analisi, guide operative e contenuti strutturati su innovazione, strategie d’impresa, modelli organizzativi e trasformazioni tecnologiche. Ogni giorno propone nuovi approfondimenti utili a orientare decisioni e interpretare i cambiamenti in corso. Gli abbonati accedono a contenuti completi, digest tematici e consulenze personalizzate. Uno strumento di lavoro per chi progetta il futuro dell’impresa. Tutti i contenuti e l’accesso all’archivio sono riservati agli abbonati a Eleatiche.
Ridondanza intelligente: come progettare sistemi che sopravvivono agli errori
Nel management degli ultimi decenni, dominato dall’ideale della massima efficienza, la ridondanza è spesso stata vista come uno spreco da eliminare. Tuttavia, in un’ottica di antifragilità, la ridondanza intelligente diventa un elemento progettuale fondamentale. Progettare sistemi che sopravvivono agli errorisignifica introdurre volutamente margini di sicurezza, duplicazioni e buffer capaci di assorbire gli shock senza collassi. Un sistema con ridondanza intelligente non è “snello” all’estremo, ma possiede risorse extra e percorsi alternativi che entrano in gioco quando qualcosa va storto. Questa filosofia, mutuata dall’ingegneria e dalla biologia (dove gli organismi spesso hanno organi accoppiati o funzioni sovrapposte per sicurezza), applicata all’impresa permette di evitare che un singolo errore locale si propaghi fino a compromettere l’intera organizzazione.