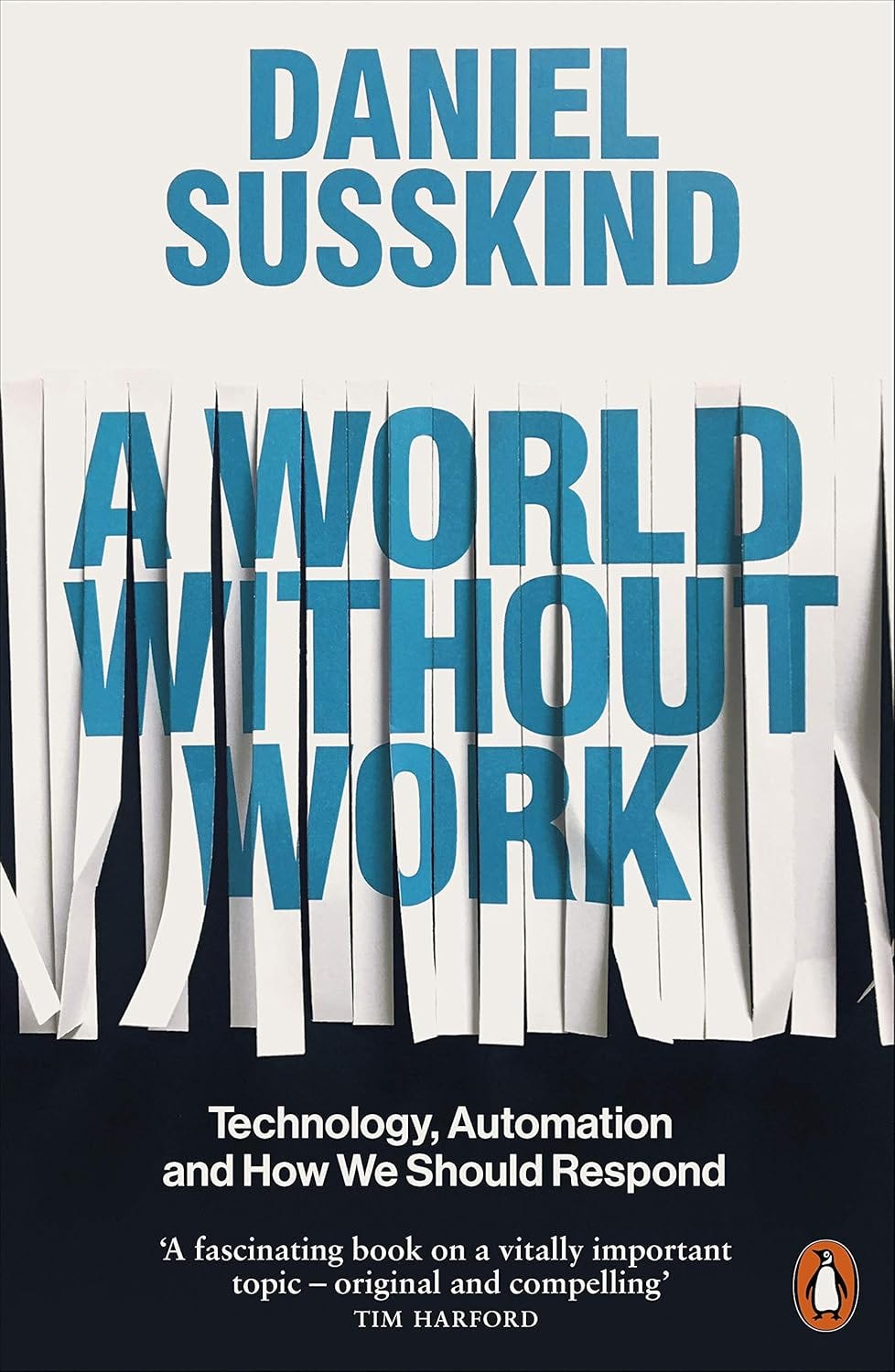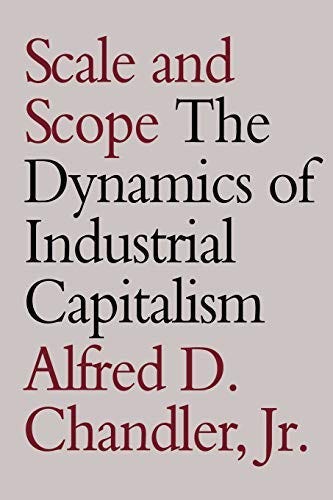Stroncature Digest #54
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce approfondimenti che hanno come metodo l’analisi delle conseguenze non intenzionali e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della Ricerca scientifica da loro condotta, contribuendo alla Terza Missione delle università (publica engagement, valorizzazione della ricerca, disseminazione, trasferimento tecnologico…). L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico, società e sistema produttivo. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e del clickbait. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
Tutti i contenuti prodotti da Stroncature a partire dal 2020 sono tutti consultatili sul sito
Analisi & Ricerche
L’etica computazionale dei modelli di moderazione automatica
Con l’enorme volume di contenuti generati online ogni minuto, le piattaforme digitali hanno fatto sempre più affidamento su modelli di moderazione automatica – algoritmi di intelligenza artificiale capaci di identificare e filtrare contenuti problematici (hate speech, pornografia non consensuale, incitamenti alla violenza, disinformazione ecc.). Ciò ha aperto un nuovo fronte di riflessione: l’etica computazionale di tali modelli, ovvero l’insieme di principi e questioni morali utilizzanti nel delegare a sistemi automatici decisioni su cosa sia lecito comunicare e cosa no. In pratica, questi algoritmi incarnano scelte di valore: devono stabilire i confini della libertà di espressione, tutelare gli utenti da contenuti nocivi bilanciando diritti e sensibilità diverse. Mentre un tempo tali scelte erano appannaggio di moderatori umani caso per caso, ora sono automatizzate su larga scala, con la velocità e fallibilità proprie delle macchine. L’etica computazionale si interroga su come garantire che questi “guardiani automatizzati” del discorso pubblico operino in modo giusto, trasparente e responsabile.
Il ritorno geopolitico del Mar Rosso
Contrariamente alle previsioni di una stabilizzazione seguita alla riduzione del conflitto in Yemen, il Mar Rosso è oggi teatro di una nuova crisi geopolitica di rilievo globale. L'escalation delle operazioni militari condotte dagli Houthi yemeniti, in particolare gli attacchi missilistici verso Israele e le azioni contro la navigazione commerciale nello stretto di Bab el-Mandeb, hanno trasformato la regione in un punto caldo della competizione strategica internazionale. Il 4 maggio 2025, un missile Houthi ha colpito nei pressi dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, provocando feriti e sospensione del traffico aereo, segnando una svolta nell'estensione del conflitto. Israele ha promesso ritorsioni, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione "Rough Rider", una campagna militare coordinata con il Regno Unito volta a colpire infrastrutture militari Houthi, tra cui il terminal petrolifero di Ras Isa, dove sono rimaste uccise oltre 80 persone.
Recensioni & Presentazioni
Punti cardinali
"A World Without Work" di Daniel Susskind
Nel libro A World Without Work, Daniel Susskind affronta il tema dell’automazione e del suo impatto sul mondo del lavoro. L’autore sostiene che la crescente capacità delle macchine di svolgere compiti un tempo esclusivamente umani porterà a una riduzione strutturale della domanda di lavoro umano. Non si tratta di una semplice crisi occupazionale temporanea, ma di una trasformazione di lungo periodo che mette in discussione la distribuzione della ricchezza e il ruolo sociale del lavoro. L’automazione non eliminerà ogni tipo di lavoro, ma modificherà radicalmente la quantità e la qualità delle occupazioni disponibili, ponendo nuove sfide sia economiche sia politiche. Il testo si articola attorno a tre interrogativi principali: quali lavori sopravvivranno, in che modo potrà essere distribuito il reddito in assenza di occupazione diffusa, e quali risposte istituzionali potranno sostenere la coesione sociale. Susskind analizza queste questioni combinando analisi economica, storica e tecnologica, e proponendo una riflessione sui limiti dei paradigmi attuali.
"Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism" di Alfred D. Chandler
Il libro analizza l’emergere e l’evoluzione dell’impresa industriale moderna tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento nei tre paesi industrializzati di riferimento: Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania. L’autore individua nella separazione tra proprietà e gestione un passaggio chiave verso una nuova forma di capitalismo, definita “manageriale”. In questo sistema, le decisioni operative e strategiche non sono più nelle mani dei proprietari, ma di manager salariati con competenze specialistiche. La creazione di queste imprese richiese investimenti simultanei in produzione, distribuzione e struttura amministrativa. I mutamenti tecnologici e infrastrutturali, in particolare nei trasporti e nelle comunicazioni, resero possibili economie di scala e di scopo, e aprirono la strada alla formazione di grandi imprese integrate verticalmente. Le gerarchie interne divennero strumenti indispensabili per coordinare processi complessi. Tali imprese si affermarono in settori con forti barriere all’entrata, generando strutture oligopolistiche stabili. Chandler sostiene che la managerializzazione della produzione fu il motore dell’espansione economica. Le imprese moderne non furono solo attori economici, ma istituzioni che plasmarono la struttura del capitalismo industriale.