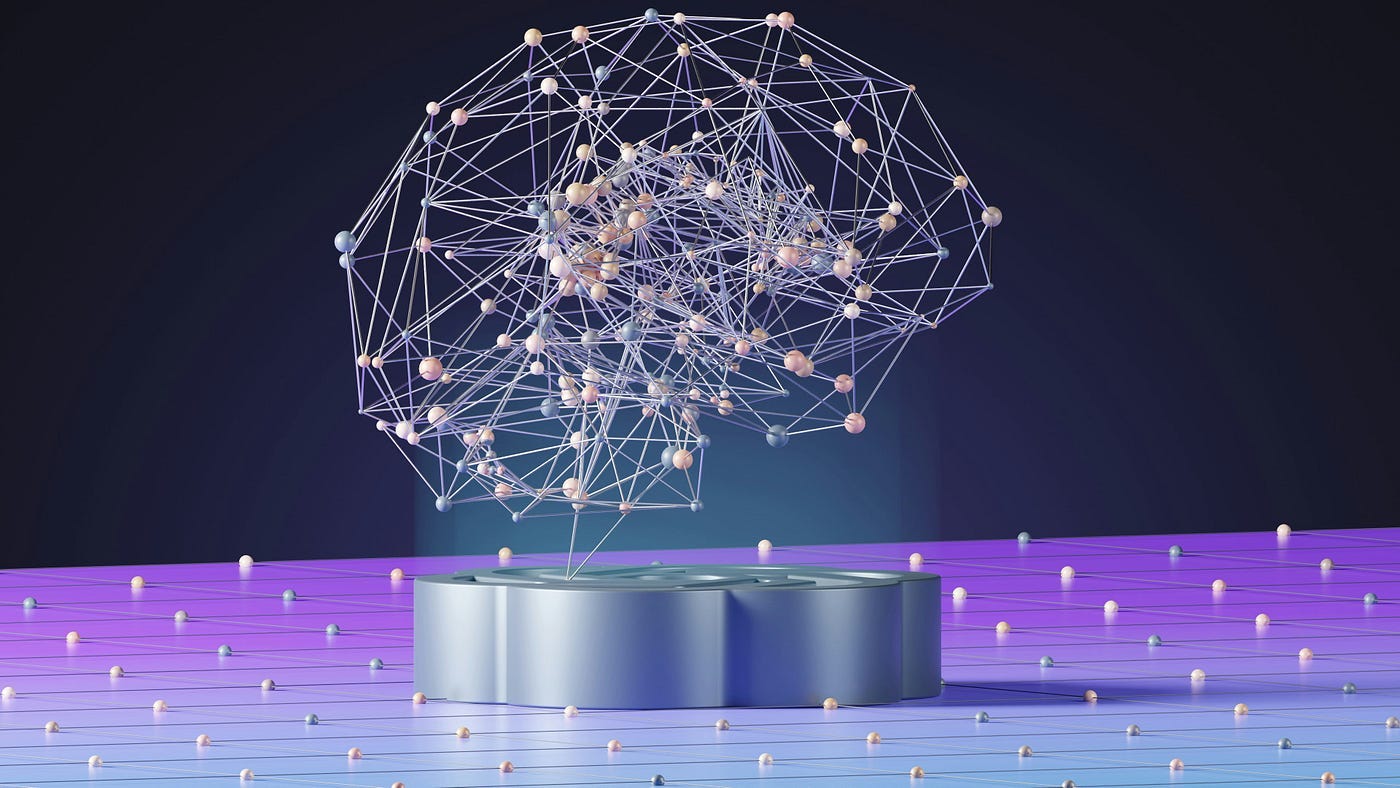Stroncature Digest #69
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce approfondimenti che hanno come metodo l’analisi delle conseguenze non intenzionali e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della Ricerca scientifica da loro condotta, contribuendo alla Terza Missione delle università (publica engagement, valorizzazione della ricerca, disseminazione, trasferimento tecnologico…). L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico, società e sistema produttivo. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e del clickbait. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
Tutti i contenuti prodotti da Stroncature (seminari, presentazioni, podcast, analisi, rubriche…) a partire dal 2020 sono tutti consultabili sul sito
Autonomia strategica: Materie prime critiche e filiere resilienti
La transizione verde e digitale dell’Europa ha messo in primo piano una verità scomoda: l’UE è altamente dipendente da forniture estere di materie prime critiche – come terre rare, litio, cobalto, nickel – indispensabili per tecnologie quali batterie, turbine eoliche, pannelli solari, semiconduttori. Questa dipendenza comporta vulnerabilità strategiche, poiché tali materiali provengono spesso da un numero ristretto di Paesi (in particolare la Cina, che oggi fornisce ad esempio oltre il 90% di alcune terre rare e il 60% del litio raffinato mondiale). Con il prevedibile boom di domanda legato agli obiettivi climatici, il rischio per l’Europa è di trovarsi in supply crunch o sotto ricatto economico se non diversifica e rafforza le proprie filiere. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, entro il 2030-2040 la domanda globale di elementi come cobalto e terre rare potrebbe quadruplicare. La Commissione stima che la sola domanda europea di litio per batterie aumenterà di 18 volte entro il 2030. Attualmente, l’UE importa il 98% delle terre rare e il 93% del magnesio dalla Cina, e situazioni simili valgono per altre materie prime critiche. Questo ha destato enorme preoccupazione fra i decisori europei, soprattutto dopo che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno evidenziato la fragilità delle catene di approvvigionamento globali.
Quanto impariamo dalle crisi?
Le grandi crisi che investono sistemi sociali complessi – dalle catastrofi industriali alle crisi finanziarie – mettono alla prova la capacità di apprendimento collettivo. Dopo un evento critico, le organizzazioni spesso istituiscono procedure per memorizzare le lezioni apprese, ma col tempo subentra l’amnesia organizzativa: la tendenza a dimenticare gradualmente gli insegnamenti del passato. Questo fenomeno di organisational amnesia si manifesta quando l’istituzione non riesce a tradurre le conoscenze acquisite in adattamenti strutturali duraturi. Così, a distanza di anni, le stesse falle di sistema possono ripresentarsi, segno che il “vaccino” della memoria non ha attecchito.
Disinformazione, elezioni e intelligenza artificiale
L’intreccio tra disinformazione e intelligenza artificiale ed elezioni è diventato un fattore di cruciale importanza nel dibattito pubblico. I processi elettorali odierni si svolgono in un ecosistema mediatico permeato da strumenti di AI avanzati: da bot automatizzati sui social media, capaci di diffondere messaggi politici su vasta scala, a video e audio deepfake in grado di falsificare dichiarazioni di candidati con un realismo senza precedenti. Tali innovazioni tecnologiche amplificano sia la portata che la persuasività della disinformazione. Ad esempio, durante le elezioni presidenziali americani recenti, sono circolate immagini alterate e video contraffatti difficilmente distinguibili dal vero, mirati a influenzare l’opinione degli elettori. Come evidenziato da un articolo del Nature Human Behaviour co-firmato da ricercatori del Stanford Cyber Policy Center, gli strumenti di generative AI rendono facile creare falsi contenuti altamente realistici, “difficili da rilevare per gli esseri umani” e potenzialmente capaci di minare la fiducia del pubblico. Le tradizionali strategie di verifica delle notizie risultano messe a dura prova in questa nuova era dell’AI, dove il confine tra realtà e manipolazione artificiale si assottiglia.
I modelli di spiegazione nelle scienze computazionali
Nel campo delle scienze computazionali – e in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale e del machine learning – è emersa con forza la questione dei modelli di spiegazione, noti anche come explainable AI (XAI). Man mano che algoritmi e reti neurali sono divenuti più complessi e potenti, la loro opacità intrinseca è divenuta un problema: molti modelli funzionano come scatole nere, fornendo output (decisioni, previsioni) senza che ne sia immediatamente chiaro il perché. Questo contrasta con un’esigenza fondamentale delle scienze, computazionali incluse: la capacità di spiegare i risultati in modo interpretabile e verificabile. La mancanza di spiegabilità non è solo un tema accademico, ma ha risvolti pratici ed etici importanti, ad esempio quando un algoritmo determina se concedere un prestito, una diagnosi medica assistita o l’esito di un colloquio di lavoro automatizzato. Senza un modello di spiegazione chiaro, diventa difficile fidarsi e adottare pienamente tali sistemi. Una ricerca citata dal Pew Research Center evidenzia che una parte consistente di utenti esita ad affidarsi a prodotti basati su AI se non capisce le ragioni delle decisioni prese. Per questo negli ultimi anni si è moltiplicato lo sforzo di sviluppare tecniche e metriche che rendano gli algoritmi più trasparenti e interpretabili agli occhi umani.
"Putin’s World. Russia Against the West and with the Rest" di Angela Stent
Il volume di Angela Stent analizza il sistema di relazioni internazionali della Russia contemporanea a partire dalla visione del mondo promossa da Vladimir Putin. Il libro evidenzia come la politica estera russa sia volta a riaffermare la centralità del paese nel sistema internazionale, sfidando l'ordine liberale occidentale e rinegoziando i rapporti con le potenze emergenti. La tesi di fondo è che la Russia, pur economicamente debole rispetto all'Occidente, riesca a esercitare un'influenza geopolitica significativa grazie a una combinazione di assertività diplomatica, uso selettivo della forza e sfruttamento di conflitti regionali irrisolti. L’autrice descrive la logica strategica del Cremlino e le sue articolazioni operative nelle relazioni bilaterali e multilaterali, evidenziando il contrasto tra la retorica sovrana russa e l’interdipendenza globale che continua a vincolare Mosca. Il libro si sofferma su alcuni nodi chiave: le “guerre congelate” nello spazio post-sovietico, il rapporto con l’Europa e la NATO, la politica verso gli Stati Uniti, l’uso del soft power e le alleanze con paesi non occidentali. L’analisi si fonda su eventi storici, sviluppi politici recenti e una lettura coerente della visione russa dell’ordine mondiale.