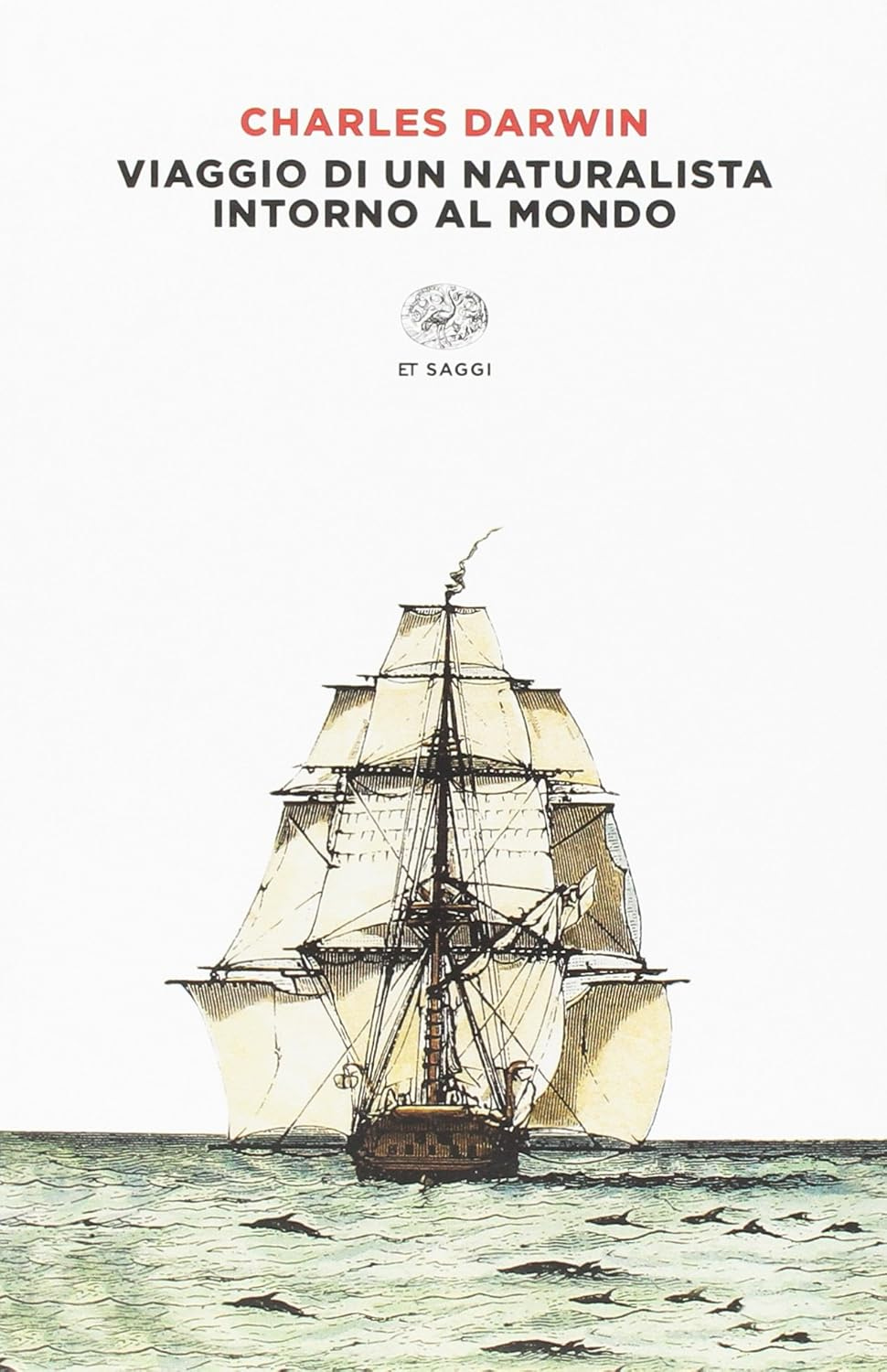Stroncature Digest #82
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce approfondimenti che hanno come metodo l’analisi delle conseguenze non intenzionali e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della Ricerca scientifica da loro condotta, contribuendo alla Terza Missione delle università (publica engagement, valorizzazione della ricerca, disseminazione, trasferimento tecnologico…). L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico, società e sistema produttivo. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e del clickbait. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
C'era una volta il caso: complessità, intelligenza artificiale e tecnologie abilitanti
Nel corso della storia intellettuale dell’umanità, vi sono momenti in cui strumenti materiali o concettuali non si limitano a potenziare le capacità operative, ma modificano in modo sostanziale le condizioni stesse della conoscenza. Si tratta di tecnologie abilitanti in senso epistemologico: innovazioni che ridefiniscono il rapporto tra soggetto e mondo, tra esperienza e comprensione, tra fenomeno e spiegazione. Si tratta di innovazioni non aprono soltanto nuovi campi applicativi, ma trasformano ciò che è pensabile, misurabile, rappresentabile. A partire dall’età moderna, la progressiva formalizzazione del sapere scientifico ha segnato una svolta decisiva in questa direzione, rendendo il mondo naturale non solo osservabile, ma modellabile secondo principi coerenti e riproducibili. L’accesso al reale non è più affidato alla percezione ordinaria o alla narrazione simbolica, ma a procedure sistematiche che rendono l’osservazione controllata e la spiegazione matematizzabile.
"Umano" di Edoardo Boncinelli
Stroncature ricorda Edoardo Boncinelli riproponendo la presentazione del suo libro "Umano"
All’indomani della scomparsa del professor Edoardo Boncinelli, Stroncature ripropone la presentazione del suo ultimo libro, Umano (Il Mulino, 2022), che si è tenuta il 25 luglio del 2022. All’evento, oltre all’autore, hanno preso parte Aldo Schiavone, Mauro Bordoni e Domenico De Masi, offrendo un dialogo ricco e articolato attorno ai nodi centrali della riflessione sull’essere umano. Al centro del dibattito, il rapporto tra natura e cultura, tra biologia e tecnica, tra identità individuale e condizione storica. Il libro se si vuole individuare un tratto distintivo del libro è che affronta la questione dell’umano in una prospettiva scientifica e insieme filosofica, cercando di sottrarla sia alle semplificazioni retoriche sia ai riduzionismi disciplinari.
Boncinelli propone una definizione dell’umano costruita per elementi, come se fosse il risultato di un assemblaggio di tratti distintivi. L’idea è che ciascun aspetto – linguaggio, cervello, socialità, coscienza – funzioni come uno degli “stecchetti” di un gioco combinatorio, e che solo la loro compresenza restituisca un’immagine complessiva dell’essere umano. Questo modello non mira a una sintesi astratta, ma a una descrizione che tenga conto della complessità e dell’equilibrio. Secondo Boncinelli, l’umano sta “nel mezzo”, in una posizione intermedia tra estremi biologici e culturali, tra rigidità naturalistica e indeterminatezza simbolica. Una posizione che richiede attenzione, misura, e soprattutto consapevolezza dei limiti e delle possibilità.
Uno dei punti centrali dell’intervento di Boncinelli è la critica alle narrazioni allarmistiche che, con crescente frequenza, parlano del rischio di “perdere l’umanità” sotto l’effetto della tecnica. L’autore respinge questa retorica come confusa e priva di fondamento. La tecnica, sostiene, non è un’aggiunta o un pericolo esterno, ma una manifestazione intrinseca dell’umano. La capacità tecnica è inscritta nella nostra evoluzione, così come il linguaggio e la capacità di fare progetti. Boncinelli sottolinea inoltre come l’insoddisfazione – la scontentezza – sia un tratto strutturale della nostra specie: non un difetto, ma un motore di trasformazione. È proprio questo senso di incompletezza che ci ha spinti, e continua a spingerci, a trasformare il mondo.
Al centro della riflessione c’è anche il tema del neotenismo, ovvero la lentezza dello sviluppo del cervello umano, che ci distingue da tutte le altre specie. Questa lentezza, se da un lato ci rende vulnerabili e dipendenti per un lungo periodo, dall’altro permette un processo di apprendimento più profondo e strutturale. Boncinelli osserva che le informazioni acquisite nei primi anni di vita non si sovrappongono semplicemente a un programma già definito, ma partecipano direttamente alla formazione dell’architettura cerebrale. Questo processo, che rende ogni individuo un prodotto irripetibile di storia biologica e culturale, è il fondamento della nostra flessibilità cognitiva e della nostra capacità di progettare, creare, comunicare.
Un altro nodo fondamentale è quello del linguaggio, che Boncinelli considera la vera soglia evolutiva. Il linguaggio umano non serve solo a nominare ciò che è presente, ma consente di riferirsi all’assenza, all’astrazione, all’irreale. Questa capacità di astrazione e comunicazione simbolica ha reso possibile la costruzione di culture, religioni, scienze e istituzioni. A essa si lega la coscienza, che l’autore descrive come la facoltà del cervello di essere consapevole di qualcosa e di articolare il pensiero in forma riflessiva. Ne consegue la formazione dell’identità e la pratica dell’autoconversazione, quella “voce interna” che ci accompagna costantemente e che definisce gran parte della nostra vita mentale quotidiana.
Boncinelli insiste anche sul ruolo dell’educazione, che definisce “la nostra unica vera arma”. Tuttavia, avverte che non basta: prima dell’educazione bisogna affrontare la questione dell’ignoranza, intesa non come semplice assenza di informazione, ma come chiusura strutturale alla conoscenza. In un’epoca in cui l’accesso ai contenuti è vasto e immediato, l’ignoranza si manifesta in forme nuove, più sottili, spesso legate all’adesione a sistemi di credenze infondate. Per questo, l’autore ritiene che combattere l’ignoranza sia oggi una priorità culturale e civile. L’educazione, senza una vera disponibilità ad apprendere, rischia di trasformarsi in un esercizio sterile, incapace di incidere realmente sulla coscienza collettiva.
Pur dichiarando un certo disagio a trattare i temi politici, Boncinelli non elude il nodo del rapporto tra scienza, tecnica e società. Egli mette in guardia contro l’illusione di una tecnica onnipotente o neutrale. Al contrario, sostiene che sia necessario contestualizzarla sempre, comprenderne la genealogia, la funzione, i limiti. La tecnica, afferma, è spesso investita di significati e poteri che non le appartengono. È uno strumento potente, ma non risolutivo. Va governata, non mitizzata. In questo senso, invita a superare le astrazioni e a ragionare in termini concreti, con consapevolezza storica e responsabilità etica, anche nei confronti delle trasformazioni che l’innovazione tecnologica impone.
Durante il dialogo con Schiavone, Bordoni e De Masi, è emersa con forza la centralità della riflessione sul rapporto tra tecnica e capitale, tra progresso tecnologico e forma sociale. Boncinelli riconosce il ruolo della tecnica nell’evoluzione dell’umano, ma resta prudente nel valutarne gli effetti sul piano politico. I relatori hanno posto domande importanti: può la tecnica contribuire all’emancipazione o rischia di accentuare le disuguaglianze? È possibile governare l’evoluzione tecnica senza alterare l’eguaglianza biologica della specie? Sono interrogativi aperti, che Boncinelli affronta con cautela ma anche con lucidità, rifiutando ogni determinismo e sottolineando la necessità di un controllo razionale e collettivo.
Stroncature invita ora a riascoltare quell’incontro per riflettere sulla lezione di Boncinelli, dove l’umano è realtà storica e plastica, attraversata da tensioni, ma dotata di strumenti per affrontarle. È un invito alla misura, alla consapevolezza, alla responsabilità. È anche, implicitamente, una difesa dell’umano contro tutte le forme di semplificazione, di allarmismo, di rinuncia.
"Viaggio di un naturalista intorno al mondo" di Charles Darwin
Viaggio di un naturalista intorno al mondo, scritto da Charles Darwin e pubblicato in versione riveduta nel 1845, rappresenta una delle testimonianze più significative della scienza moderna nella sua fase di formazione. Basato sulle osservazioni raccolte durante la spedizione del Beagle tra il 1831 e il 1836, il testo si presenta come un diario di viaggio in cui si intrecciano descrizioni naturalistiche, geologiche, zoologiche e antropologiche. La struttura non è sistematica né finalizzata a enunciare una teoria, ma documenta un processo continuo di osservazione e confronto empirico. Darwin non esplicita direttamente la teoria dell’evoluzione, ma lascia emergere ipotesi che progressivamente minano il concetto di fissità delle specie. Il libro documenta la transizione tra un pensiero ancora dominato da un ordine metafisico immutabile e un approccio scientifico fondato su prove raccolte sul campo. È anche un’opera narrativa che riflette il genere letterario del racconto di viaggio scientifico, ereditato dall’Illuminismo e fortemente influenzato da Alexander von Humboldt.