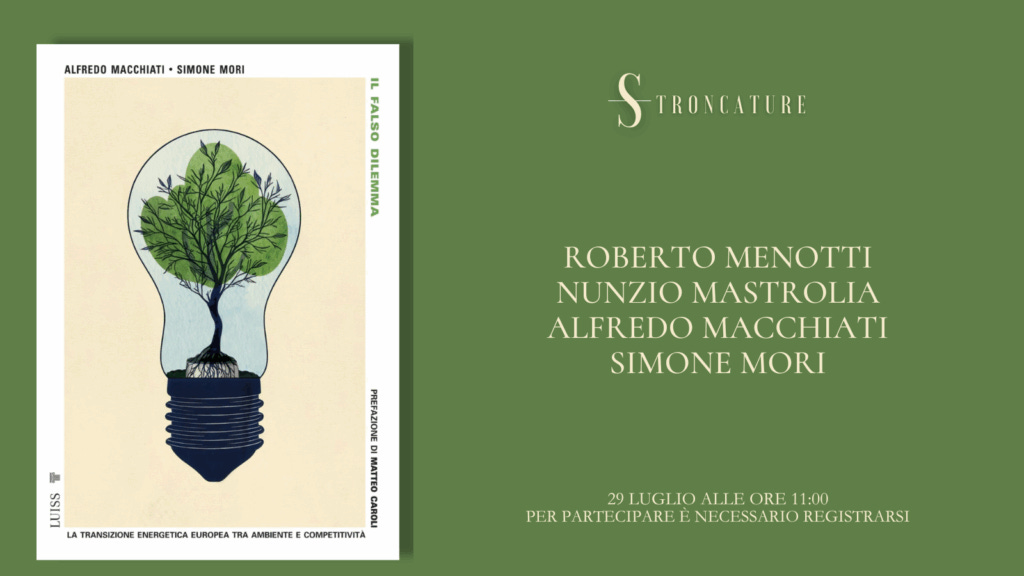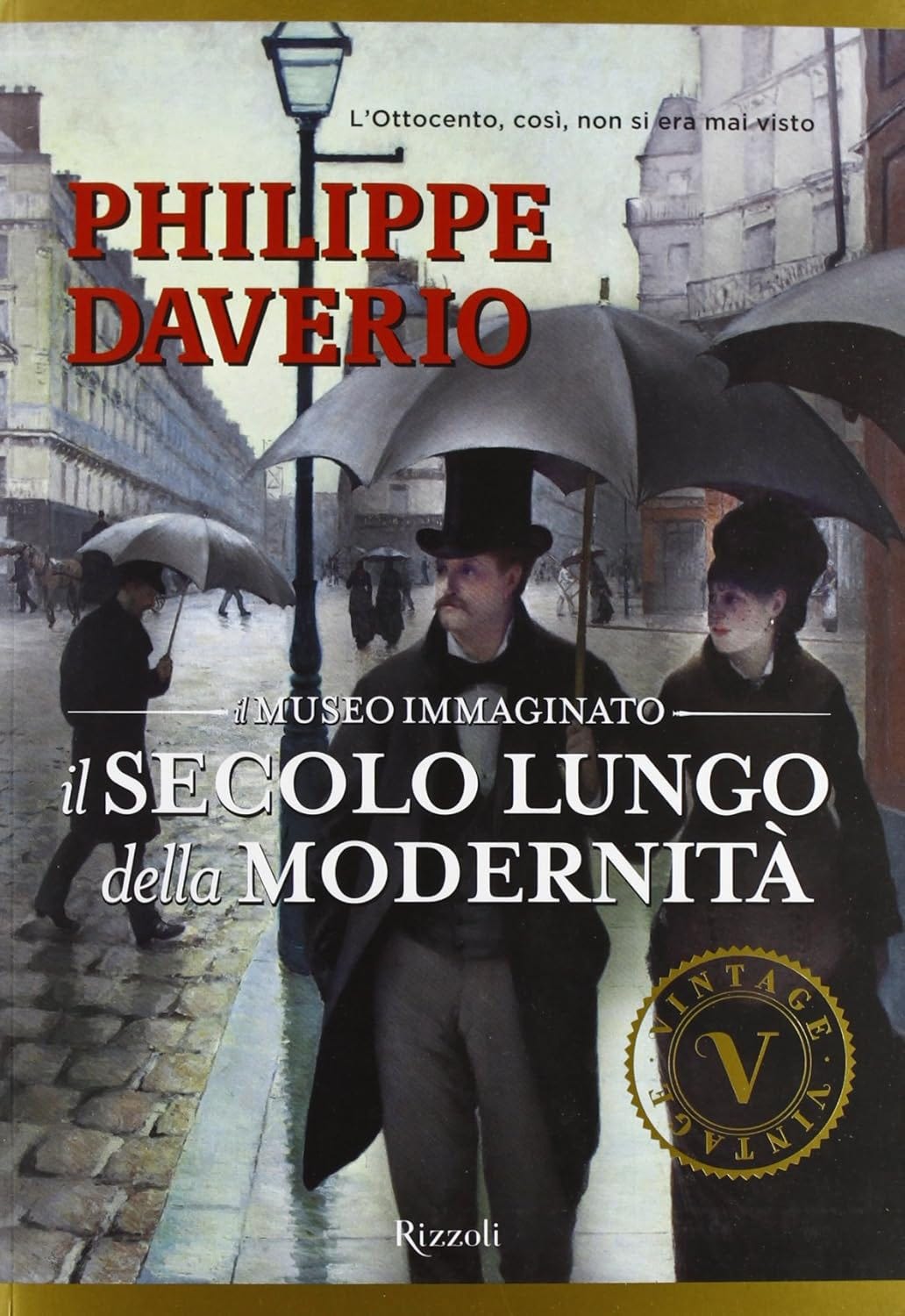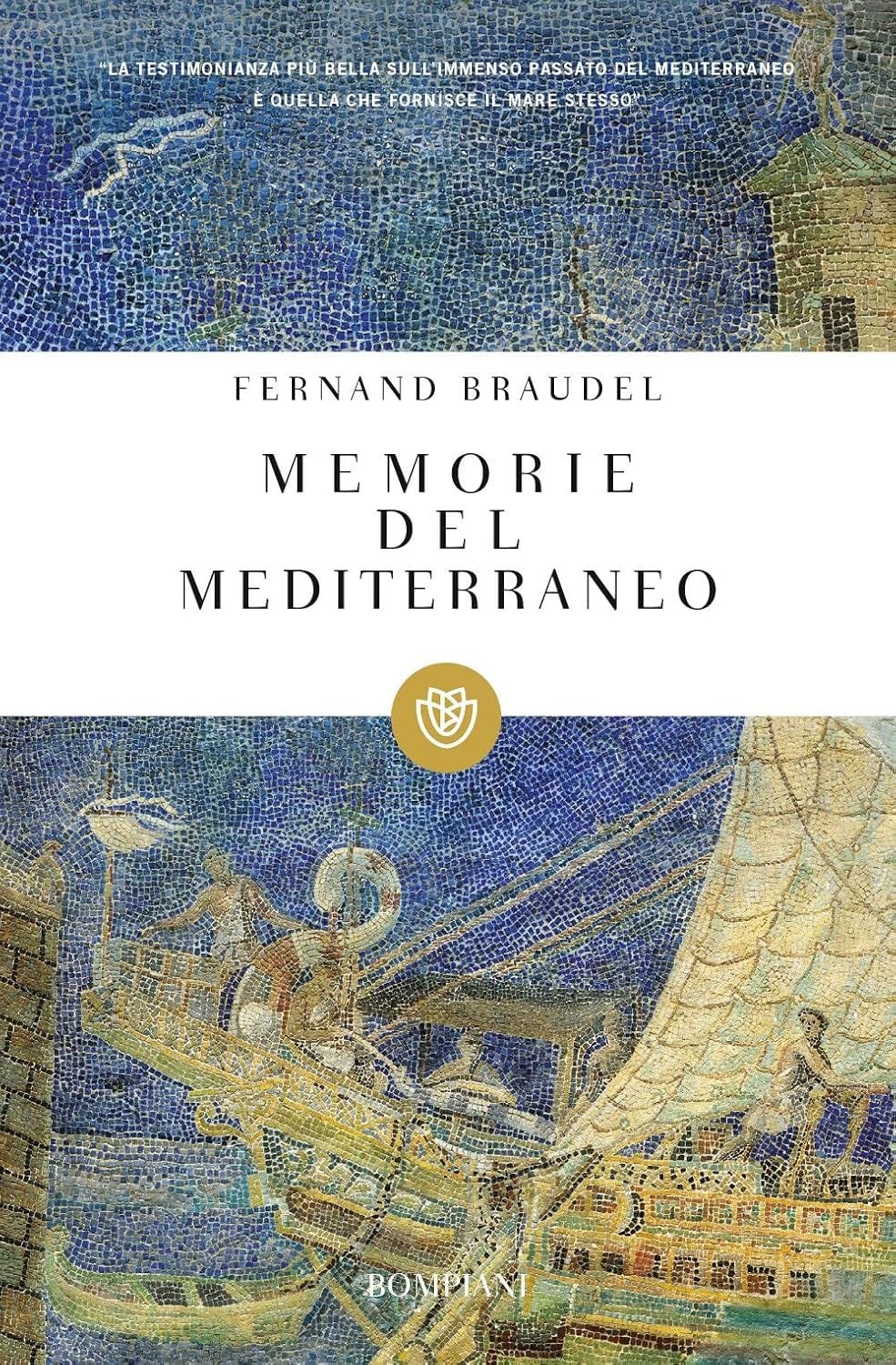Stroncature Digest #83
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce approfondimenti che hanno come metodo l’analisi delle conseguenze non intenzionali e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della Ricerca scientifica da loro condotta, contribuendo alla Terza Missione delle università (publica engagement, valorizzazione della ricerca, disseminazione, trasferimento tecnologico…). L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico, società e sistema produttivo. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e del clickbait. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
L’intelligenza artificiale e la crisi del web aperto
Nel giro di pochi anni, la centralità dell’intelligenza artificiale nella fruizione dell’informazione online ha modificato radicalmente i meccanismi di accesso alla conoscenza. Sempre più utenti scelgono di affidarsi a chatbot e assistenti virtuali invece di navigare direttamente sui siti web. Questo spostamento dell’attenzione, apparentemente efficiente e conveniente per l’utente finale, sta generando una distorsione profonda nel sistema di incentivi che ha sostenuto per decenni l’economia dell’informazione su internet. Il web, inteso come spazio aperto alimentato da contenuti pubblici e accessibili, si reggeva su una logica di scambio: gli utenti ricevevano contenuti gratuiti in cambio della loro attenzione, monetizzata attraverso la pubblicità. Oggi, però, il traffico umano si sta riducendo drasticamente, sostituito da interazioni mediate da LLM, con conseguenze strutturali sull’intero ecosistema. Secondo The Economist (17 luglio 2025), il rischio non è solo economico ma sistemico: senza un nuovo modello di remunerazione, l’intero meccanismo che sostiene la produzione di contenuti è destinato a crollare.
Rassegna della stampa tedesca #133
Quello che segue è il Monitoraggio della stampa tedesca, curato dalla redazione di Stroncature, su commissione della Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano. Il monitoraggio ha cadenza settimanale ed è incentrato sui principali temi del dibattito politico, economico e sociale in Germania. Gli articoli sono classificati per temi.
Stroncature produce diversi monitoraggi con taglio tematico o geografico personalizzabili sulla base delle esigenza del committente.
"Il falso dilemma. La transizione energetica europea tra ambiente e competitività" di Alfredo Macchiati e Simone Mori
Il prossimo 29 luglio alle 11:00, Stroncature ospiterà la presentazione del libro "Il falso dilemma. La transizione energetica europea tra ambiente e competitività" di Alfredo Macchiati e Simone Mori (Luiss University Press, 2025). Il libro affronta il dibattito, ormai ventennale, sulle politiche energetiche europee, mettendo in discussione il presunto conflitto tra tutela dell’ambiente e competitività economica. Gli autori mostrano come questo dilemma sia in realtà fuorviante: la transizione energetica non rappresenta una minaccia, ma un’opportunità trasformativa che sta già ridisegnando in profondità industria e società, ben oltre i confini dell’Unione Europea. L’Europa è chiamata ad affrontare questa sfida non solo per guidare il cambiamento, ma per non subirlo. Con gli autori dialogheranno: Roberto Menotti e Nunzio Mastrolia. Per partecipare è necessario registrarsi.
"Il secolo lungo della modernità" di Philippe Daverio
Il volume Il secolo lungo della modernità di Philippe Daverio è concepito come un viaggio narrativo attraverso l’arte visiva e le sue connessioni con la trasformazione culturale, sociale e politica dell’Europa moderna, a partire dalla Rivoluzione francese fino alla fine della Belle Époque. La tesi principale del libro è che il lungo Ottocento, nella definizione estesa da Hobsbawm, costituisce la matrice del mondo contemporaneo non solo per le innovazioni tecniche e scientifiche, ma anche per le mutazioni nei linguaggi dell’arte. Daverio costruisce un “museo immaginato” in cui le opere pittoriche non sono esibite in ordine cronologico, ma allestite secondo un criterio tematico e simbolico, utile a comprendere la densità del periodo. La pittura viene trattata come testimonianza diretta del tempo, capace di restituire sensazioni e significati non mediati dal filtro interpretativo. L'autore intreccia arte, urbanistica, storia politica e storia del gusto, dimostrando come la modernità si sia articolata in un sistema visivo e simbolico in continua tensione fra tradizione e sperimentazione. L’approccio è volutamente non accademico ma critico, con l’obiettivo di proporre una rilettura non convenzionale della modernità attraverso le sue manifestazioni artistiche.
"Memorie del Mediterraneo" di Fernand Braudel
In Memorie del Mediterraneo, Fernand Braudel ricostruisce con approccio storico-strutturale la genesi e l’evoluzione delle civiltà mediterranee dalle origini geologiche e preistoriche fino all’età antica. Il testo nasce da un progetto editoriale incompiuto negli anni Sessanta e propone una riflessione estesa su lunga durata, territorio e civilizzazione. L’autore colloca il Mediterraneo come uno spazio frammentato ma centrale nella storia umana, segnato da conflitti, scambi, migrazioni e permanenze ambientali. A differenza delle sue opere più celebri incentrate sull’età moderna, Braudel sceglie qui di esplorare le radici profonde della storia attraverso la lente della geografia, dell’archeologia e dell’antropologia. Il Mediterraneo emerge come luogo di oscillazioni lente, dove la natura impone vincoli che le società umane progressivamente imparano a negoziare. L’approccio evita semplificazioni evolutive e privilegia l’analisi di strutture profonde, fenomeni collettivi e trasformazioni di lunga durata che preparano l’avvento delle prime forme statuali, urbane e scritte.
"Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto" di Peter Brown
Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto di Peter Brown analizza il periodo compreso tra il 150 e il 750 d.C., proponendo una rilettura della fine del mondo classico non come decadenza, ma come trasformazione culturale, politica e religiosa. L’autore individua in questo arco temporale il passaggio da una civiltà imperiale a un sistema di società pluralistiche, fondate su nuove concezioni del potere, della religione e dell’identità. La tesi centrale è che il mondo tardo antico abbia dato origine a realtà nuove, tra cui il cristianesimo trionfante in Europa e l’emergere dell’Islam nel Medio Oriente. Brown rifiuta la narrazione lineare della caduta dell’impero per evidenziare invece un processo articolato di riformulazione sociale e culturale, reso possibile da fenomeni come la diffusione del monachesimo, la trasformazione dell’autorità imperiale, l’evoluzione dell’educazione e l’irruzione di nuovi soggetti politici e religiosi. Il libro si struttura attorno a una doppia rivoluzione, sociale e religiosa, il cui intreccio definisce la natura del mondo tardo antico come fase di transizione verso il Medioevo.