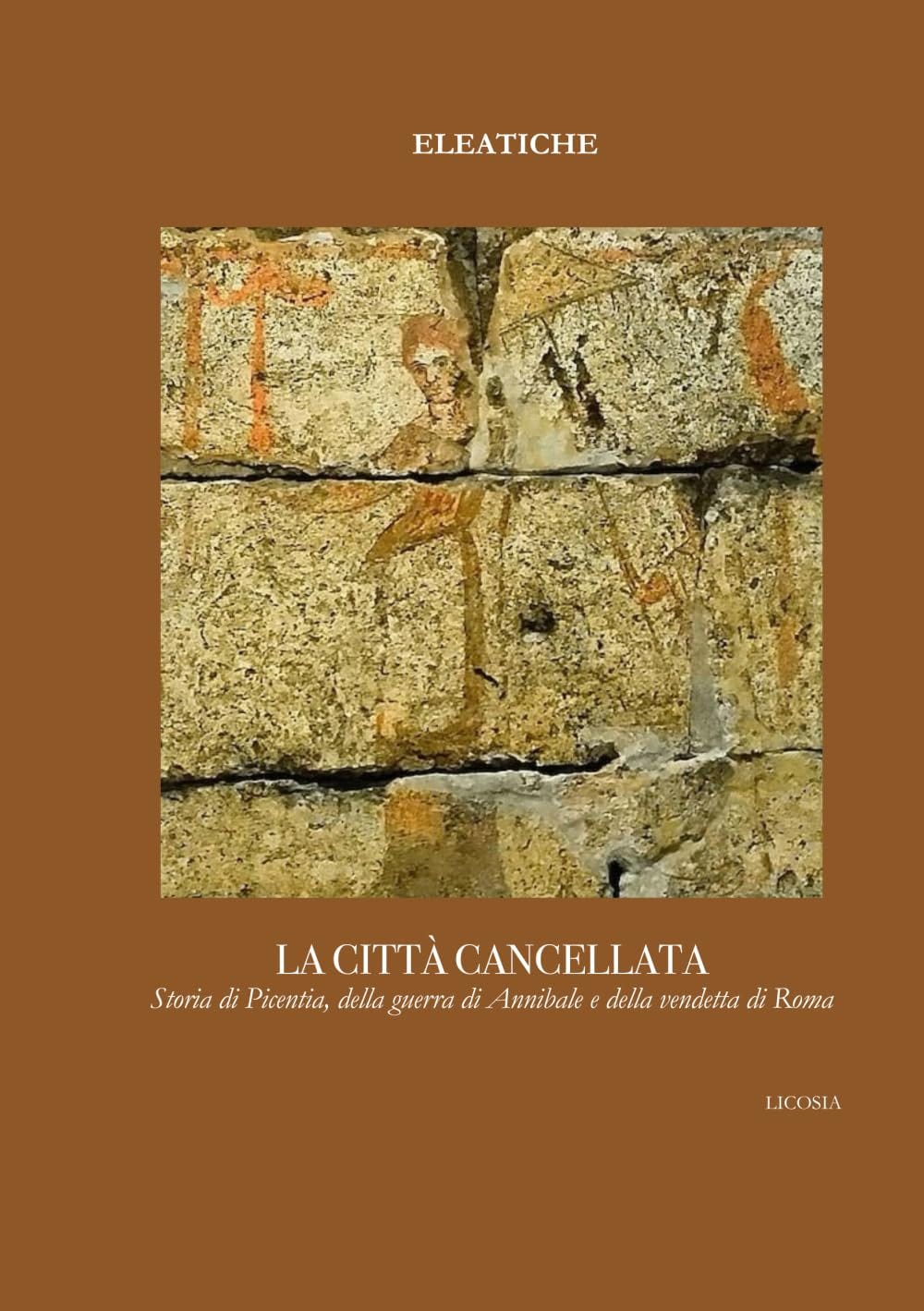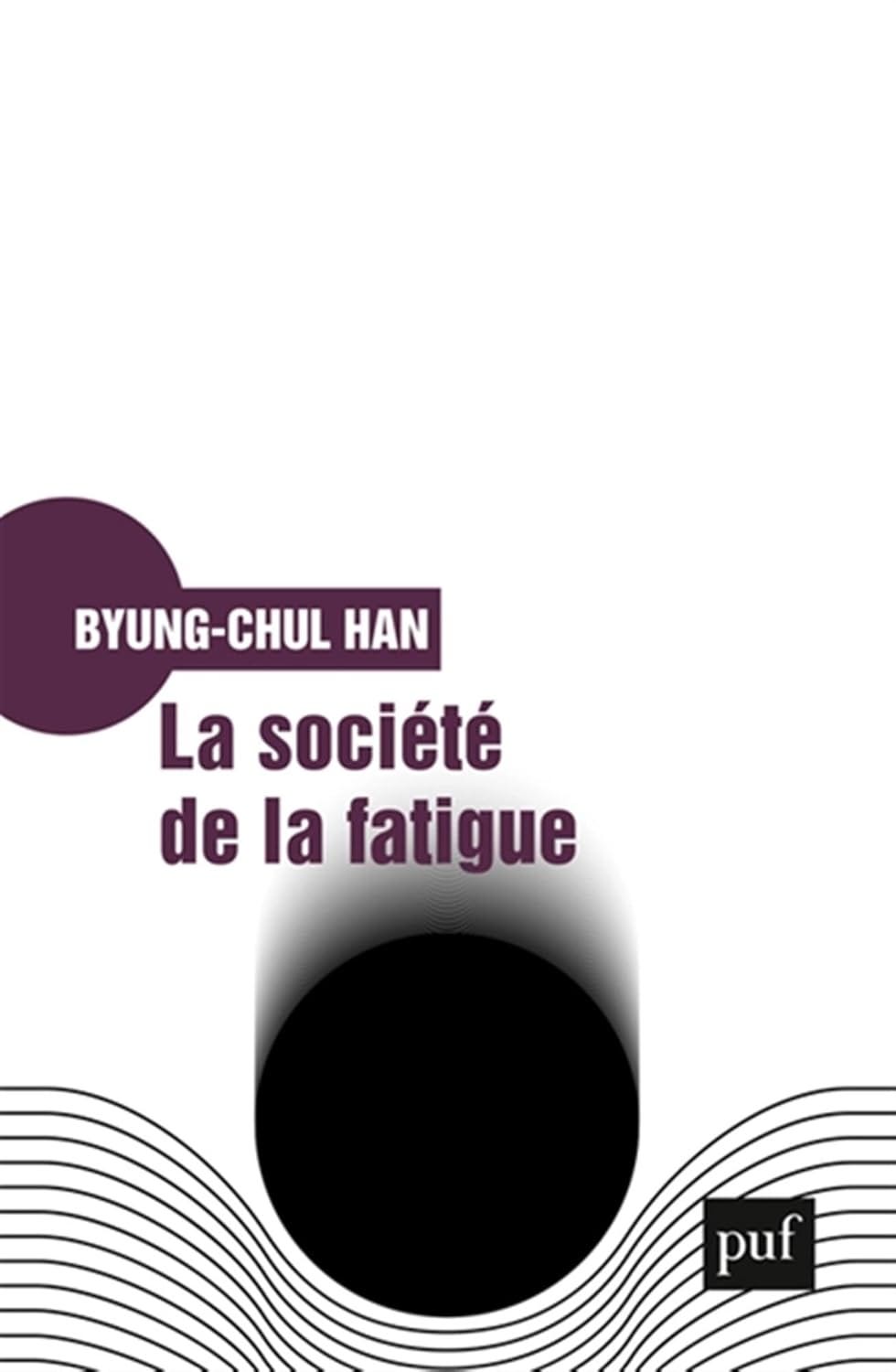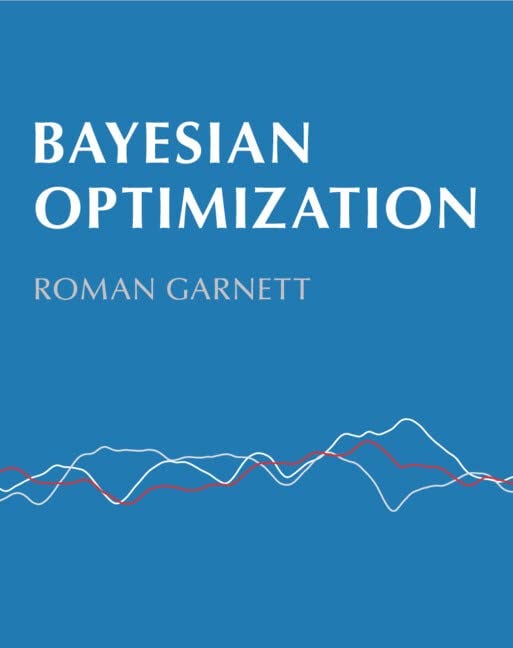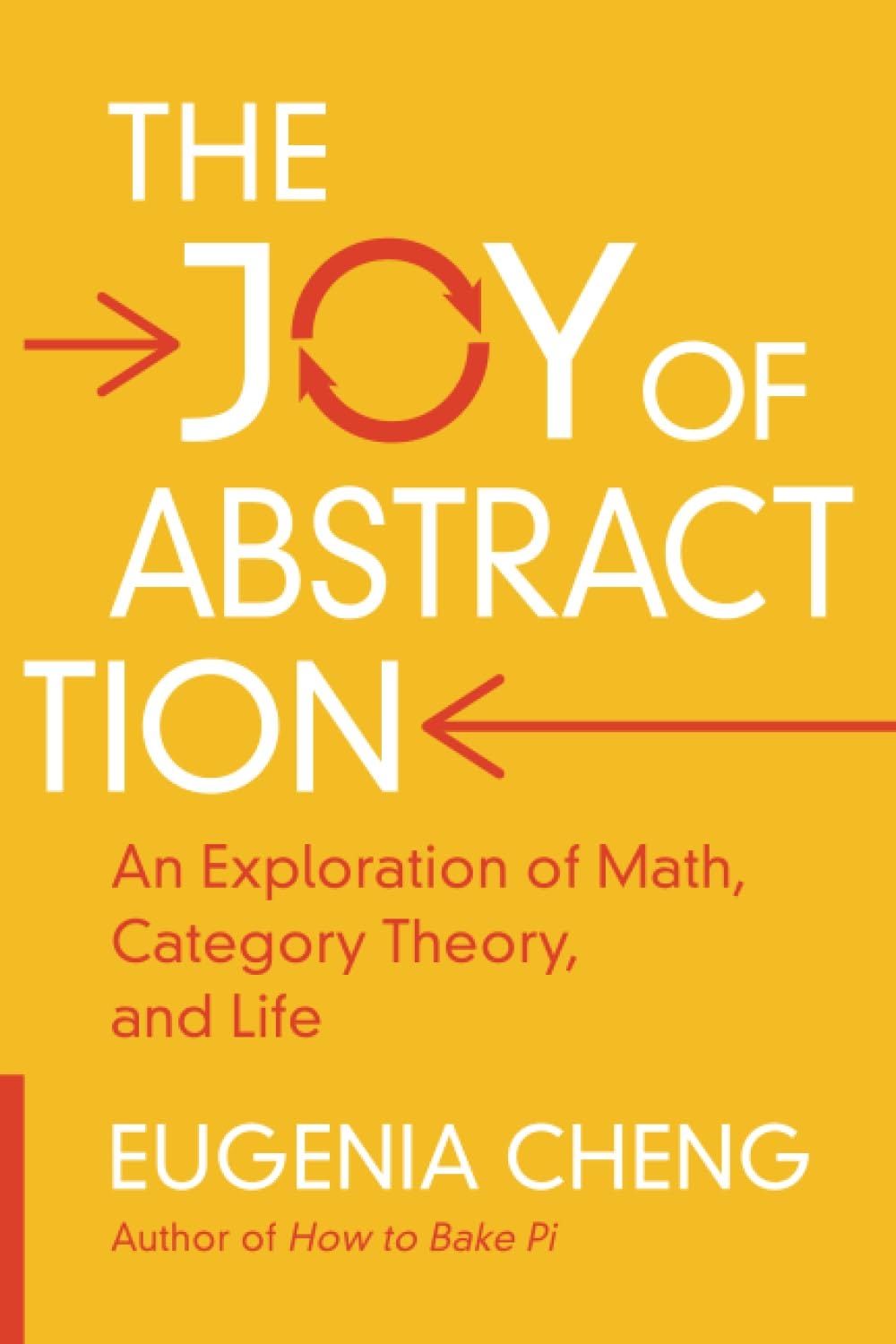Stroncature Digest #99
Stroncature è la piattaforma per la Terza missione, per la disseminazione scientifica e culturale e il trasferimento tecnologico. In collaborazione con Università ed Enti di ricerca pubblici produce contenuti e formati (video, podcast, testi divulgativi, infografiche) che servono alla diffusione, valorizzazione e trasferimento dei frutti della ricerca pubblica, nella convinzione che l’Università e la Ricerca, in una economia della conoscenza, siano il vero motore di progresso sociale e sviluppo economico. C’è di più: c’è la convinzione che raccontare le storie della Ricerca, le sfide a cui ricercatori e ricercatrici, studiose e studiosi dedicano la loro esistenza sia il modo migliore per suscitare l’entusiasmo delle giovani menti, per accettare la sfida a risolvere problemi sempre più complessi e difficili, spostando così un po’ più in là il confine che separa il noto e a ridurre il campo dell’ignoto.
Analisi & Ricerche
Il problema della causalità nei fenomeni complessi e l’idea di leggi sociali
È possibile parlare di causalità nelle scienze sociali allo stesso modo in cui se ne parla nelle scienze naturali? E fino a che punto ha senso cercare “leggi sociali” capaci di spiegare in maniera generale il comportamento umano e collettivo? Queste domande toccano uno dei punti più delicati dell’epistemologia delle scienze sociali. Se in fisica o in chimica la causalità è concepita come relazione regolare tra eventi, nelle scienze sociali essa incontra l’ostacolo della complessità: i fenomeni sociali non sono mai il risultato di un’unica causa, ma di una pluralità di fattori che interagiscono in contesti mutevoli. La ricerca di leggi universali rischia così di ridursi a un’astrazione che non coglie la specificità storica e culturale dei processi. La sfida diventa quindi quella di ripensare il concetto di causalità alla luce della natura intrinsecamente complessa e contingente della realtà sociale.
Seminari e Presentazioni
“Genomica sociale. Come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA” di Carlo Alberto Redi e Manuela Monti
Lo scorso 17 settembre, Stroncature ha ospitato la presentazione del libro “Genomica sociale. Come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA” di Carlo Alberto Redi e Manuela Monti (Carocci editore, 2025). Il volume affronta l’impatto profondo che l’ambiente – inteso in senso fisico, sociale, culturale e psicologico – esercita sull’espressione genetica e sul funzionamento del nostro organismo. Le condizioni in cui viviamo possono infatti modificare il modo in cui il DNA si attiva, influenzando la salute, ma anche contribuendo a diseguaglianze economiche e sociali che si trasmettono di generazione in generazione. In questa nuova edizione rivista e aggiornata, gli autori sottolineano quanto sia cruciale adottare stili di vita responsabili e riconoscere il legame inscindibile tra salute individuale e benessere ambientale. Con gli autori dialogano la prof.ssa Emanuela Mancino, dell’Università di Milano-Bicocca, docente di Filosofia dell’educazione, e il prof. Guido Bosticco, Università degli Studi di Pavia, docente di Scrittura creative e Professioni dell’editoria.
Licosia
La città cancellata: Storia di Picentia, della guerra di Annibale e della vendetta di Roma
Il volume ricostruisce la vicenda storica della città di Picentia, dalla sua fondazione all’annientamento da parte di Roma all’indomani della seconda guerra punica. Situata tra Salerno e Pontecagnano, Picentia rappresenta un caso paradigmatico di damnatio memoriae: una città cancellata per aver parteggiato con Annibale, i cui abitanti furono dispersi e la cui identità fu rimossa dalla tradizione. Attraverso l’analisi incrociata delle fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche, il libro restituisce voce a una comunità cancellata dalla storia, indagando al contempo le strategie politiche e simboliche messe in atto dalla Repubblica romana per consolidare il proprio dominio. Una riflessione sulla forza della deterrenza, sul potere della memoria e sulle forme della sua manipolazione nella costruzione del passato.
Punti cardinali
“La société de la fatigue” di Byung-Chul Han (PUF, 2024)
Il libro La société de la fatigue di Byung-Chul Han, pubblicato in origine in tedesco nel 2010 con il titolo Müdigkeitsgesellschaft e tradotto in francese dalle Presses Universitaires de France nel 2024, è un saggio filosofico breve ma denso che affronta una delle questioni centrali della modernità: il rapporto tra società, soggettività e nuove forme di malattia psichica e sociale. Han, filosofo sudcoreano formatosi in Germania e docente a Berlino, propone una diagnosi della contemporaneità attraverso la categoria della fatica, intesa non solo come fenomeno fisiologico, ma soprattutto come condizione esistenziale e sociale che deriva da un eccesso di positività e di auto-sfruttamento. L’autore intende mostrare come il paradigma della modernità non sia più quello della società disciplinare descritta da Michel Foucault, fondata sul controllo, sulla proibizione e sulla negatività, ma quello di una società della prestazione, in cui gli individui non sono più soggetti-obbedienti, bensì soggetti-performanti, imprenditori di sé stessi, che interiorizzano l’imperativo alla produttività senza più bisogno di un’autorità esterna. La tesi principale è che questo nuovo regime, apparentemente liberatorio, produce nuove forme di patologie neuronali – depressione, burnout, disturbi dell’attenzione – che non nascono da una repressione esterna, ma dall’eccesso di libertà intesa come obbligo a poter fare sempre di più. L’impostazione del libro è filosofica, con riferimenti costanti a pensatori come Foucault, Arendt, Nietzsche, Baudrillard e altri, ma anche con incursioni nella letteratura (Kafka, Melville) e nella teoria sociale contemporanea. L’obiettivo è delineare una diagnosi della condizione contemporanea che permetta di comprendere la natura delle nuove forme di sofferenza e di iperattività che caratterizzano l’uomo del XXI secolo.
“Bayesian Optimization” di Roma Garnett (Cambridge University Press, 2023)
La Bayesian Optimization è un metodo pensato per affrontare un problema molto pratico: come trovare il miglior risultato possibile in situazioni in cui fare esperimenti è costoso e complicato. Immaginiamo di voler sviluppare un nuovo farmaco. Ogni test in laboratorio richiede tempo, denaro e materiali preziosi, e non è realistico provare tutte le possibili combinazioni chimiche. Oppure pensiamo a un’azienda che costruisce turbine eoliche: per capire quale forma delle pale renda la produzione di energia più efficiente, non si possono realizzare centinaia di prototipi. In casi come questi entra in gioco la logica della Bayesian Optimization. L’idea è di non procedere alla cieca, ma di sfruttare un modello matematico che rappresenti le conoscenze già raccolte e che, invece di fornire una risposta unica, indichi per ogni ipotesi sia un valore stimato, sia il grado di incertezza. A partire da questo quadro probabilistico, si sceglie il prossimo esperimento in modo che porti il massimo di nuove informazioni o che abbia buone probabilità di migliorare i risultati. In questo modo si riduce il numero di prove necessarie, ottimizzando risorse e tempi.
“The Joy of Abstraction. An Exploration of Math, Category Theory, and Life” di Eugenia Cheng (Cambridge University Press, 2022)
The Joy of Abstraction. An Exploration of Math, Category Theory, and Life, pubblicato da Cambridge University Press nel 2022, è un’opera che intende aprire le porte della teoria delle categorie a un pubblico ampio, non necessariamente formato da matematici professionisti. L’autrice, Eugenia Cheng, matematica di fama internazionale e divulgatrice apprezzata, si propone di mostrare come l’astrazione non debba essere vista come un ostacolo, bensì come una forma di pensiero che permette di cogliere strutture e connessioni invisibili a un’analisi superficiale. Il libro ha una struttura peculiare: alterna la spiegazione di concetti formali a digressioni di carattere personale, filosofico e sociale, con l’intento di dimostrare che l’astrazione non appartiene solo alle aule universitarie, ma attraversa la vita quotidiana, i rapporti sociali, le scelte personali. L’obiettivo non è formare specialisti, ma fornire un linguaggio nuovo per pensare, un modo di guardare ai problemi che privilegi le relazioni e le connessioni rispetto agli elementi isolati. Cheng si muove quindi in una tradizione di divulgazione che non sacrifica la precisione, ma la coniuga con la chiarezza e la leggibilità.