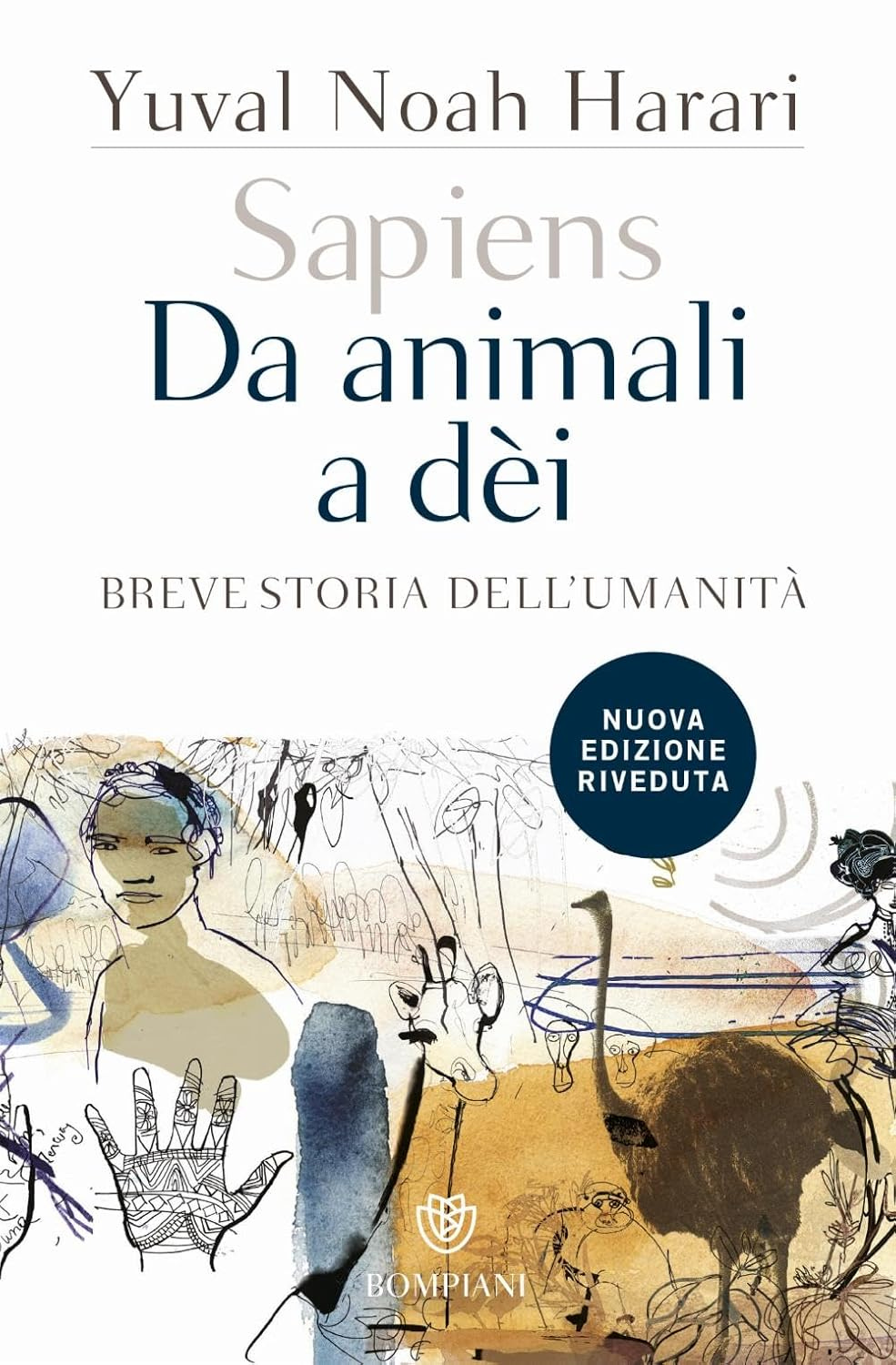Stroncature Digest #46
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce analisi basate sulla complessità e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della ricerca, contribuendo alla terza missione delle università. L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico e società. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e dell’engagement. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
Analisi & Ricerche
Oligopoli tecnologici e concentrazione del potere: effetti sulle economie liberali
Negli ultimi due decenni si è assistito all’ascesa di oligopoli tecnologici: un numero ristretto di aziende – in primis le Big Tech americane (Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) ma anche equivalenti cinesi (BATX: Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) – ha conquistato posizioni dominanti in settori chiave dell’economia digitale. Dati di mercato mostrano che in vari comparti la quota dei primi 4 attori (CR4) è cresciuta drasticamente, segnalando mercati sempre meno concorrenziali. Ad esempio, Apple genera quasi il 75% dei ricavi nel mercato degli smartphone premium, Google detiene ~90% delle ricerche web, Facebook controlla i maggiori social network. Queste concentrazioni sfidano i principi dell’economia liberale basata sulla libera concorrenza e sull’accesso paritario al mercato.
Intelligenza sistemica
Modelli, simulazioni e sistemi complessi: che cosa ci dicono davvero
Nell’analisi dei sistemi complessi, i modelli matematici e le simulazioni informatiche rappresentano strumenti largamente impiegati per esplorare dinamiche difficilmente osservabili in modo diretto. La loro diffusione è dovuta alla capacità di rappresentare scenari ipotetici, testare ipotesi e visualizzare effetti sistemici generati da molteplici interazioni. Tuttavia, proprio per la loro crescente centralità, è necessario interrogarsi in modo rigoroso su che cosa questi strumenti siano effettivamente in grado di dire sui fenomeni analizzati. Un modello, per definizione, è una costruzione semplificata della realtà: seleziona alcune variabili e relazioni, ne esclude altre, e restituisce un’immagine parziale e ipotetica del sistema. Questo significa che l’affidabilità delle sue conclusioni dipende interamente dalla qualità delle assunzioni iniziali e dalla coerenza della struttura logica adottata. Quando i modelli sono fraintesi o assunti come rappresentazioni fedeli del reale, possono generare un’eccessiva fiducia predittiva, favorire l’adozione di strategie inadeguate o rinforzare visioni distorte del problema. Comprendere i limiti interpretativi dei modelli è quindi condizione necessaria per un loro uso responsabile. Più che offrire certezze, i modelli forniscono scenari condizionati, validi entro i confini delle ipotesi che li generano. L’analisi critica di ciò che includono e di ciò che tralasciano è parte integrante della valutazione della loro utilità.
Recensioni & Presentazioni
"L'urlo disumano. Il passaggio del testimone nelle aziende famigliari" di Alberto Albertini
Lo scorso 5 maggio, Stroncature ha ospitato la presentazione del libro "L'urlo disumano. Il passaggio del testimone nelle aziende famigliari" di Alberto Albertini (Rubbettino, 2024).
Punti cardinali
"Silla" di Giovanni Brizzi
Nel volume Silla, Giovanni Brizzi ricostruisce la figura di Lucio Cornelio Silla in modo analitico e rigoroso, offrendo una lettura distante dalle semplificazioni. Silla fu generale, uomo politico e riformatore istituzionale, protagonista di una fase di grave crisi nella tarda Repubblica romana. La sua carriera, segnata dalla vittoria nella guerra contro Giugurta, dalla repressione della guerra sociale, dal conflitto civile con Mario e dalla guerra contro Mitridate, si concluse con l’assunzione di una dittatura costituente. In questa veste, egli avviò un programma di restaurazione oligarchica fondato sulla limitazione dei poteri tribunizi e sull’allargamento del senato. La narrazione insiste sull’ambivalenza della figura sillana, presentandolo al tempo stesso come violento difensore dell’ordine e come uomo coerente nella sua volontà di riforma. Dopo aver esercitato un potere assoluto, Silla rinunciò spontaneamente alla dittatura e si ritirò dalla vita pubblica. Brizzi valuta con attenzione il peso delle fonti, evidenziando la parzialità della tradizione ostile legata al cesarismo. L’immagine risultante è quella di un uomo dotato di capacità straordinarie e di un progetto di restaurazione istituzionale organico, non sempre compreso dai contemporanei.
"Storia marittima del mondo" di David Abulafia
Nel libro Storia marittima del mondo, David Abulafia propone una ricostruzione della storia umana fondata sul ruolo centrale degli oceani, intesi non come sfondo passivo ma come infrastruttura attiva e continua di scambi, migrazioni, contatti e conflitti. La tesi principale è che i mari abbiano giocato un ruolo superiore rispetto alle vie terrestri nello sviluppo delle civiltà, nella diffusione di merci, idee, religioni e poteri politici. L’autore esamina un arco temporale di quattro millenni e si concentra su rotte, commerci e popolazioni che operarono lungo le coste e attraverso gli oceani. L’approccio è centrato sull’interconnessione tra regioni distanti, senza separare nettamente i tre grandi oceani, ma mostrando come essi abbiano formato un’unica entità dinamica e in evoluzione. I protagonisti principali sono i mercanti, gli esploratori e le società costiere, piuttosto che gli Stati centrali o gli imperi terrestri. Lo stile è quello della storia globale, ma con una marcata attenzione alle fonti locali, ai contesti specifici e alla materialità della navigazione. L’opera presenta quindi una visione marittima della globalizzazione, attenta alle discontinuità e alle forme di contatto nel lungo periodo. Il mare diventa così una chiave interpretativa essenziale per leggere la storia.
"Sapiens. Da animali a dèi" di Yuval Noah Harari
In Sapiens. Da animali a dèi, Yuval Noah Harari propone una sintesi storica dell’evoluzione dell’Homo sapiens dalle sue origini preistoriche fino all’età contemporanea, articolando il percorso umano attraverso tre grandi trasformazioni: la rivoluzione cognitiva, la rivoluzione agricola e la rivoluzione scientifica. Il testo analizza il modo in cui l’Homo sapiens è passato da uno tra i tanti mammiferi marginali a dominatore del pianeta, grazie alla capacità di creare finzioni collettive che hanno permesso cooperazione su vasta scala. Harari ricostruisce il processo attraverso cui le credenze, le strutture sociali e i sistemi politici ed economici si sono evoluti come prodotti della cultura piuttosto che della biologia. L’attenzione si concentra su come miti condivisi e sistemi simbolici – religioni, nazioni, denaro, diritto – abbiano sostenuto l’organizzazione umana e favorito la creazione di strutture complesse. La riflessione finale si rivolge al futuro, interrogandosi sui potenziali sviluppi della specie umana e sulla possibilità che l’Homo sapiens venga superato da nuove forme di intelligenza artificiale o progettazione biologica.