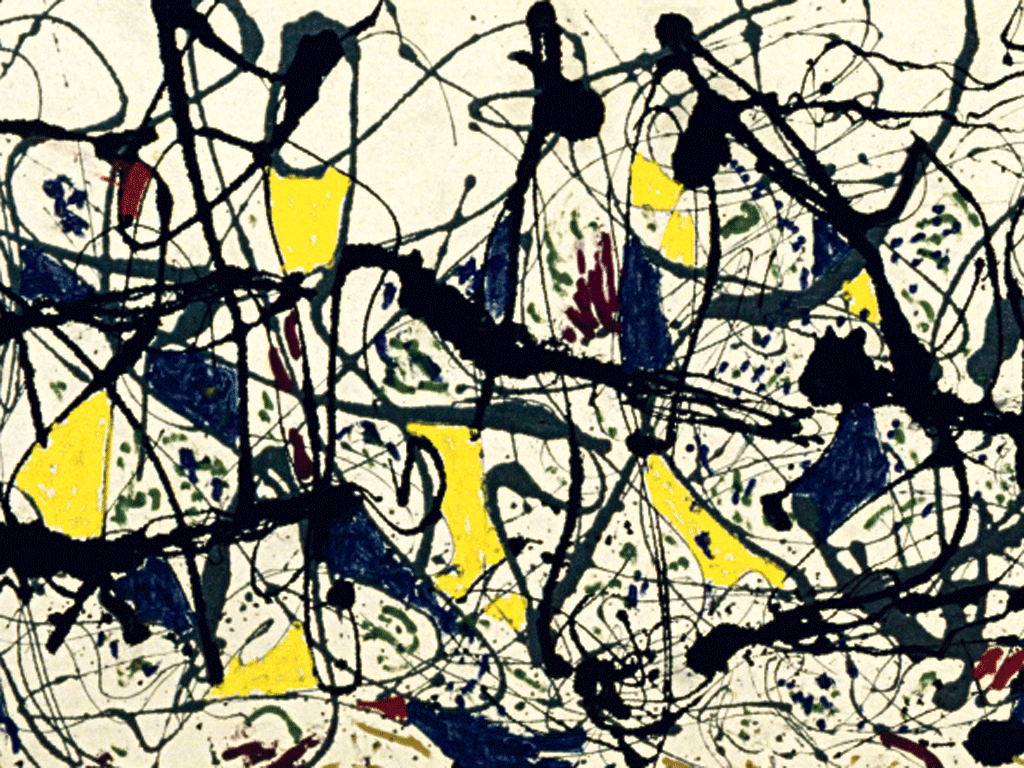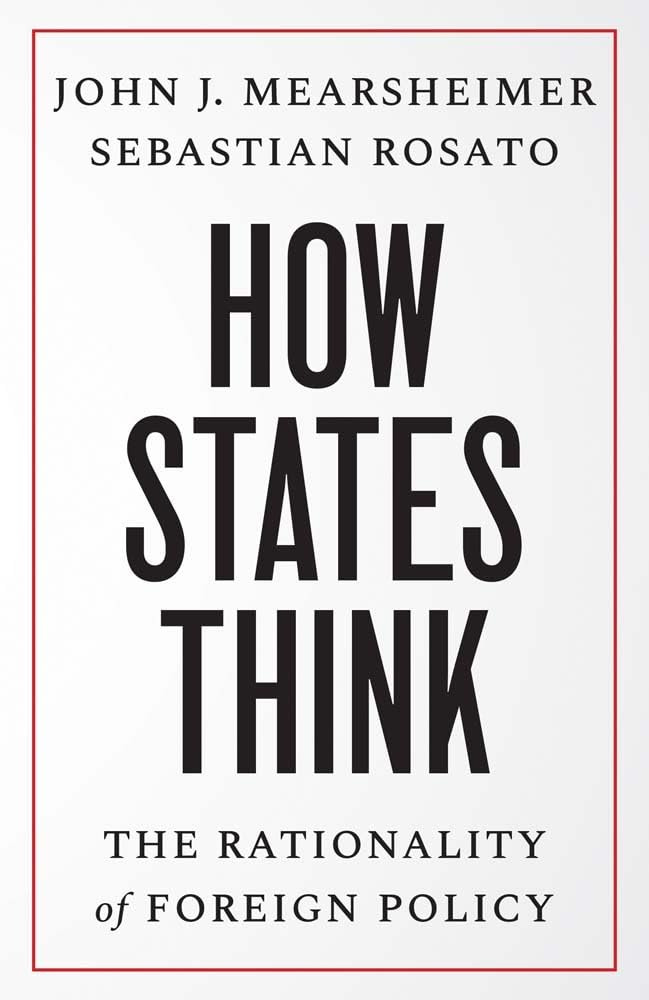Stroncature Digest #51
Complexity-as-a-service
Stroncature è una piattaforma editoriale che produce analisi strutturare per incomporare la complessità e promuove la diffusione della conoscenza scientifica prodotta dalle università. Nasce per offrire un’alternativa alla semplificazione che domina il discorso pubblico, proponendo contenuti pensati per ricostruire le connessioni, analizzare le interdipendenze e comprendere gli effetti non visibili dei fenomeni contemporanei. Ogni testo pubblicato è frutto di un lavoro redazionale che privilegia la lentezza, la profondità e il rigore metodologico. Accanto alla produzione di articoli, saggi e report, Stroncature collabora con il mondo accademico per valorizzare i risultati della Ricerca scientifica da loro condotta, contribuendo alla Terza Missione delle università (publica engagement, valorizzazione della ricerca, disseminazione, trasferimento tecnologico…). L’obiettivo è rendere accessibili concetti complessi senza rinunciare alla precisione analitica, facilitando l’incontro tra sapere scientifico, società e sistema produttivo. La piattaforma si rivolge a chi cerca strumenti di comprensione affidabili, capaci di superare le logiche dell’immediatezza e del clickbait. In un ecosistema informativo dominato dalla ripetizione e dalla superficialità e dalla peste dell’Infotainment, Stroncature propone un modello alternativo: contenuti lenti per pensare prima di reagire, analizzare prima di semplificare, comprendere prima di giudicare.
Tutti i contenuti prodotti da Stroncature a partire dal 2020 sono tutti consultatili sul sito
Analisi & Ricerche
"C'è un podcast per questo": la proliferazione dei canali audio e nuove forme di pubblicità
Negli ultimi due decenni il podcast è passato da formato di nicchia a fenomeno di massa, divenendo centrale nel modo in cui l’informazione e la conoscenza circolano tra il pubblico. Nato nel 2004 (quando il termine podcast fu coniato per descrivere questa nuova modalità di distribuzione audio), il medium ha visto una crescita esponenziale: oggi il 57% degli americani – circa 162 milioni di persone – ha ascoltato almeno un podcast, rispetto a solo l’11% di dieci anni fa. Quasi la metà della popolazione adulta degli Stati Uniti (circa 116 milioni) ascolta podcast ogni mese, a testimonianza di una penetrazione senza precedenti per un canale emerso appena all’inizio del XXI secolo. La facilità di accesso e la natura coinvolgente dell’audio hanno trasformato i podcast in uno strumento di “epistemologia popolare”: sempre più persone si informano, apprendono nuove conoscenze o formano opinioni attraverso questo medium, al di fuori dei tradizionali canali editoriali e accademici. Tale successo solleva però interrogativi critici sul piano epistemologico e culturale. I podcast stanno ridefinendo la produzione e il consumo di sapere, con implicazioni ambivalenti: da un lato democratizzano l’accesso all’informazione e ampliano il pluralismo delle voci; dall’altro presentano rischi concreti di disinformazione, tribalizzazione delle opinioni e disintermediazione dei controlli editoriali. Inoltre, la loro evoluzione in strumenti di branded content legati a sponsorizzazioni commerciali pone ulteriori quesiti sulla finalità e l’indipendenza di tali contenuti.
Rapporti di Ricerca
Il mosaico della sicurezza europea: accordi di cooperazione in ambito Difesa extra NATO
Negli ultimi anni, il panorama della sicurezza europea si è ristrutturato attraverso un processo di intensificazione delle cooperazioni bilaterali e multilaterali tra Stati membri dell’Unione, spesso sviluppate autonomamente rispetto al quadro istituzionale della NATO. Tale processo ha subito un’accelerazione a partire dal 2014, con la crisi ucraina e l’annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, ma trova radici più profonde in una lunga evoluzione storica della politica di sicurezza europea. Se da un lato l’alleanza atlantica ha costituito per decenni il principale pilastro della sicurezza collettiva occidentale, il progressivo affermarsi dell’idea di “autonomia strategica europea” ha portato numerosi Stati a rafforzare forme di cooperazione militare diretta, finalizzate ad accrescere la propria capacità di risposta autonoma in scenari di crisi, anche al di fuori delle dinamiche transatlantiche.
Punti cardinali
"China’s World View" di David Daokui
Nel volume China’s World View, David Daokui Li propone un’interpretazione dall’interno del sistema politico, economico e culturale della Cina, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il rischio di conflitti tra la Repubblica Popolare e l’Occidente. L’autore, economista accademico e consigliere di importanti istituzioni cinesi, intende offrire una visione non propagandistica ma informata e strutturata del funzionamento della Cina contemporanea, a partire dalla convinzione che gran parte delle tensioni internazionali derivino da un deficit di comprensione reciproca. Il libro si apre con il racconto di un dibattito pubblico a Toronto nel 2011, durante il quale Li fu chiamato a difendere la tesi secondo cui il XXI secolo apparterrà alla Cina, pur non essendo personalmente convinto di tale previsione. Tale episodio diventa lo spunto per una riflessione più ampia sul modo in cui l’Occidente percepisce la Cina, spesso attraverso la lente del sospetto e del confronto strategico, e sull’urgenza di una conoscenza più accurata del pensiero e delle dinamiche interne cinesi. La tesi centrale del libro è che la Cina non costituisce una minaccia strutturale all’ordine mondiale esistente e che il suo sviluppo può avere effetti positivi anche per gli altri paesi, se accompagnato da un adeguato sforzo di chiarimento e decodifica reciproca. L’autore non nega le difficoltà o le criticità della Cina, ma insiste sul fatto che la sua traiettoria storica, la struttura del Partito Comunista e la sua cultura politica hanno caratteristiche peculiari che devono essere comprese secondo logiche proprie e non semplicemente misurate con parametri occidentali.
"How States Think" di John J. Mearsheimer e Sebastian Rosato
How States Think. The Rationality of Foreign Policy, scritto da John J. Mearsheimer e Sebastian Rosato, propone una revisione sistematica del concetto di razionalità nella politica estera. Gli autori sostengono che, contrariamente a una diffusa opinione accademica e pubblica, gli Stati agiscono razionalmente nella maggior parte delle circostanze. Il volume si sviluppa a partire da due domande fondamentali: cosa significa essere razionali nella sfera della politica internazionale e se i dati storici confermano l’assunto secondo cui gli Stati si comportano razionalmente. La razionalità, per gli autori, è definita da due criteri: l’uso di teorie credibili per interpretare il mondo e l’adozione di un processo decisionale deliberativo. Il testo contesta l’equazione tra fallimento e irrazionalità, affermando che una decisione può essere razionale anche se non produce l’esito desiderato. La tesi è illustrata attraverso casi storici controversi, come l’invasione russa dell’Ucraina o la gestione americana della crisi dei missili di Cuba. Viene anche criticata l’interpretazione della razionalità come mera massimizzazione dell’utilità attesa, ritenuta inadeguata in un contesto di profonda incertezza informativa. Il libro offre quindi una definizione alternativa di razionalità strategica, basata sull’uso consapevole di teorie realistiche e sulla deliberazione. Si tratta, in conclusione, di una difesa metodologica e teorica della possibilità di comprendere e prevedere il comportamento statale attraverso un modello razionale.
Monitoraggi Globali
Rassegna della stampa tedesca #123
Quello che segue è il Monitoraggio della stampa tedesca, curato dalla redazione di Stroncature, su commissione della Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano. Il monitoraggio ha cadenza settimanale ed è incentrato sui principali temi del dibattito politico, economico e sociale in Germania. Gli articoli sono classificati per temi.
In questo numero, la rassegna mette in evidenza l’avvio travagliato del governo Merz, segnato da tensioni interne alla coalizione CDU-SPD e da critiche sulla gestione dell’immigrazione. L’aggressione russa resta centrale nel dibattito: cresce la pressione per un maggiore sostegno militare all’Ucraina e per una strategia europea unitaria. Sul piano interno, preoccupa la stagnazione economica e l’aumento della spesa pubblica, con timori di deriva verso un’economia pianificata. L’industria della difesa tedesca vive un boom di ordini ma incontra limiti produttivi e burocratici. Infine, emerge l’urgenza di colmare i ritardi strutturali nella digitalizzazione e nelle infrastrutture tecnologiche.
Seminari & Presentazioni
"Scienza chiara, scienza oscura" di Gianfranco Pacchioni
Il prossimo 30 maggio alle 16:00, Stroncature ospiterà la presentazione del libro "Scienza chiara, scienza oscura" di Gianfranco Pacchioni (il Mulino, 2025). Il libro affronta una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la crescente privatizzazione della ricerca scientifica. Se un tempo la scienza era appannaggio delle istituzioni pubbliche e finalizzata al bene comune, oggi l’ingresso massiccio delle Big Tech e il ruolo della ricerca militare stanno trasformando radicalmente lo scenario. Settori come l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, la medicina e l’esplorazione spaziale vedono una crescente egemonia di attori privati, che operano secondo logiche riservate, protette da segretezza e brevetti. Il volume solleva così una questione cruciale: in un contesto in cui parte consistente del sapere viene prodotta a porte chiuse, è ancora possibile affidarsi alla scienza come bene pubblico e strumento trasparente di progresso collettivo? Con l’autore dialogheranno Caterina Visco e Sandro Iannaccone. Per partecipare è necessario registrarsi.